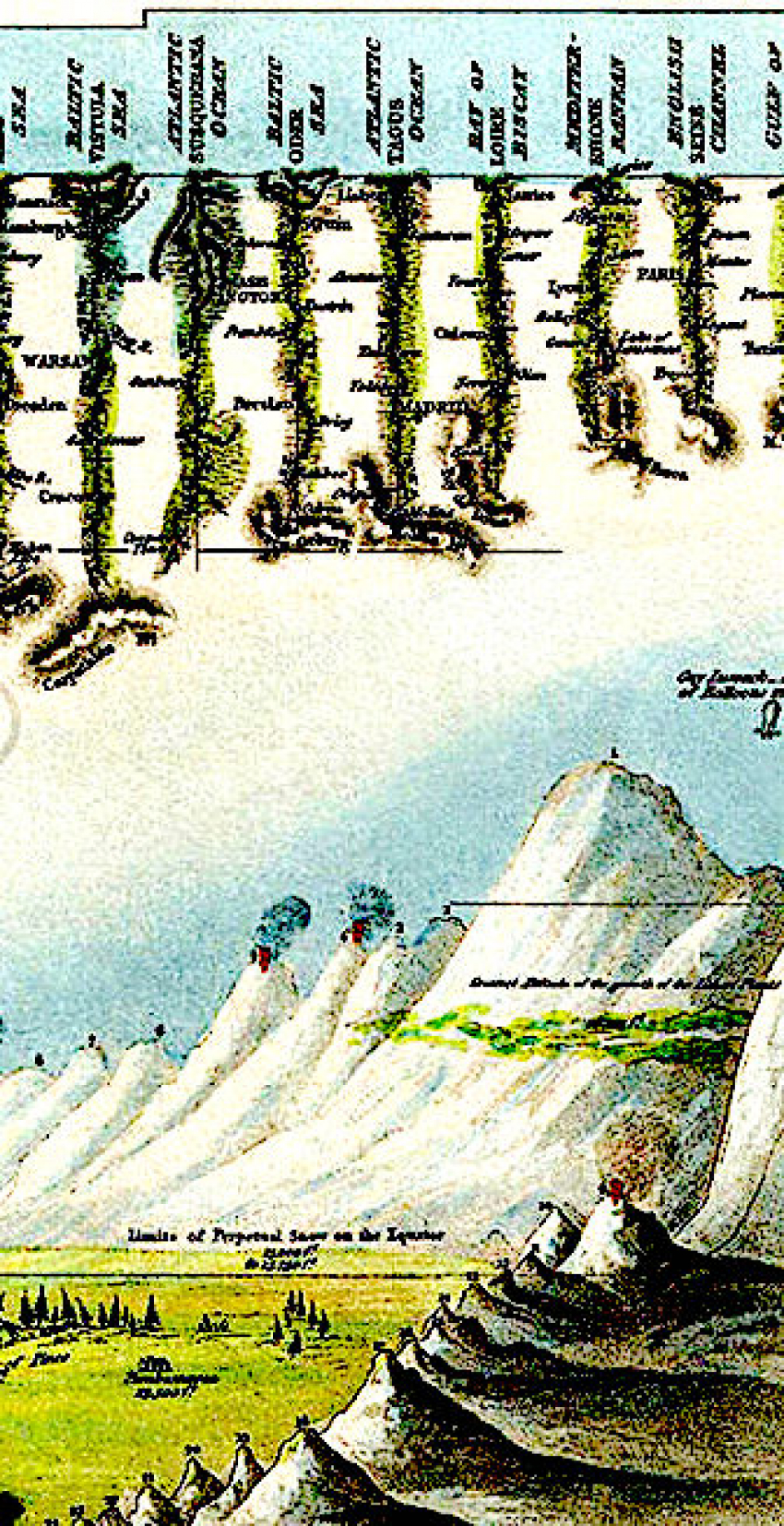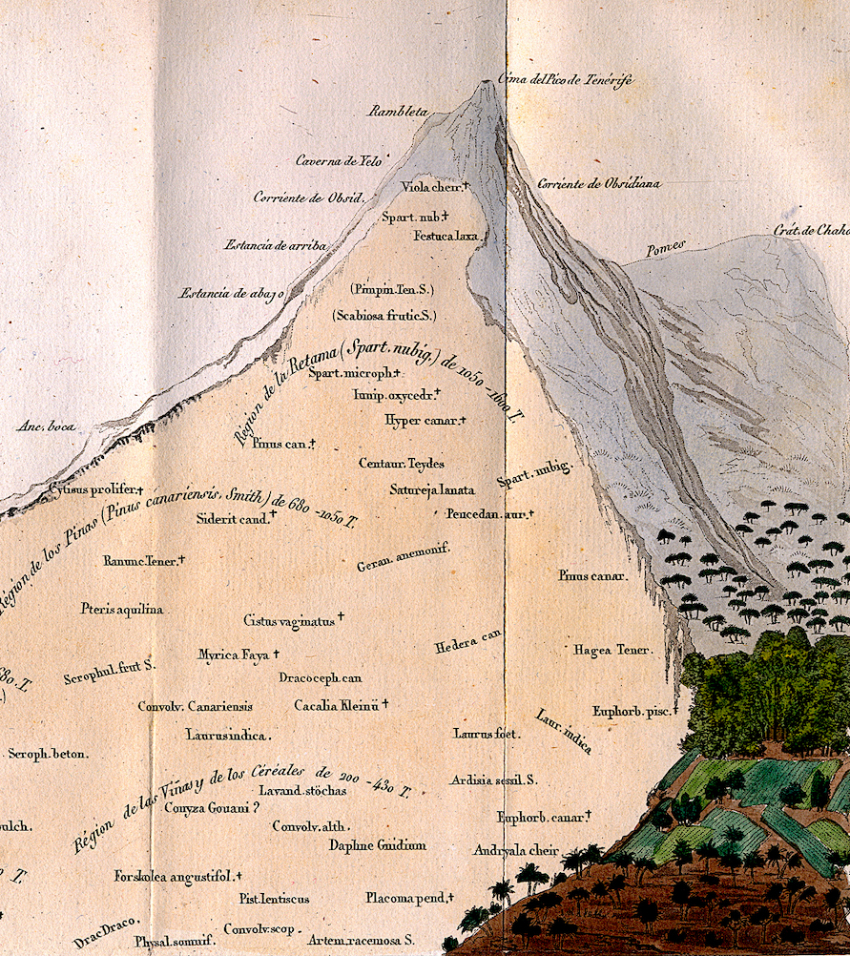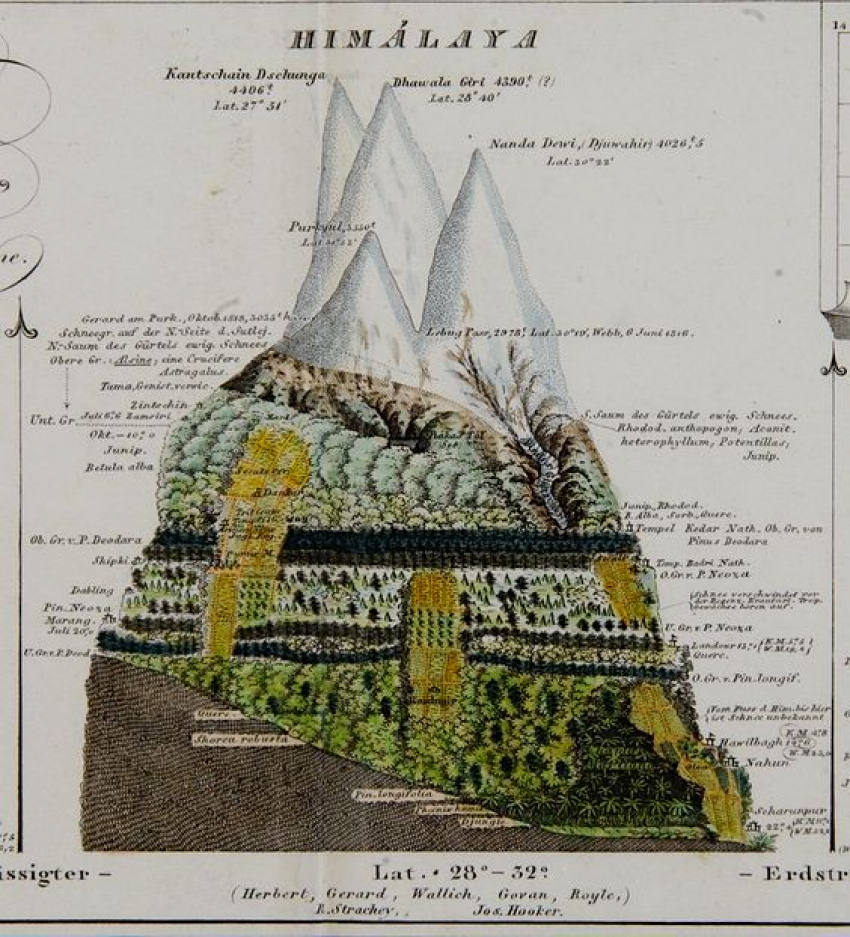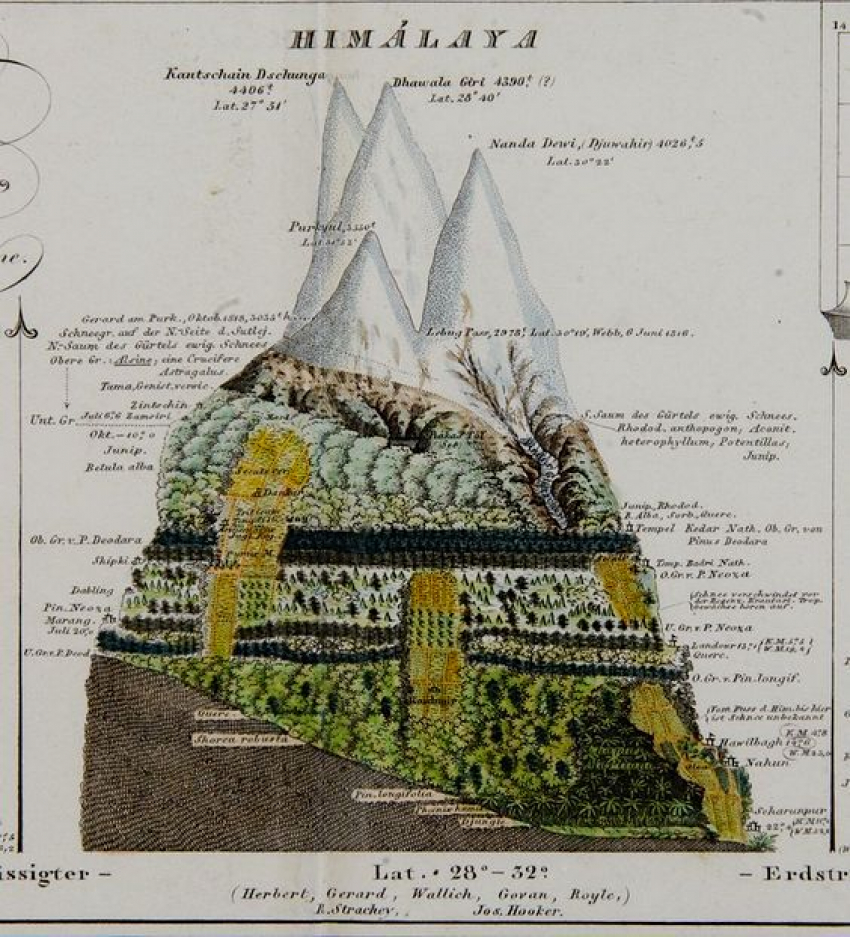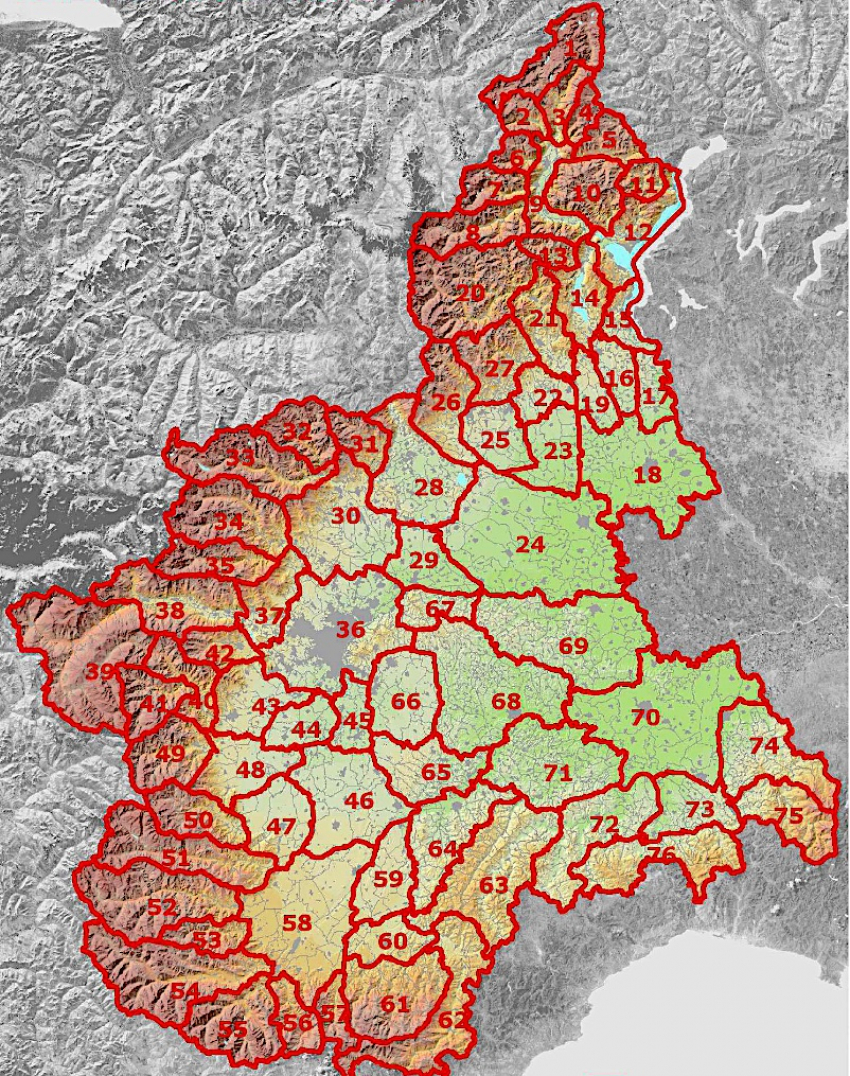Landscapefor Doc: una raccolta ordinata di materiali utili per il paesaggio attivo
-
interpretazioni e studi sui temi teorici di maggior rilievo: la multidisciplinarità.
il rapporto con il tempo, il segno nel paesaggio -
indagini, piani e progetti per conoscere le tecniche e le problematiche
della rappresentazione e dell’intervento utili -
un repertorio di pratiche di gestione e partecipazione del paesaggio attivo
nei contesti naturali, rurali ed urbani -
un catalogo aperto di organizzazioni smart per i servizi territoriali e paesistici
(trasporti, alimentazione, turismo, infanzia, tempo libero)
- 1
- 2
- 3
- 4
SuperLS4
Encomio alla IV edizione del Premio del paesaggio per Atlasfor
Il 14 marzo si è svolta nella sede del Ministero della Cultura a Roma, la consegna del Premio del Paesaggio 2023, alla sua IV edizione.
Nell’ambito della cerimonia, che ha visto premiato il programma “Orti generali” di Torino su oltre 70 concorrenti, l’associazione Landscapefor ha ricevuto un encomio per il lavoro svolto con AtlasFor.
Le motivazioni lette da Luigi LA Rocca, Direttore Generale archeologia, belle arti e paesaggio: “Per la capacità di proporre innovative forme digitali di conoscenza, diffusione didattica del paesaggio e del patrimonio culturale attraverso la creazione di un archivio digitale liberamene fruibile costituito da un atlante on line di tutti i luoghi di interesse culturale, ambientale, paesaggistico, con schede geolocalizzate facilmente utilizzabili da parte di tutti gli operatori”.
Ritirando l’encomio il presidente di LanscaperFor, Paolo Castelnovi ha detto:
“Ringrazio tutti, ma in particolar modo ringrazio quelli che stanno lavorando per il paesaggio. L’idea di fare questo atlante, che è dedicato particolarmente a quello che noi chiamiamo paesaggio attivo ( ciò che siamo tutti noi), è nato proprio qui in occasione di una Giornata del Premio del Paesaggio, quando è stato premiato il caso di Libera che aveva lavorato in Sicilia sui beni sequestrati alle mafie. Da allora ci siamo resi conto che in tutte queste manifestazioni viene alla luce una miniera di attività preziose, di gente impegnata che poi, dopo aver ricevuto il premio, torna a casa propria e rimane isolata. Con questo atlante stiamo cercando di recuperare una rete di questo straordinario movimento che si sta producendo quasi in silenzio”.
Dopo 7 anni di attività l’associazione LandscapeFor vede riconosciuto a livello nazionale il proprio impegno a produrre servizi per valorizzare e sostenere i progetti e le attività di interesse socioculturale che utilizzano il paesaggio come ingrediente fondamentale, integrando in modo sostanziale, ma spesso inosservato, il patrimonio di testimonianze socioculturali che caratterizza in modo sempre differente ogni ambito del nostro paese.
L’encomio identifica questo impagno con AtlasFor, l’atlante online prodotto e gestito dall’associazione che descrive gli elementi di interesse del territorio attraverso immagini, spesso raccontate da chi in quel territorio abita e svolge la propria attività.
AtlasFor Canavese diventa pienamente operativo
AtlasFor Canavese è un dossier speciale di Atlasfor, che nell’area canavesana presenta oltre 100 schede di punti di interesse tra beni e attività, redatte e messe a disposizione del turismo culturale e naturalistico, mobilitando sino ad ora oltre 50 operatori locali tra sindaci, produttori e servizi (vedi la lista allegata).
Si tratta di un work in progress che per ora interessa i beni diffusi, i piccoli centri, le attività di produzione artigianale e di ricettività locali dell’anfiteatro morenico e che si arricchirà nei prossimi mesi, non solo con le nuove adesioni dei Comuni sino ad ora partecipanti, ma anche con Ivrea e i beni olivettiani (per i quali è prevista la stesura di un protocollo di accordo con Comune e Coordinamento del Sito UNESCO).
Atlasfor è una webapp online di accesso libero, che presenta una mappa con schede dei beni e delle attività culturali, basate su immagini storiche o video (che aggiungono conoscenza a ciò che il visitatore può vedere direttamente) con brevi didascalie, destinate al turista curioso che esplora gli aspetti meno noti del territorio. A questa base, con schede del tutto analoghe, gli operatori locali pubblici e privati aggiungono direttamente immagini e segnalazioni per mettere in vetrina le loro iniziative e invitare ad approfondire sul proprio sito web. Ne risulta un racconto ricco e articolato, costruito con la partecipazione attiva degli operatori: una finestra che riassume l’offerta turistica e culturale del territorio in un panorama racconto unitario di beni, attività culturali, ricettività, enogastronomia, artigianato.
Questo esperimento, attivato in circa 6 mesi (con un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo per la fase di impostazione) mostra l'efficienza di uno strumento operativo, sinora applicato solo a città (con circa 500 schede tra Torino, Genova, Este) e che ora sperimentiamo per i territori con beni diffusi per la promozione delle iniziative locali, con una strategia che sta riscuotendo interesse in Regione e al Ministero della cultura.
Mentre il dossier si rimpolpa investendo nuovi territori (Val Chiusella, Canale di Caluso, Cuorgnè etc.) e approfondendo itinerari e schede dei beni, nell'immediato (e gratuitamente per il 2021) gli operatori che lo desiderano possono avere a disposizione:
- una"specchiatura"(cioèlariproduzione)dellapiattaformaAtlasForsullahomepagedeiproprisiti,in modo da offrire immediatamente un’immagine ricca e interattiva della offerta del territorio (che il visitatore può attivare nella modalità «around me»),
- l'inserimento su AtlasFor di ulteriori punti di interesse (a partire ovviamente da schede delle sedi delle attività di ricettività o di servizi o di produzione interessante per il turista);
-
la messa a disposizione delle funzionalità "news", "prenotazioni” e “vetrina attiva”, che si aggiungono ai materiali “fissi” inseriti nella scheda di POI, per segnalare le iniziative temporanee o gli aspetti commerciali (a gestione totalmente autonoma da parte dell’operatore).
Queste predisposizioni possono essere impostate nel giro di pochissimi giorni su richiesta e sono poi implementate dall’operatore stesso successivamente. Ovviamente a monte va verificata con i gestori dei vostri siti web la compatibilità delle vostre piattaforme e del software del nostro atlante, per verificare le procedure per l’inserimento nei siti locali o aziendali della specchiatura di Atlasfor e viceversa l’agibilità da parte degli operatori della gestione dei moduli dedicati (calendari, news, prenotazioni, vetrine attive ecc., vedi presentazione
La presentazione è anche l’occasione per ringraziare chi ha collaborato a questa prima fase di impostazione del dossier, a partire da Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha contribuito allo sforzo iniziale di predisposizione delle schede, al Club per l’UNESCO di Ivrea, ai numerosi Comuni e alle associazioni che ci hanno aiutato sino ad ora e che vorremmo accompagnare in questa faticosa fase di avvio di una rete che durerà nel tempo dando i suoi frutti a lungo.
Landscape Planning: invarianti e criticità
Landscape Planning: invarianti e criticità
Roberto Gambino
in Maria Mautone e Maria Ronza (a cura di), Patrimonio culturale e paesaggio: un approccio di filiera per la progettualità territoriale, Roma, Gangemi editore 2009
Abstract Landscape analysis and planning are assuming a growing relevance in territorial government processes, in relation to the scaling-up of many environmental problems and their complex interference with the social and economic ones.
According to the European Landscape Convention, landscape has to be conceived not only as the result of the interaction between natural and cultural factors, but also as the expression of the diverse common heritages and the foundation of the population’s identities. It requires a new paradigm for landscape policies, that cover the entire territory and invest a wide range of different administration sectors.
Landscape may be considered with diverse scientific approaches, ranging from geography and geomorphology to ecology, economy, history, antropology, semeiology, aesthetics and so on. But we need also a holistic vision, based on a structural interpretation of the territorial context, pointing out the "invariants” to be rispected, as well as the pressures and critical factors threatening them.
The structural interpretation is a crucial step towards the landscape planning, where the special protection granted to the outstanding values must be reconciled with the need for a careful and sustainable management of the entire territory.
La questione del paesaggio: rilevanza e attualità
Il paesaggio ha assunto negli ultimi due o tre decenni una crescente importanza nei processi di gestione e di pianificazione territoriale. La “domanda di paesaggio”, lungi dal ridursi ad una pulsione edonistica schiacciata dai bisogni primari, riflette il tentativo di ridefinire i rapporti dell’uomo con la terra (Berque, 1995). Essa è entrata da tempo nelle rivendicazioni con cui comunità più o meno ampie tentano di difendere o di ricostruire la propria identità. La rivalutazione della estrema diversità del proprio patrimonio paesistico fa parte delle politiche con cui l’Europa È in cerca di se stessa, ma l’identità paesistica È spesso orgogliosamente difesa anche dai paesi emergenti, non senza drammatiche contrapposizioni etniche e culturali. A scala locale, molte piccole comunità “perdenti”, emarginate dallo sviluppo economico e sociale, affidano alle proprie risorse paesistiche e ambientali le residue speranze di sopravvivenza o di rinascita. L’obiettivo della valorizzazione del paesaggio figura quasi ritualmente nelle dichiarazioni e nei programmi strategici con cui le amministrazioni pubbliche ai diversi livelli tentano di disegnare il proprio sviluppo economico e sociale.
D’altra parte, a dispetto di tali programmi e dichiarazioni, la “questione del paesaggio”, in quanto groviglio inestricabile di problemi, di rischi e di minacce che hanno a che fare con il patrimonio paesistico, sembra destinata ad aggravarsi e complessificarsi, stando ai Rapporti ambientali internazionali, che evidenziano congiuntamente:
-
l’incessante salto di scala di molti problemi ambientali, quali quelli connessi al global change, che pongono crescenti difficoltà di controllo, di regolazione e di governo alla scala locale;
-
la crescente interferenza dei problemi ambientali con quelli economici e sociali, quali quelli che concernono la povertà, l’accesso all’acqua ed alle risorse primarie, l’accesso all’informazione e alla cultura.
In questo contesto, il paesaggio gioca un ruolo centrale. Esso lancia un ponte tra natura e cultura, non soltanto perchè storicamente è sempre il risultato storico dell’interazione tra fattori naturali e culturali, ma anche perché (come dice la Convenzione Europea del Paesaggio: CEP, CE 2000) È “una componente essenziale del quadro di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”. Infatti, non esiste paesaggio, per quanto remoto, che possa dirsi esente da ogni influenza antropica (Shama, 1995).
Questa affermazione trova riscontro anche in situazioni di estrema dominanza dei fenomeni naturali, come le grandi vette o i grandi complessi vulcanici (nei quali, come dimostra esemplarmente il caso del Vesuvio, le dinamiche eruttive hanno spesso coabitato per secoli con le attività antropiche). Ma vale anche in assenza di trasformazioni fisiche indotte dall’uomo: è lo sguardo dell’uomo, la sua interpretazione del dato naturale che dà senso e “crea” il paesaggio, inventandolo (come nell’”invenzione delle Alpi” da parte dei grandi viaggiatori del ‘600 e ‘700: Joutard, 1986) o scoprendolo (come nei “paesaggi della scoperta”).
In entrambi i casi la creazione del paesaggio implica una qualche forma di controllo della realtà materiale da parte della cultura umana (Raffestin, 2007). In entrambi i casi lo sguardo dell’uomo lascia il segno. Da questo punto di vista, ci si può chiedere se il concetto di “paesaggio culturale”, che ha richiamato tanta attenzione in questi ultimi anni, regga al confronto col concetto di paesaggio ridefinito dalla Convenzione europea, che attribuisce ad ogni paesaggio un preciso interesse paesistico.
Se il concetto di paesaggio culturale va ricondotto a quello di combined works of nature and of man (Unesco, 1966), può sostanzialmente trovare riscontro in ogni manifestazione paesistica: anche il più celebre “santuario della natura”, il Parco nazionale di Yellowstone, può essere considerato un paesaggio culturale nella misura in cui non solo i suoi caratteri fisici discendono dalle secolari attività, come il “fire management”, delle popolazioni indigene precedenti, ma soprattutto la sua immagine e la sua percezione dipendono crucialmente dai modelli interpretativi che guidano i piani di gestione e l’organizzazione delle modalità di accesso e fruizione. In questo senso ogni paesaggio È un paesaggio culturale, o più precisamente luogo di mediazione culturale.
Lo spostamento concettuale, dai paesaggi culturali al significato culturale di tutti i paesaggi, investe il rapporto tra paesaggio e territorio, ossia la imprescindibile “territorialità” del paesaggio, che lega “visto” e “vissuto”, valori tangibili e intangibili. Nell’esperienza e nel dibattito degli ultimi decenni i paesaggi culturali sono stati prevalentemente pensati in rapporto ai territori in cui si vive e si lavora: paesaggi “viventi” che esprimono peculiari configurazioni agrarie o sistemazioni idrauliche (come i versanti terrazzati per la coltivazione del riso o dei vigneti). Ma spesso si tratta di coltivazioni o produzioni scomparse o in declino, che fanno parlare di territori abbandonati o senescenti, di impianti o di aree industriali dismesse o non più utilizzate, il cui interesse paesistico non nasce dalla coerente rappresentazione delle attuali attività e funzioni, quanto piuttosto dalla memoria o dalla nostalgia di quelle pregresse: un desiderio di paesaggio che nasce dalla nostalgia del territorio (Raffestin, 2007), non senza vagheggiamenti romantici di un passato pre-industriale o pre-moderno.
Le politiche del paesaggio
L’apprezzamento dei valori del paesaggio da parte della società contemporanea si È da tempo tradotto in misure normative, volte a tutelarli. Esse riflettono il riconoscimento di un interesse pubblico del paesaggio, che in talune legislazioni, come quella italiana, assume carattere prioritario, ossia non subordinabile ad alcun altro interesse pubblico o privato. Anche se l’assimilazione del paesaggio ai “beni pubblici” È contestata (in particolare a causa del fatto che, a differenza dei beni pubblici “puri”, i beni paesaggistici non possono spesso essere goduti da alcuni senza limitarne il godimento da parte di altri), vi largo consenso nell’attribuirgli il ruolo di risorsa comune, meritevole di adeguata protezione.
Come per tutti o gran parte dei beni culturali, le ragioni della tutela affondano le loro radici in complessi coacervi di percezioni e consapevolezze, concezioni e valutazioni, atteggiamenti culturali ed etici, assai diversi nei diversi paesi e nelle diverse culture. Inoltre, come È stato osservato (Brennan e Buchanan, 1985), le “ragioni delle regole” variano nel tempo, in funzione dei cambiamenti complessivi della società, delle sue paure e delle sue speranze. Ma, anche se si può discutere la possibilità di equiparazione del paesaggio, come degli altri beni culturali, ai beni pubblici (Kling, 1993) o ai beni “misti” (Lichfield, 1988; Samuelson 1958; Ventura 2001), vi È ampio consenso sull’esigenza di intervento pubblico nei processi di trasformazione che possono minacciarne l’integrità, la qualità e la fruibilità. Tuttavia le politiche del paesaggio negli ultimi decenni hanno preso strade diverse.
Tre paradigmi sembrano particolarmente riconoscibili.
Il primo paradigma È quello implicito nella Convenzione Unesco del 1972, che ruota attorno al concetto di outstanding universal value, sistematicamente richiamato nell’art.1 (per le cultural properties) e nell’art.2 (per le natural properties) e fa riferimento a beni o siti di intrinseca eccezionale rilevanza, autenticità, integrità, in quanto tali distinguibili o separabili dal contesto, chiamati a rappresentare e celebrare una eredità che appartiene all’umanità intera, senza vincoli di identità nei confronti delle comunità locali. L’opzione conservativa sovrasta ogni altra opzione e la politica pubblica mira essenzialmente a salvaguardarne i valori indiscutibili » importante notare che i siti che hanno meritato finora il riconoscimento nel Patrimonio Mondiale sono attualmente in tutto il mondo meno di un migliaio e prevalentemente di piccole dimensioni.
Il secondo paradigma, affermato nel campo della conservazione della natura dall’Unione Mondiale della Natura (IUCN, 1994) ruota attorno al concetto di “paesaggio protetto”, una delle 6 categorie delle “aree naturali protette”. Secondo la definizione del 1994, i Protected landscapes/seascapes della Cat.V sono quelli “in cui l’interazione tra uomo e natura nel corso del tempo ha prodotto un’area di carattere distintivo con significativi valori ecologici, biologici, culturali e scenici”. Anche in questo caso si fa riferimento ad aree di specifico, intrinseco e significativo interesse, la cui integrità merita una protezione speciale. Ma a differenza dei Siti del Patrimonio Mondiale, i “paesaggi protetti” sono aree riconosciute e gestite per la long term conservation of nature strettamente connessa alla difesa della biodiversità. Va notato che i “paesaggi protetti” coprono ormai una quota importante della superficie complessiva delle terre emerse: in Europa, essi coprono più della metà della superficie protetta complessiva. Ed ancora, va rilevato che la logica “insulare” che ha guidato finora le politiche delle aree protette (pensate come aree in qualche modo set aside e fra loro staccate) lascia ora emergere “nuovi paradigmi” (IUCN, 2003) fondati sul networking e sulla interconnessione.
Il terzo paradigma È quello propugnato dalla European Landscape Convention (Consiglio d’Europa, 2000), che ruota attorno al concetto di “paesaggio”, ridefinito come si È sopra citato. Tale ridefinizione, che ha raccolto gli esiti di lunghi dibattiti e riflessioni, propone un approccio esplicitamente “territorialista”, mettendo in risalto la valenza paesaggistica dell’intero territorio inclusi i paesaggi dell’ordinarietà o persino degradati, il significato complesso e pervasivo dei valori paesistici, e il necessario riferimento alle percezioni, alle attese e alla responsabilità gestionale delle popolazioni direttamente interessate.
In questa visione, il focus non È sulle “isole” di pregio, sulle “eccellenze” e le aree di valore eccezionale, ma sul patrimonio paesistico diffuso, parte integrante del “capitale territoriale”. La sua conservazione attiva È inseparabile dalla valorizzazione del territorio e delle identità locali.
Il primo paradigma risponde all’esigenza di reagire all’”arretramento dell’universalismo di fronte al particolarismo pulviscolare delle comunità” (Touraine, 2008), anche con la riaffermazione del ruolo fondativo dell’eredità comune. Questo vale anche per il secondo, che tuttavia risponde più direttamente alla domanda crescente di natura e di qualità ambientale e ai timori determinati dagli attuali processi di degrado. Quanto al terzo paradigma, se da un lato l’enfasi sui valori identitari, spesso drammaticamente contrapposti (le “identità armate”: Remotti, 1996) non È certo esente da conflitti e contraddizioni, dall’altro esso sembra riflettere l’affermazione di nuovi diritti di cittadinanza, come quelli che riguardano la qualità e la bellezza dell’ambiente di vita. Conoscenza e valutazione del paesaggio
Le nuove concezioni del paesaggio mettono in discussione gli statuti disciplinari, i metodi e gli apparati interpretativi che, a partire almeno da von Humboldt a metà Ottocento, hanno approfondito il tema del paesaggio. La discussione riguarda soprattutto due esigenze:
-
l’esigenza di aderire alla complessità intrinseca della fenomenologia paesistica col pluralismo dei contributi specialistici disciplinari,
-
l’esigenza di produrre visioni e interpretazioni olistiche ed il più possibile integrate, atte ad informare l’azione pubblica di regolazione.
Per quanto riguarda la prima esigenza, occorre dalla constatazione che le diverse discipline e le diverse scuole di pensiero offrono spesso visioni parziali e riduttive, o comunque difficilmente confrontabili. Ma È innegabile il ruolo egemone assunto, soprattutto a partire dagli anni Sessanta o Settanta, dalla Landscape Ecology, nel cui ambito confluiscono anche le tradizioni nordamericane del landscape planning (Steiner et al., 1988). Alla base del successo della Landscape Ecology vi è certamente il fatto che essa ha offerto un quadro teorico organico e sistematico, capace di “spiegare” in ampia misura, con l’analisi scientifica oggettiva, la fenomenologia paesistica. La fede nelle scienze esatte, che aveva consentito a McHarg (1966) di propugnare polemicamente l’ecological determinism contro gli orientamenti economicisti del planning, si È dimostrata vincente nei decenni successivi contro il confuso impressionismo degli approcci estetizzanti, il descrittivismo di certi approcci geografici o l’arbitrarietà progettuale della landscape architecture.
Di più, l’orientamento ecologico ha sottolineato con forza l’esigenza di non staccare i paesaggi dal paese reale, i testi paesistici dal loro contesto ambientale. Ma la visione sistemica offerta dalla Landscape Ecology, nonostante si presenti come un paradigma totalizzante (l’ecologia come quadro globale di riferimento) lascia nell’ombra alcune dimensioni del paesaggio, la cui importanza È emersa con forza soprattutto negli ultimi decenni.
Il dibattito e la ricerca degli anni Ottanta e Novanta hanno richiamato l’attenzione sulla dimensione economico-sociale. Quest’attenzione non È di per sÈ in contrasto col quadro teorico della Landscape Ecology, (“nessun ecosistema potrà essere studiato senza fare riferimento all’uomo”, per McHarg, 1981; d’altra parte non ci sono ecosistemi che non risultino almeno in parte modificati dalla cultura umana, per Schama, 1995).
Il terreno da esplorare È quello che riguarda quell’intreccio complesso di interazioni tra le dinamiche economiche e sociali ed i processi di trasformazione paesistica, che costituiscono lo “zoccolo duro” della questione paesistica. Un intreccio che investe le dinamiche globali (IUCN, 2003, 2004) ma che si presenta in forme ancor più acute nelle dinamiche locali: come difendere i paesaggi terrazzati della risicoltura e della viticoltura senza quelle attività? come salvaguardare la diversità paesistica delle Alpi e degli Appennini senza mantenere e rinnovare le attività agricole e pastorali?
Sembra impossibile una tutela paesistica minimamente efficace se non si riporta al centro il ruolo dell’uomo in quanto “produttore” di paesaggio e non si affronta la separazione storicamente intervenuta tra il “produttore” e l’”abitante”. Le riflessioni (Magnaghi, 1990) sul “territorio degli abitanti” indicano come - a quali condizioni, con quali processi - il paesaggio possa costituire una risorsa effettivamente insostituibile per lo sviluppo locale endogeno ed auto-centrato. Se la tutela e il progetto di paesaggio si pongono a rimorchio dei correnti modelli economici e produttivi e delle loro tendenze evolutive, c’È invece il rischio che si riducano ad un’azione “cosmetica” (il landscaping, figlio “bastardo” dell’architettura del paesaggio), concorrendo in fondo al consolidamento di quegli stessi modelli e di quelle stesse tendenze.
Un’altra dimensione del paesaggio di cui si avverte la crescente importanza riguarda gli aspetti storici e culturali. Anche questi non comportano, in linea di principio, ragioni di contrasto con la teoria e la ricerca ecologica, che hanno da tempo posto in risalto quanto la struttura e il funzionamento degli ecosistemi dipendano dalle vicende pregresse; d’altra parte la stessa prospettiva ecologica, nel pensiero di studiosi come Bateson o Lorenz, si dilata ad abbracciare anche i processi culturali.
Il contributo della storia e della geografia storica si È rivelato per contro fondamentale soprattutto nei paesi europei, i cui paesaggi sono direttamente fondati sulla storia abitativa e su processi complessi di acculturazione (“memorie in cui si registra e sintetizza la storia dei disegni territoriali degli uomini”, come diceva il Sereni, 1961), indipendentemente dal fatto che l’uomo sia tuttora presente.
Lo scavo dei palinsesti territoriali coi metodi dell’archeologia del paesaggio (Sereno, 1983) consente di portare alla luce i tratti profondi, le geometrie latenti, le regole trasformative dei testi paesistici, mentre la prospettiva storica illumina i processi soggiacenti, quel che non si vede e che È spesso più importante di ciò che È immediatamente afferrabile con lo sguardo (Gambi, 1961).
I contributi dell’antropologia culturale, della sociologia ambientale e della geografia umanistica, che implicano “il definitivo superamento, nella cultura europea, della tradizionale contrapposizione tra mito e logos” (Quaini,1992), si ricollegano peraltro al pensiero fondativo del paesaggio geografico. Questo ci accosta ad un’altra dimensione del paesaggio, quella semiotica ed estetica, che, del tutto assente dall’analisi ecologica, È forse quella su cui si È registrato negli ultimi anni un più vivace risveglio d’interesse. Se si riconosce il ruolo culturale del paesaggio - di ogni paesaggio, indipendentemente dalla qualità dei suoi contenuti culturali - È perchÈ lo si considera come un processo di significazione (Barthes, 1985) e, quindi, come un fenomeno di comunicazione sociale (Eco, 1975).
Di per sÈ , il riconoscimento della funzione estetica del paesaggio non È certo una novità. Il paesaggio occupa infatti un posto di rilievo nella storia dell’arte (Clarck, 1976) e persino le sue descrizioni più primitive, come i graffiti preistorici, sono state interpretate come espressioni artistiche ed insostituibili testimonianze “culturali” (Jellicoe, 1987). In particolare in Italia la tradizionale attenzione per gli aspetti estetici del paesaggio ha trovato riscontro nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Ed anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, soprattutto a partire dagli anni Settanta, l’interesse per i valori estetici del paesaggio (o più precisamente per quelli “scenici” o visivi) ha stimolato una vasta produzione di piani e di ricerche.
Ma l’interpretazione semiologica del paesaggio pretende molto di più. Se infatti si riconosce il duplice fondamento - naturale e culturale - dell’esperienza paesistica, occorre anche riconoscere che il sistema segnico costituito dalla sostanza sensibile del paesaggio non può in alcun modo tradursi in un insieme “dato” di significati: la semiosi paesistica È un processo sempre aperto (Dematteis, 1998). La dinamica delle cose -l’ecosfera -È inseparabile dalla dinamica dei significati -la semiosfera - e quindi dai processi sociali in cui questa si produce (Dematteis, 1998). Ma, se questo È vero, allora il paesaggio non può essere quello, cognitivamente perfetto (Socco, 1998), che forma oggetto delle scienze della terra. Esso È spazio di semiosi aperta, non racchiudibile nelle semiosi scientifiche delle varie discipline. » in questa dinamica apertura che si collocano e debbono essere indagate le sue funzioni simboliche e metaforiche, i suoi depositi mitici e memoriali, le sue funzioni narrative e le sue funzioni propriamente estetiche.
CosÏ, se il paesaggio È teatro (Turri, 1997), non È tuttavia un teatro “dato”, con le sue scene fisse e i suoi fondali immobili, dove soltanto gli attori e gli spettatori possono cambiare; l’autorappresentazione, che consente agli attori locali di “prendere le distanze” dalle vicende rappresentate diventando spettatori di se stessi, ricostruisce continuamente il teatro stesso o almeno il significato che esso assume per chi partecipa in vario modo all’azione teatrale.
Il paesaggio come chiave interpretativa
Le considerazioni di cui sopra dimostrano che il paesaggio non può essere adeguatamente compreso all’interno di un solo ambito disciplinare, pena il rischio del riduttivismo: “vedere gli alberi e perdere di vista il bosco” (Tricart e Kilian,1985). Ma una adeguata considerazione delle diverse dimensioni del paesaggio, quale quella sollecitata dalla CEP, non può trovare riscontro nel semplice allargamento del ventaglio di discipline coinvolte dalla questione paesistica. Non si tratta tanto di considerare qualche aspetto in più, ma di ripensare l’intera questione paesistica in termini più complessi. » in questa direzione che assume interesse l’interpretazione del paesaggio, passaggio cruciale tra la ricognizione e il progetto di paesaggio. Si tratta di un’interpretazione tendenzialmente olistica, che non può nascere dal semplice accostamento delle molteplici letture disciplinari, ma richiede che esse interagiscano confrontandosi e fecondandosi a vicenda.
Un quadro interpretativo unitario, in cui confluiscano le diverse letture specialistiche, volto ad evidenziare i fattori e i caratteri di base, relativamente stabili, permanenti o di lunga durata, destinati a guidare le politiche di tutela, di gestione e di pianificazione, assumendo valore condizionante nei confronti dei processi di trasformazione. Tali fattori - che in varie esperienze e legislazioni sono evocate col termine di invarianti strutturali - esprimono in sostanza le “regole costitutive” da cui nessuna scelta di piano può prescindere e rappresentano la parte meno negoziabile delle scelte di piano.
Per miglior comprensione essi possono essere inquadrati nella seguente articolazione:
A fattori strutturanti
B fattori caratterizzanti;
C fattori qualificanti;
D fattori di criticità o di degrado.
I fattori cosÏ definiti possono essere incrociati coi diversi profili di analisi specialistica del territorio in esame: profili che naturalmente possono essere diversi nelle diverse situazioni, in funzione della varia rilevanza che ogni problematica settoriale può assumere in ciascuna situazione.
Quali ad es.:
1. aspetti fisici (geologici, geomorfologici, climatici, idrogeologici, pedologiciÖ);
2. aspetti biologici (flora e vegetazione, fauna, ecologia, attività agroforestaliÖ);
3. aspetti storico-culturali (storia e geografia del territorio, matrici storiche, patrimonio culturale..);
4. aspetti insediativi e infrastrutturali (urbanistica e organizzazione del territorio, sistemi e morfologie insediative, infrastruttureÖ);
5. aspetti paesistico-percettivi (apparati percettivi e sistemi segnici, sistemi di relazioni visiveÖ). L’interpretazione strutturale del territorio È un passo importante verso l’identificazione dei paesaggi, opportunamente prevista dalla Convenzione Europea del Paesaggio. A questo riguardo, notevole rilievo possono assumere le Unità di paesaggio (UP) oggetto negli ultimi decenni di una vasta gam ma di programmi di ricerca assai diversificati. La loro utilità consiste nel proporre una articolazione del territorio che colga forme significative di caratterizzazione, coesione o solidarietà paesistica (idrogeomorfologiche, ambientali, storico-culturali, insediative, paesistico-percettive, visive, ecc.).
Il concetto di unità di paesaggio (UP) può essere utilmente accostato a quello di “unità ambientale” (EU).
Il concetto di Environment Unit (EU), elaborato negli ultimi decenni, nel quadro della Landscape Ecology, come strumento di una rappresentazione olistica del paesaggio, che tende ad individuare porzioni significative di territorio, organizzate “unitariamente” in un determinato e preciso livello spazio-temporale (Zonneveld, 1989).
Queste articolazioni possono poi essere confrontate con quelle che colgono gli aspetti economici e sociali dell’organizzazione del territorio (come i “sistemi locali territoriali”, SLOT: Dematteis, Governa, 2005), nonchÈ con l’articolazione istituzionale-amministrativa del territorio (Regioni, Province, Comuni, od altre), nella quale si sviluppano i processi di regolazione pubblica delle dinamiche territoriali ed ambientali. E’ importante notare che tutte queste articolazioni, a parte l’ultima, appaiono, di per sÈ , fondate su differenti categorie analitico-interpretative, consolidate nell’ambito dei diversi statuti disciplinari; e, perciÚ, mutuamente irriducibili. Il loro confronto non può quindi tendere ad una improponibile “collimazione”; ma deve piuttosto tendere a porre in evidenza le diverse solidarietà che si manifestano nel territorio (e che possono talora tradursi in vere e proprie “indivisibilità” quali quelle da tempo frequentate dall’analisi economica) e che configurano i diversi “tessuti relazionali”. » questa una condizione essenziale per dare senso concreto a quella “territorializzazione” delle politiche di tutela paesistica-ambientale che caratterizza sia i “nuovi paradigmi” per la conservazione della natura, che la concezione di fondo espressa dalla CEP.
Non È infatti un caso che l’innovazione forse più importante introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 sulla scia della CEP riguardi proprio l’articolazione della pianificazione paesaggistica per Ambiti di paesaggio, a ciascuno dei quali vanno associati obiettivi specifici di “qualità paesaggistica”. Questa articolazione consente di spostare decisamente l’attenzione dai “beni paesaggistici” - sui quali si È tradizionalmente incentrata l’azione di tutela - ai diversi contesti paesistici che prendono forma nel territorio complessivo.
L’interpretazione strutturale del territorio offre un potente contributo alla valutazione dei paesaggi, altro passaggio cruciale verso il progetto di paesaggio. Più precisamente, essa, con l’identificazione delle UP, consente di procedere alla “caratterizzazione” paesistica dei siti, che comporta la evidenziazione:
-
dei valori da tutelare e delle poste in gioco;
-
dei rischi, delle minacce e delle pressioni incombenti;
-
delle relazioni col contesto territoriale;
-
dei soggetti e degli interessi coinvolti.
Ma È opportuno notare che, nella prospettiva delineata dalla CEP, lo scopo non È tanto (o soltanto) quello di orientare la disciplina delle forme di tutela, quanto più ampiamente quello di orientare l’attivazione degli “strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi”, in funzione “degli obiettivi di qualità paesaggistica” stabiliti, “tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate” (art.6).
Il riconoscimento da parte dei vari soggetti di fattori o componenti che svolgono ruoli diversi nel modellare i paesaggi e nel definirne le qualità e i rischi, rappresenta un contributo insostituibile al confronto “argomentato” delle rispettive scelte di tutela e di governo. La possibilità di un confronto argomentato delle interpretazioni e delle valutazioni È alla base di ogni strategia autenticamente cooperativa.
Nella prospettiva delineata dalla CEP, tali interpretazioni rappresentano inoltre uno strumento importante per collegare la conoscenza scientifica a quella diffusa od ordinaria e per recuperare le “sapienze ambientali” locali, quali quelle riflesse nelle “buone pratiche” tradizionali. Nonostante gli sforzi degli esperti per ancorare le loro valutazioni ad analisi storiche o scientifiche relativamente stabili e il più possibile sottratte all’arbitrarietà ed all’impressionismo dell’osservatore, non c’è dubbio che la determinazione dei valori È sempre lontana dal potersi esprimere in termini univoci ed assoluti, è sempre immersa in processi socioculturali più o meno complessi e dagli esiti incerti.
La costruzione di nuove interpretazioni (e dunque di nuove immagini) paesistiche, soprattutto in presenza di paesaggi gravemente alterati o degradati che richiedono interventi creativi di riqualificazione, non può infatti configurarsi come materia esclusiva per esperti, poichÈ richiede invece processi aperti di apprendimento collettivo e di progettualità sociale.
Il progetto di paesaggio
L’interpretazione strutturale e l’identificazione dei paesaggi sono un ponte che collega la fase ricognitiva alle opzioni di fondo che guidano, anche in assenza di esplicite “deliberazioni”, le politiche di protezione e d’intervento. Il riconoscimento dei fattori “invarianti” e delle solidarietà che definiscono le UP, il modo stesso di “guardare” il paesaggio, presuppongono sempre una più o meno tacita intenzione di tutela o valorizzazione.
La progettualità del paesaggio si manifesta anche per quei paesaggi che, in ragione della loro rilevanza e della loro integrità, sembrano doversi sottrarre ad ogni dinamica trasformativa, per essere conservati rigorosamente allo stato attuale. Questa osservazione conduce ad interrogarsi sul significato che può essere oggi attribuito alla conservazione. Sul piano della prassi prima ancora che dei principi, il contenuto delle azioni conservative È progressivamente cambiato negli ultimi decenni, sia nel campo della conservazione della natura che nel campo della conservazione del patrimonio culturale (Gambino, 1997).
Sia nell’uno che nell’altro campo, È apparso sempre più chiaro che una efficace conservazione dei valori non può essere assicurata con mere misure di inibizione, di limitazione o di divieto (anche se tali misure sono spesso assolutamente indispensabili), ma richiede azioni positive di gestione e innovazione, volte, a seconda dei casi, a rimuovere i fattori di rischio o di degrado, ad attivare processi di risanamento o riqualificazione, a superare le criticità in atto. I “nuovi paradigmi” per la conservazione della biodiversità (IUCN, 2003 e 2004) declinano le azioni conservative in forme assai diversificate. Analogamente la Convenzione del 2000 prefigura politiche del paesaggio mirate non solo alla protezione ma anche alla gestione e alla pianificazione Più in generale, le riflessioni e le esperienze degli ultimi decenni per il patrimonio culturale hanno ribadito l’affermazione della Carta di Gubbio (ANCSA, 1990) secondo la quale non può esservi autentica conservazione senza la produzione di nuovi valori, ed anzi la conservazione ‘, per la società contemporanea, “il luogo privilegiato dell’innovazione”.
In questo contesto dinamico, la pianificazione paesaggistica È costretta a ridefinire le sue missioni. Crescono l’importanza e la complessità della missione conoscitiva e valutativa, volta a consentire a tutti i soggetti interessati di prendere coscienza dei valori e delle poste in gioco, dei rischi e delle minacce incombenti, delle opportunità e delle potenzialità, delle risorse mobilitabili, dei soggetti e degli interessi toccati. Cambia la missione regolativa, volta a definire vincoli, limitazioni, misure specifiche di disciplina e di governo dei processi di trasformazione territoriale, in funzione degli obiettivi assunti. Tale missione deve sempre più svolgersi in un orizzonte istituzionale e normativo in radicale mutamento, caratterizzato dalla complessificazione dei processi decisionali, dal crescere delle istanze cooperative e delle esigenze di flessibilità delle azioni di governo.
Cresce la rilevanza politica della missione di orientamento strategico, volta a proporre visioni, idee-guida e linee strategiche, da discutere e condividere con una pluralità di soggetti, istituzioni e stakeholders, a vario titolo interessati e dotati di relativa autonomia decisionale, al fine di promuovere politiche coordinate o convergenti. Ciò mette inevitabilmente in discussione le logiche e i contenuti della pianificazione.
Un primo punto problematico riguarda il processo di pianificazione, in rapporto ai soggetti che vi intervengono e al campo d’attenzione.» evidente che questo deve opportunamente allargarsi, sia in termini spaziali, sia in termini di contenuti disciplinari. Il campo d’attenzione si sposta infatti dai singoli oggetti o dalle singole risorse naturali e culturali ai sistemi di relazioni, ai contesti e alle reti in cui esse si situano: È precisamente il “metterle in rete” e “metterle in scena” che costruisce o modifica il paesaggio. Ciò vale per gli aspetti ecologici (basti pensare all’importanza crescente delle reti ecologiche di interconnessione) ma anche per quelli storico-culturali e per quelli scenici e percettivi. A questo allargamento del campo d’attenzione corrisponde necessariamente l’allargamento della platea di soggetti coinvolti, almeno potenzialmente, nel processo di pianificazione. Cade la possibilità di individuare un unico referente istituzionale e si impone un approccio pluralistico, in cui soggetti diversi, che operano a scale diverse, in settori diversi e con diverse competenze, responsabilità e capacità decisionali, sono chiamati a confrontarsi e collaborare. Questa tendenza implica esigenze di flessibilità e reversibilità delle scelte non certo facili da conciliare con le esigenze di efficacia regolativa, che scaturiscono dalla inviolabilità dei valori ambientali, paesistici e culturali e dal ruolo primaziale che, nel nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si attribuisce alla pianificazione paesaggistica.
Un secondo nodo problematico riguarda la sua integrazione nell’insieme delle attività di governo del territorio. Il riconoscimento della “territorialità” del paesaggio rende ragione dell’esigenza (espressa dalla CEP, art.5), di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonchÈ nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”. Ciò implica un confronto continuo con un insieme assai vasto di piani e programmi, allo scopo di coordinarne o armonizzarne le scelte, sulla base di una valutazione comparativa degli interessi in gioco. La valutazione deve consentire di perseguire la “risoluzione negoziale” dei conflitti, che può, in linea di principio, dar luogo ad esiti di comune soddisfazione, in presenza di giochi a somma positiva. Ma l’esperienza insegna che molto spesso gli interessi pubblici alla conservazione del patrimonio paesistico e culturale sono difficili da conciliare con quelli, pubblici o privati, volti a favorire lo sviluppo economico e produttivo; in questi casi occorre riconoscere il primato dei primi rispetto ai secondi, come già esplicitamente prevede la nostra Costituzione. In questa direzione, l’interpretazione strutturale del territorio (con l’individuazione delle “invarianti”) può offrire un supporto prezioso.
Un terzo nodo problematico concerne la governance dei processi di trasformazione territoriale suscettibili di incidere sul paesaggio. La pianificazione paesaggistica può svolgere un ruolo rilevante. Essa può anzitutto favorire, mediante la produzione e l’accumulo di conoscenza “esperta” e la sua interazione con quella “diffusa”, a tutti i livelli, la crescita della sensibilità e del senso di responsabilità nei confronti del patrimonio paesistico e delle sue modificazioni attese o temute. Mediante la costruzione di una organica interpretazione del territorio e delle sue espressioni paesistiche e di un quadro strategico di riferimento, può concorrere alla diffusione di “nuove idee” e nuove visioni dei paesaggi interessati e stimolare azioni positive e convergenti di valorizzazione e di tutela. Mediante le misure di disciplina e gli indirizzi d’intervento, può concorrere a modificare i comportamenti lesivi del paesaggio, favorire le best practices, innovare le pratiche gestionali e i modelli di sviluppo.
Ma, affinchÈ tutto ciò si realizzi, occorre anzitutto che i sistemi di governance multilaterale trovino spazi e procedure adeguate di pubblica consultazione e di effettivo coinvolgimento e partecipazione nei processi di pianificazione, a partire dalle percezioni e dalle attese delle comunità locali e dalle loro attribuzioni di valore, fino alle scelte di gestione e di intervento proposte dal piano. In un processo democratico di decisione, il confronto degli interessi e delle attese È confronto aperto e trasparente di valori, compresi quelli identitari, di cui il paesaggio È fondamento. Ma perchÈ il confronto non si riduca allo scontro tra valori assoluti e identità esclusive e inconciliabili (“la tirannia dei valori”: Zagrebelsky, 2008) occorre che essi trovino il loro limite nei diritti e la loro ispirazione ultima nei grandi principi universali.
Bibliografia
ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storico Artistici), Un contributo italiano alla riqualificazione della città esistente, Gubbio, 1990.
G. Bateson, (1972), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1993.
R. Barthes, (1966), Elementi di semiologia. Linguistica e scienze della significazione, Einaudi, Torino 1983. R. Barthes, (1985), L’avventura semiologica, Einaudi, Torino 1991.
A. Berque, L’ecumene, in ´Spazio e societàª, n. 64, 1993.
A, Berque, Les raisons du paysage, Hazan, p. 39, 1995.
G. Bertrand, La science du paysage: une science diagonale, in ´Revue GÈ ographique des PyrÈ nÈ es et du Sud-Ouestª, 43, 2, pp. 127-33, 1972.
G. Brennan, J.M.Buchanan, The Reason of Rules, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
CE (Council of Europe), European Landscape Convention, Florence, 2000.
K. Clarck, (1976), Il paesaggio dell’arte, Garzanti, Milano 1985.
D. Cosgrove, (1984), Realtà sociali e paesaggio simbolico (a cura di C. Copeta), Unicopli, Milano 1990.
G. Dematteis, Progetto implicito, F. Angeli, Milano, 1995.
G. Dematteis, Il senso comune del paesaggio come risorsa progettuale, Seminario Il senso del paesaggio, ISSU, Torino, 1998.
G. Dematteis, F. Governa (a cura), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLOT, F. Angeli, Milano, 2005.
U. Eco, Trattato di semiotica generale. Bompiani, Milano, 1975.
L. Gambi, Critica ai concetti geografici di paesaggio umano, Lega, Faenza, 1961.
R. Gambino, Conservare innovare: paesaggio, ambiente, territorio. 0Utet, Torino, 1997.
IUCN (The World Conservation Union), The Protected Areas Management Categories. Guidelines, 1994. IUCN (The World Conservation Union), World Park Congress, “Benefits beyond Boundaries”,2003.
IUCN (The World Conservation Union), World Conservation Congress, “People and Nature, only one World”, Bangkok, 2004.
G. Jellicoe, S. Jellicoe, The Landscape of Man, Thames and Hudson, London, 1987.
P. Joutard, L’invenzione del Monte Bianco. Einaudi, Torino, 1986.
Magnaghi, Il territorio dell’abitare, F. Angeli, Milano, 1990.
J. McHarg, Ecological Determinism, in F.F.Darling, J.P.Milton, Future Environments of North America, The National History Press, Garden City, New York, 1966.
J. McHarg, Human Ecological Planning at Pennsylvania, Landscape Planning, 8, 1981.
M. Quaini, Alexander von Humboldt, cartografo e mitografo, in A. von Humboldt, op. cit, 1992.
Raffestin, De la domestication à la simulation du paysage, Seminario Il senso del paesaggio, ISSU, Torino, 1998.
Raffestin, Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per una teoria del paesaggio. Alinea, Firenze, 2005.
F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Bari-Roma, p. 65, 1996.
S. Schama, (1995), Paesaggio e memoria, Mondadori, Milano 1997.
Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, 1961.
P. Sereno, Il paesaggio, La Nuova Italia, Roma, 1983.
Socco, Il paesaggio imperfetto. Uno sguardo semiotico sul punto di vista estetico, Tirrenia Stampatori, Torino, 1998.
Steiner, Costruire il paesaggio: un approccio ecologico alla pianificazione del territorio, McGraw Hill Italia, Milano, 1994.
Steiner, G. Young, E. Zube, Ecological planning: retrospect and prospect, ´Landscape Journalª, 7/1, pp. 31-39, 1988.
Touraine, Ecco come muoiono i nostri valori universali, intervista ´La repubblica ª, 22/2/2008.
J. Tricart, J. Kilian, L’ecogeografia e la pianificazione dell’ambiente naturale, F. Angeli, Milano, 1985.
E. Turri, Il paesaggio come teatro, Marsilio, Padova, 1998.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, Paris, 1972.
von Humboldt, Cosmos. Saggio di una descrizione fisica del mondo, Venezia, 1860.
Zagrebelsky, Valori e diritti, intervista ´La Repubblicaª, 22/2/2008.
La Pianificazione Paesaggistica
LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
CORSO DI FORMAZIONE SU PIANIFICAZIONE, REGIONE PIEMONTE 3/10/07
Roberto Gambino
-
La questione del paesaggio come questione europea
1.1. In una delle sue più intriganti parabole, Borges narra di un pittore che si propone di disegnare il mondo, ritrae paesaggi e si accorge, alla fine, “che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto”. Il paesaggio è l’autoritratto di un uomo come della società, coi suoi lineamenti fisici, le sue vicende e le sue speranze di vita: lega ciò che si vede a ciò che è vissuto. Dietro alle incessanti modificazioni dei paesaggi, alle ferite, alle mutilazioni e alle nuove configurazioni da esse prodotte, si delineano le trasformazioni della territorialità umana, dei modi con cui la nostra società abita la terra. E’ nei processi economici, sociali e culturali che attraversano il territorio la radice dei mutamenti dei paesaggi della contemporaneità, come del resto è sempre avvenuto nel corso della storia, visto che non c’è ecosistema che non risulti almeno in parte modificato dalla cultura umana (Schama, 1997). E’ nel territorio il terreno di scontro degli interessi che premono sui paesaggi e ne sollecitano i mutamenti. E’ su quel terreno che occorre cercare risposte a quel groviglio di ansie e di paure, di speranze e disincanti da cui nasce la crescente “domanda di paesaggio” della società contemporanea. Una domanda in nessun modo riducibile alla “deriva estetizzante di una società sazia, [che] al contrario è il segno che l’uomo tende a riallacciare i suoi legami con la terra, che la modernità aveva dissolto” (Berque, 1995). Una domanda che tende ad incarnarsi in nuovi “diritti di cittadinanza” (come il diritto alla bellezza o alla qualità dell’ambiente di vita) e che non può trovare risposta in operazioni “cosmetiche” o di semplice razionalizzazione degli apparati di tutela messi in campo dalle diverse istituzioni che si interessano di paesaggio. La “questione del paesaggio” è in questo senso una questione squisitamente territoriale: o, più precisamente, di politica territoriale. Il che, naturalmente, non significa affatto che paesaggio e territorio sian tutt’uno; chè anzi, proprio il riconoscimento dell’imprescindibile territorialità del paesaggio ne pretende la distinzione dal territorio che vi si esprime.
1.2. Non v’è dubbio che, alla luce dell’art.9 della Costituzione e delle interpretazioni ripetutamente affermate dalla Corte, la questione del paesaggio così concepita è una grande questione nazionale. Ma essa è anche e prima di tutto una grande questione europea. I mille paesaggi europei sono i mille volti dell’Europa: di un’Europa ancora in cerca di se stessa e della propria identità. E che la cerca non contro altre identità, ma nel dialogo, nell’inclusione e nella diversità. (Gambino, 2004). La diversità paesistica che caratterizza così plasticamente il continente europeo è il fondamento e l’espressione della sua diversità ecologica e culturale, vale a dire della principale ricchezza su cui l’Europa può basare il proprio ruolo nell’arena mondiale. Da questo punto di vista il paesaggio non può non essere considerato come una risorsa strategica per lo sviluppo durevole e sostenibile dell’intero continente (come parzialmente riconosce lo stesso “Schema di sviluppo dello spazio europeo”: UE 1999). D’altra parte, le rivendicazioni localiste non possono indurre ad ignorare che la considerazione della dimensione europea nelle politiche del paesaggio è sempre più imperiosamente reclamata dall’evoluzione stessa dei problemi da affrontare. In generale, questa evoluzione comporta una crescente complessificazione e, assai spesso, un vero e proprio “salto di scala”, che esigono apparati di controllo ed azioni di governo a scala sovra-locale: regionale, nazionale ed internazionale. Più specificamente, gran parte dei problemi implicati nelle politiche del paesaggio nel nostro paese dipende in misura crescente da dinamiche e politiche che maturano a livello europeo, in particolare in seno all’Unione Europea: basti pensare all’incidenza, spesso disastrosa, che le politiche agricole comunitarie (PAC) orientate in senso produttivistico hanno esercitato nei confronti dei paesaggi agrari e dello spazio rurale (in termini di omologazione o smantellamento delle antiche trame colturali o di cancellazione dei “paesaggi di piccola scala” di grande valore estetico ed ecologico); o all’impatto paesistico ed ambientale dei “grands réseaux” infrastrutturali, obbedienti a logiche del tutto avulse dalle realtà territoriali locali e indifferenti ai loro contesti paesistici. Da notare, in entrambi gli esempi, che il rapporto di dipendenza delle dinamiche paesistiche locali dalle politiche europee può essere volto in positivo: nuove PAC sono attese proprio per sostenere concretamente la rivalorizzazione degli spazi rurali, così come nuove politiche infrastrutturali possono contribuire in modo non marginale a celebrare la diversità dei paesaggi europei.
1.3. Per quanto sorretta da evidenze empiriche come quelle testè citate, la considerazione della questione del paesaggio come questione di politica territoriale non manca di mettere in discussione la riflessione scientifica e culturale, i quadri giuridici e istituzionali e gli approcci metodologici finora dominanti. Già nel 1977, Claude Raffestin sottolineando lo stretto rapporto tra paesaggio e territorialità, tra “vu” e “vecu”, incitava a cercare in una nuova geografia della territorialità umana ciò che si cela dietro alle forme del paesaggio. La sua posizione non era certo isolata ed affondava le radici in una lunga e prestigiosa tradizione del pensiero geografico, a partire almeno da von Humboldt (1860), non certo esente, peraltro, da differenze, contrasti e contrapposizioni non sempre adeguatamente percepite dall’esterno della disciplina. Ma quella posizione era allora certamente minoritaria nel campo degli studi, della pianificazione e delle pratiche gestionali riguardanti il paesaggio. Il paesaggio era allora (com’è tuttora) terreno di convergenza ma anche luogo dei sentieri che si biforcano. Mentre in alcuni paesi europei, in primo luogo l’Italia, perdurava una concezione essenzialmente “estetica” del paesaggio, che esplicitamente comportava il distacco del paesaggio dal paese reale, si era ormai affermata a livello internazionale quella “svolta ecologica” che doveva dominare, nel bene e nel male, nei decenni successivi la cultura del paesaggio, o più precisamente del “landscape” o “landshaft”.
1.4. Il ruolo egemone assunto, soprattutto a partire dagli anni ’60 e ’70, dalle scienze della terra e dal “paradigma ecologico” negli studi e nella pianificazione del paesaggio, trova ovvie spiegazioni nella solidità dell’impianto teorico offerto dalla Landscape Ecology (da C.Troll, 1939, a Naveh, Forman; Godron e altri), ma anche nell’importanza dei rapporti col “land” nella cultura americana (Steiner 1998), e nell’influenza profonda dei miti della natura nelle origini specifiche delle civiltà americane preesistenti alla colonizzazione (Schama, 1997). D’altra parte, non si può negare che la fede nelle scienze esatte, che aveva consentito a Jan McHarg (riprendendo le lezioni degli Odum, dei Leopold, di Angus Hill e di Philip Lewis) di propugnare polemicamente negli anni ’60 l’”ecological determinism” (1966), ha svolto nei decenni successivi un importante ruolo di contrasto nei confronti non soltanto del confuso impressionismo degli approcci estetizzanti o dell’arroganza progettuale della “landscape architecture”, ma anche del funzionalismo economicista e delle logiche della crescita implicite nell’”amenagement du territoire” non meno che nelle tendenze alla deregolamentazione selvaggia. Essa ha evidenziato la violenza implicita nel “maitriser la nature” (Marcuse), e i tragici errori del movimento moderno tra le due guerre, rimettendo in discussione i fondamenti culturali della manipolazione estetica della natura (il “plaisir superbe de forcer la nature”: Saint Simon). Ma il “paradigma ecologico”, nonostante le sue pretese globalizzanti, è mancato all’appuntamento più importante, quello appunto col territorio. D’altra parte, né l’interpretazione estetica (che in Italia ha trovato solido fondamento nel pensiero di Benedetto Croce), né quella semiologica (il paesaggio come processo di significazione: Barthes, 1985) sembrano in grado di cogliere l’essenza della territorialità del paesaggio. E’ in gioco il ruolo dell’osservazione e della conoscenza nel “progetto di paesaggio”, visto che “non c’è paesaggio senza progetto” (Bertrand, 1998). La conoscenza e la comprensione del paesaggio nascono in effetti da sintesi olistiche ed interpretazioni polisemiche di sguardi differenti ed instaurano col progetto rapporti carichi d’ambiguità e di interrogazioni, destinati a scardinare ogni pretesa d’oggettività e neutralità nei riconoscimenti di valore: il paesaggio non è mai un dato (Gambino 1997).
1.5. E’ in questo contesto fluido e problematico che si è mossa la Convenzione Europea del Paesaggio (CE, 2000), con la quale il Consiglio d’Europa ha ritenuto di affrontare la questione europea del paesaggio. La Convenzione (CEP) consacra politicamente gli orientamenti emergenti dalle riflessioni, dal dibattito e dalle sperimentazioni a livello internazionale, affermando alcune opzioni di fondo:
-
l’affermazione inequivoca che gli obiettivi di qualità paesistico-ambientale da perseguire non riguardano pochi brani di paesaggi di indiscusso valore (nella logica delle “bellezze naturali” o delle “emergenze sceniche” o panoramiche o di beni specifici e circoscritti) ma riguardano l’intero territorio, “gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani […] i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati” (art.2);
-
il pieno riconoscimento del significato complesso del paesaggio in quanto “parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”(art. 1a) e “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”;
-
il sistematico riferimento ai “soggetti interessati” o “coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche”, anche per quanto concerne la valutazione delle risorse paesistiche, che deve “tener conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate” (art. 5c, 6C) e le conseguenti procedure di consultazione e partecipazione.
2. La centralità della pianificazione
2.1.Le indicazioni della CEP hanno rilevanti implicazioni sulle politiche pubbliche per il paesaggio. In primo luogo, esse pongono l’esigenza di una regolazione pubblica dei processi che incidono sul paesaggio, di ben maggiore impegno di quella tradizionalmente affidata alle misure di “vincolo” su singoli oggetti individualmente considerati. Queste misure infatti appaiono del tutto incapaci di esprimere una considerazione olistica, dinamica e sistemica dei processi da controllare, sia sotto il profilo dell’articolazione spaziale (che deve riguardare l’intero territorio e non singoli oggetti), sia sotto il profilo dei contenuti da sviluppare (che devono tener conto congiuntamente delle valenze ecologiche, storico-culturali, estetiche e semiologiche, ecc.), sia, ancora, sotto il profilo previsionale ed evolutivo. Per rispondere a queste esigenze, l’azione regolatrice deve essere guidata non solo da forme adeguate di conoscenza “contestuale”, ma anche – come si è già notato – da opzioni progettuali, atte a prefigurare i risultati attesi, in rapporto agli “obiettivi di qualità” (CEP, art. 6D) che si intendono perseguire. Inoltre, l’azione regolatrice deve portare ragioni delle sue scelte, motivarle e giustificarle in modo da consentirne la “certificazione sociale” nel quadro di processi “partecipati” di formazione delle scelte e di attribuzione dei valori (CEP, art.5c).
2.2. E’ interessante notare che analoghe esigenze si sono negli ultimi 15-20 anni imposte all’attenzione anche in altri campi d’azione pubblica, segnatamente:
- nel campo della conservazione della natura, con l’orientamento a “territorializzare” le politiche ambientali (UNDEP, 1992), ad esempio con approcci “bioregionali”, o con i “nuovi paradigmi” per le politiche dei parchi e delle aree protette (IUCN, 2003, 2004);
- nel campo della tutela del patrimonio storico-culturale, con lo spostamento d’attenzione dai singoli beni ai centri storici, al territorio storico (ANCSA 1990, 2006) e ai “sistemi culturali territoriali” (Euromed, 2003).
In tutti questi campi, come in generale nel campo delle politiche ambientali e territoriali, si avverte in sostanza l’esigenza di azioni più efficaci di regolazione pubblica, a fronte dei nuovi rischi e della complessificazione dei problemi, della comprovata inadeguatezza degli approcci puntuali e settoriali, dell’urgenza di politiche di prevenzione, meno segnate dalle logiche dell’emergenza e della riparazione. Ed è sintomatico che tale esigenza trovi riscontro, a livello legislativo, nella centralità attribuita alla pianificazione territoriale ed alle sue declinazioni specialistiche. Per limitarci al caso italiano, il primo segnale di svolta può essere fatto risalire alla L.431/1985 (legge Galasso) che appunto fonda l’azione di tutela del paesaggio sulla pianificazione paesistica (o sulla “pianificazione urbanistica e territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali”) affidata alle Regioni. Pochi anni dopo, la L.183/1989, ristrutturando organicamente l’intera materia della difesa del suolo e della gestione delle acque, pone al centro la “pianificazione di bacino”, affidata alle Autorità di bacino, rompendo una lunga tradizione di intervento sostanzialmente basata sulle “opere pubbliche” settorialmente individuate. A breve distanza di tempo, la L.394/1991 fonda la gestione dei parchi sui “piani dei parchi”, sostitutivi di ogni altro piano nel territorio protetto. Nel corso degli anni ’90 numerosi altri provvedimenti hanno integrato quelli ora citati, ribadendo il ruolo della pianificazione, fino al recente Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) che, riprendendo ed estendendo a quasi vent’anni di distanza il dettato della “legge Galasso” del 1985, mette l’accento sulla pianificazione “paesaggistica” come strumento chiave per le nuove politiche del paesaggio.
2.3. Non è certo un caso che la centralità attribuita dal Codice alla pianificazione paesaggistica coincida, almeno nelle intenzioni, col recepimento delle innovative indicazioni della CEP. In altri termini, sembra plausibile che, per raccogliere le sfide lanciate dalla Convenzione, il legislatore nazionale non potesse che puntare sulla pianificazione: come recita l’art.135 (prima delle recenti modifiche), al fine di assicurare “che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato […] le Regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale”. A parte il necessario richiamo alla “legge Galasso”, e l’estensione del suo campo d’applicazione all’intero territorio (estensione di per sé non particolarmente significativa, ove si consideri che le aree tutelate in base a tale legge coprivano già circa la metà del territorio nazionale), il superamento della concezione “elitaria” implicita nella vecchia legislazione e soprattutto nelle pratiche tradizionali di protezione del paesaggio (caratterizzata dalla tutela di un numero limitato di “beni” isolati e raccolti in appositi elenchi) e l’avvio di politiche più efficaci di tutela e valorizzazione non poteva che sollecitare il ricorso alla pianificazione urbanistica e territoriale o quanto meno a forme speciali di pianificazione (territoriale) paesaggistica. Passo obbligato, per dare adeguato riscontro agli impegni fissati dalla CEP, in particolare con l’art. 5d, che richiede di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere una influenza diretta o indiretta sul paesaggio”.
2.4. Tuttavia, il confronto tra l’evoluzione legislativa italiana in materia di paesaggio e la CEP è più complicato. Intanto, va segnalato che la Convenzione usa in più luoghi (ad es. artt. 1f, 6B-b, 6E) il termine di “pianificazione del paesaggio” con significato certamente diverso da quello attribuitogli nella legislazione nazionale. Accostandolo ai termini di “salvaguardia” e “gestione”, essa non intende palesemente alludere ad uno strumento di gestione (Priore, 2006), quanto piuttosto ad una modalità d’azione, in qualche misura vicina a quella evocabile con l’“amenagement” usato nella traduzione francese. D’altronde, non è casuale che manchi nella CEP una precisa identificazione degli strumenti amministrativi con cui attuare le politiche del paesaggio: sia perché la Convenzione fa riferimento anche ad un’ampia gamma di misure e attività (come quelle di sensibilizzazione, educazione e formazione) non riconducibili agli strumenti della pianificazione territoriale, sia perchè la scelta degli strumenti non può che dipendere dai quadri istituzionali e legislativi dei singoli paesi membri, che presentano al riguardo notevoli difformità.
2.5. L’impulso che la CEP ha inteso imprimere alle politiche europee del paesaggio va ben oltre ciò che può essere richiesto ai singoli strumenti amministrativi e riguarda un insieme vasto e articolato di azioni pubbliche. In questo quadro, cambiano notevolmente le missioni che possono essere assegnate alla pianificazione territoriale paesaggistica – se con questo termine vogliamo alludere non tanto a singoli atti amministrativi, quanto piuttosto a processi politico-amministrativi che riguardino l'intero territorio con particolare attenzione per il paesaggio (espressione volutamente generica, che può ricomprendere le varie articolazioni previste dal Codice 2004 e/o messe in campo dalle Regioni a partire dalla L.431/1985 o dalle successive legislazioni regionali).
2.6. La prima missione ad essere messa in discussione è quella propriamente regolativa. Se infatti è vero che la pianificazione è stata ed è sollecitata a supportare, come si è prima osservato, più efficaci azioni pubbliche di regolazione dei processi di trasformazione, non è meno vero che tale regolazione deve attuarsi in contesti politici e sociali caratterizzati sempre più dal pluralismo dei soggetti decisionali e dei portatori d’interesse, dall’indebolimento di molti dei tradizionali meccanismi di “comando e controllo”, dalle rivendicazioni autonomiste dei poteri locali, dalla difficile ricerca di forme efficaci di sussidiarietà e dalla stessa incertezza e aleatorietà degli scenari previsionali. Queste tendenze di fondo hanno da tempo scosso la fiducia nella pianificazione, messo in crisi i suoi paradigmi e i suoi statuti disciplinari, imposto ripensamenti profondi della cultura amministrativa e professionale che si occupa di pianificazione. Nel campo urbanistico, la critica ai modelli “conformativi” e agli ordinamenti “gerarchici” ha spostato l’attenzione sulle logiche “performative” dei piani, sulle esigenze di flessibilizzazione degli apparati normativi, oltre che sulle forme di partecipazione sociale alla formazione delle scelte e sui meccanismi valutativi di supporto. Ancora più significativa l’evoluzione degli orientamenti nel campo della conservazione della natura e delle politiche ambientali. Qui lo spostamento dalle tradizionali politiche top-down verso quelle bottom-up, col crescente riferimento al ruolo degli attori locali e alle forme di gestione cooperativa delle risorse (IUCN. 1996, 2003,2004) è stato particolarmente evidente, così da configurare un importante “shift in focus” nelle dichiarazioni emergenti a livello internazionale.
2.7. Ciò che accomuna le diverse tendenze nel caratterizzare le “nuove” missioni della pianificazione non è soltanto il nuovo modo di concepire “le regole” che essa è chiamata ad esprimere, ma anche e forse più l’importanza crescente attribuita alla sua dimensione “strategica”. In altri termini, alla sua capacità di esprimere, sulla base di visioni di lungo termine e di largo orizzonte, obiettivi ed indirizzi strategici condivisi da una pluralità di soggetti interagenti, mettendo in risalto le poste in gioco e gli interessi coinvolti, le priorità e le opzioni di fondo. In questa direzione, la pianificazione strategica rinuncia deliberatamente ad una funzione direttamente “normativa” per esercitare piuttosto una funzione di stewardship, di guida, seduzione e persuasione nel corso di processi decisionali complessi e aperti, i cui esiti non possono essere fissati del tutto a priori. In quanto strumento di “governance” più che di governo, la pianificazione strategica non implica affatto, di per sé, un indebolimento dell’efficacia dell’azione pubblica, poiché al contrario consente di allargare l’area di influenza e la platea dei soggetti coinvolti, favorendo la concertazione inter-istituzionale, la cooperazione tra i diversi portatori di interessi e la regolazione negoziale dei conflitti d’interesse non risolvibili per via autoritativa. Ciò sembra del tutto in sintonia con le raccomandazioni della CEP (art. 5c) volte ad “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche”.
2.8. Se si accetta l’idea che la pianificazione paesaggistica non possa limitarsi a definire le misure di protezione passiva, ma debba esprimere un disegno strategico di politiche del paesaggio, capace di confrontarsi con i processi di degrado e le esigenze di gestione che concretamente si manifestano, occorre rivedere anche la tradizionale missione conoscitiva della pianificazione. Quanto più la pianificazione si esprime in orizzonti strategici caratterizzati dall’apertura, dall’inclusione e dall’interazione, tanto più essa deve essere in grado di produrre “conoscenza regolatrice”, di motivare e giustificare le scelte che propone e di valutarne gli effetti, di individuare i valori non negoziabili e i campi di negoziabilità, di sollecitare l’attenzione di tutti gli interessati per le poste in gioco: non si difende ciò che non si conosce (non è un caso che la CEP indichi come prima misura la “sensibilizzazione”: art. 6A). Il rafforzamento della funzione conoscitiva della pianificazione ha però importanti implicazioni:
-
In primo luogo essa implica la capacità di offrire una lettura sintetica, inter– e trans-disciplinare del territorio e delle sue espressioni paesistiche, che non può risultare dal semplice accostamento delle letture settoriali. A tal fine è di grande interesse la sperimentazione in corso delle “interpretazioni strutturali” del territorio, esplicitamente richieste, seppure in modi diversi, da alcune legislazioni regionali (Toscana, Campania, Emilia-Romagna ed altre); esse, in sostanza, mirano ad evidenziare quegli elementi e quelle relazioni costitutive di lunga durata che possono essere considerate stabili o “invarianti” nei confronti di qualunque ipotesi di trasformazione.
-
In secondo luogo, la conoscenza delle realtà in atto non può in alcun modo separarsi da quella delle loro possibili evoluzioni (non si possono separare le cose dal loro divenire) più o meno nfluenzate dalle scelte d’intervento. Ciò comporta l’introduzione nei processi di pianificazione di procedure di valutazione preventiva, esplicita e trasparente, quali quelle già in vigore (come le Valutazioni d’impatto, le Valutazioni d’incidenza, le Valutazioni ambientali strategiche), opportunamente arricchite per quanto concerne gli aspetti squisitamente paesaggistici.
-
In terzo luogo, alla luce della CEP, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi implicano la piena considerazione delle percezioni e delle attribuzioni di valore da parte “dei soggetti e delle popolazioni interessate” (art. 6C). Considerazione che sembra doversi e potersi allargare non solo alle comunità e agli attori locali –direttamente e stabilmente impegnati nella “produzione” del paesaggio (o nella sua “edificazione”, come diceva il Cattaneo riferendosi alla campagna milanese riorganizzata sotto l’impulso delle riforme teresiane), ma anche dei visitatori e dei “care taker” che in vario modo concorrono a modellare il paesaggio e le sue rappresentazioni (come ad es. avvenne nella “invenzione delle Alpi” tra Seicento ed Ottocento da parte dei visitatori europei).
-
Problemi aperti
3.1. Le considerazioni di cui sopra lasciano intuire che la definizione del ruolo della pianificazione territoriale ai fini dell’attuazione della CEP è tutt’altro che semplice o scontata: si può anzi immaginare che costituisca uno dei temi di maggior rilievo che la Rete europea per l’attuazione della CEP (RECEP), in via di attivazione presso il Consiglio d’Europa, dovrà affrontare. Nel contesto italiano, il tema è indubbiamente complicato dalle incertezze interpretative e dalle aporie del Codice del 2004, anche alla luce delle modificazioni in seguito introdotte. L’entrata in vigore della CEP costringe infatti a discutere alcuni problemi di coerenza con gli indirizzi della Convenzione, che il Codice ha a in qualche misura lasciato aperti.
3.2. Il primo problema aperto riguarda il “focus” della pianificazione del paesaggio, il suo centro d’attenzione. Nella impostazione del Codice, essa ha due orientamenti compresenti, quella che fa riferimento ai “beni paesaggistici” (art.134), già tutelati per legge o individuati dai piani, e quella che fa riferimento agli “ambiti di paesaggio” (art. 135) in cui si ripartisce il territorio regionale in base alle caratteristiche naturali e storiche, a ciascuno dei quali sono attribuiti specifici obiettivi di qualità paesaggistica. Questo duplice orientamento riflette due diverse filosofie di politica del paesaggio:
-
nella prima, che ha trovato piena espressione nella Convenzione Europea, il paesaggio è un sistema che si articola in forme diverse, più o meno coerenti e pregevoli, in tutto il territorio; esso è di tutti e di ciascuno, la sua protezione risponde a diritti diffusi che riguardano il quadro di vita di ogni popolazione e non può prescindere dai legami d’appartenenza e identificazione che con essa si stabiliscono; la sua valorizzazione tende a coincidere con la valorizzazione del territorio, la sua “produzione” tende a saldarsi col suo “uso”, restituendo pienezza e qualità all’”abitare” il territorio; in questa filosofia, la politica del paesaggio richiede strategie d’azione per gestire i processi di trasformazione, il più possibile integrate, concertate tra i diversi soggetti aventi responsabilità di governo e condivise dai diversi portatori d’interesse;
-
nella seconda filosofia, (rappresentata al limite dalle Guidelines con cui l’Unesco inserisce determinati paesaggi culturali nel patrimonio mondiale dell’umanità, Iccrom 1998; ma rintracciabile anche nelle logiche con cui, in molti paesi, sono stati istituiti “paesaggi protetti” oggetto di particolare tutela, corrispondenti ad una delle categorie internazionalmente riconosciute: Iucn 1994), il paesaggio è una “emergenza”, un bene “eccellente”, di particolare o eccezionale valore, in quanto tale staccabile dal contesto territoriale; esso non “appartiene” alle popolazioni locali, la sua protezione risponde ad interessi universali o comunque sovralocali e può prescindere dalle relazioni che con esse si stabiliscono; la sua valorizzazione è, almeno in linea di principio, indipendente da logiche territoriali, il suo uso e la sua stessa specifica gestione tendono a staccarsi dai processi di produzione e dalle attività degli abitanti; in questa filosofia, la politica del paesaggio tende ad affidarsi soprattutto a regole di gestione, stabilite dalle autorità competenti e prevalenti su ogni pur legittima attesa di sviluppo.
3.3. Al di là del favore di cui le politiche delle “eccellenze” sembrano godere nell’attuale contesto politico, non si può negare che questa bipolarizzazione percorra il nuovo Codice, nella misura in cui esso da un lato riprende e precisa, nella linea della L.1497, l’attenzione per i beni di intrinseco valore paesaggistico, dall’altro allarga la considerazione dei beni paesaggistici a tutto il territorio e introduce il concetto degli “ambiti di paesaggio” in cui essi dovrebbero integrarsi e, per così dire, “territorializzarsi”. E’ anche importante notare che questa bipolarizzazione ha assai poco a che vedere con la contrapposizione “tra i vincoli e i piani” risalente ai dibattiti degli anni ’80, una contrapposizione schematica e quasi caricaturale, che ignora la complementarietà tra i due ordini di strumenti: i piani senza vincoli rischiano di ridursi a libri dei sogni, i vincoli senza piani rischiano di essere “ciechi e muti”. Ma la dilatazione del campo d’attenzione proposta dal Codice sembra lontana dal potersi tradurre in pratiche coerenti con la prima delle due filosofie sopra evocate. Non è un caso che nel Codice si faccia esclusivo riferimento ai “beni culturali” e ai “beni paesaggistici” quali oggetti distinti di tutela e mai ai sistemi di relazioni che li legano strutturando il territorio. La cosa non stupisce: l’idea che l’opzione conservativa debba allargarsi all’intero territorio sembra, in realtà, fragile e perdente di fronte alle minacce e ai rischi incombenti, come tipicamente le aggressioni dilaganti dell’abusivismo (incoraggiato dai ricorrenti condoni) o la svendita dei beni pubblici (accelerata dai contestati provvedimenti legislativi degli ultimi anni). L’urgenza dell’azione di difesa e la scarsità di risorse sembrano indurre più di ieri a concentrare gli sforzi sulle cose di maggior valore – come i monumenti, le aree naturali di maggior pregio, o i paesaggi di pregio eccezionale – o a cercare di “salvare il salvabile”. Di qui la corsa disperata e comprensibile delle nostre Soprintendenze a cercare rifugio negli elenchi delle cose intoccabili, dei tesori non negoziabili. Ma non si salva il paesaggio se non si salva il paese. Staccare i monumenti o le “bellezze naturali” dal variegato mosaico di paesaggi umanizzati (pur frequentemente deturpati o sconvolti dalle trasformazioni recenti) che costituisce il volto vero del nostro come di altri paesi europei, significa ignorare le ragioni profonde che stanno alla base dell’attuale domanda di qualità, il ruolo dei valori identitari e il radicamento territoriale delle culture locali, il rapporto costitutivo che lega la gente ai luoghi. Evitare questa spaccatura, d’altra parte, non vuol dire che si debba fare di ogni erba un fascio, negare il valore dei paesaggi eccezionali o il significato peculiare dei tanti impareggiabili paesaggi culturali che arricchiscono lo spazio europeo, stemperare l’azione di tutela nei paesaggi dell’ordinarietà, dell’anomia e del degrado che coprono ormai larga parte del territorio. Al contrario, allargare l’attenzione all’intero territorio è la strada obbligata per cogliere le differenze, diversificare l’azione di tutela, rispondere diversamente, nelle diverse situazioni, alla domanda di qualità.
3.4.Queste considerazioni introducono un secondo problema, riguardante il riconoscimento dei valori del paesaggio, toccato dal Codice in particolare negli artt. 135 e 143, recentemente modificati. E’ chiaro che la pianificazione, non solo per quanto concerne le misure specificamente poste a tutela dei singoli beni paesaggistici, ma ancor più per quanto concerne le “previsioni” per ogni ambito di paesaggio ordinate (come chiede l’art.135 del Codice) a mantenere i caratteri identitari, ad individuare linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibile, a recuperare le aree degradate, ad individuare interventi per lo sviluppo sostenibile, si fonda sul riconoscimento della “tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici”. Riconoscimento operato con la possibile oggettività e con gli strumenti scientifici che le diverse discipline interessate mettono a disposizione. Tutto ciò corrisponde alle indicazioni della Convenzione Europea. Desta invece perplessità l’attribuzione al piano paesaggistico del compito di definire una gerarchia di “livelli di valore”, individuando le modalità per la loro specifica attribuzione ai diversi ambiti o, peggio, alle diverse componenti territoriali. Le perplessità non riguardano ovviamente la possibilità-opportunità di esprimere giudizi di valore su singoli beni o singole parti del territorio (secondo una prassi largamente consolidata a livello internazionale nel campo della conservazione della natura), ma la pretesa di fondare solo o essenzialmente su tali giudizi le misure di disciplina. Attribuire “livelli di valore” scalarmente ordinati a beni caratterizzati in modo specifico secondo caratteristiche peculiari, sembra operazione culturalmente discutibile. Non solo perché implica l’attribuzione di valutazioni soggettive, largamente discrezionali per molti aspetti, come tipicamente quelli estetici, a beni di cui invece l’analisi scientifica oggettiva consente di definire i connotati caratterizzanti e le ragioni della tutela. Ma anche perché sul piano applicativo comporta una inopportuna iper-semplificazione delle indicazioni normative, che cancella arbitrariamente le profonde diversificazioni che, anche all’interno della più piccola porzione di territorio, danno vita ai diversi paesaggi.
3.5. Un terzo problema concerne la divisione tra i “beni culturali”, cui è dedicata la parte seconda e più cospicua del Codice, e i “beni paesaggistici”, cui è dedicata la parte terza. E’ una divisione ben comprensibile alla luce delle tradizioni nazionali in materia di conservazione, ma difficile da sostenere sul piano strettamente scientifico e culturale (come si è già rilevato, le nuove concezioni del patrimonio tendono piuttosto ad abbattere le vecchie divisioni e a conferire al patrimonio paesistico un’accezione assai ampia e comprensiva) e difficile da praticare sul piano applicativo. Basti pensare ai centri storici, praticamente assenti dal Codice del 2004 se non ridotti alla figura di “monumenti complessi”, chiaramente superata dal dibattito degli ultimi decenni: essi infatti non figurano nel pur minuzioso elenco dei tipi di beni culturali (l’art. 10 sembra anzi quasi negarne l’esistenza, nel momento in cui cita invece esplicitamente “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, come se in questi si esaurisse il ruolo complesso ed integrante dei centri storici) e sono esplicitamente esclusi dalle categorie di beni paesaggistici “tutelati per legge” (art. 142, c.2, lett.a). Va però segnalato che le modifiche recenti del Codice (art. 136) hanno inserito i centri storici e le zone di interesse archeologico tra le aree di notevole interesse pubblico da tutelare. Naturalmente nulla esclude che i piani urbanistici o quelli paesaggistici dedichino particolari tutele a determinati centri storici, ma è curioso che il Codice non colga la rilevanza generale degli insediamenti storici – e in sostanza della città, in tutte le sue articolazioni storiche anche recenti – come struttura di base del “capitale territoriale”.
3.6. Un quarto e cruciale problema concerne la separazione tra tutela e valorizzazione, peraltro già introdotta con la riforma del Tit.V della Costituzione (art.117), che distingue “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” di competenza esclusiva dello Stato, dalla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Nonostante non manchino i richiami alla necessità di integrare tutela e valorizzazione con l’azione concorde di Stato e Regioni (e a prescindere dalle incertezze interpretative: v. sentenza Corte Costituzionale n.407/2002), sembra evidente che proprio a questo riguardo il Codice manchi all’appuntamento più importante, quello dei nuovi rapporti tra conservazione e sviluppo sostenibile. Come si è già ripetutamente osservato, questi rapporti sono tanto più stretti e condizionanti quanto più la conservazione tende ad allargarsi a tutto il territorio, interessando le aree e i sistemi della marginalità e dell’abbandono, che coprono ormai una larga parte del territorio nazionale: qui non solo le misure di vincolo e protezione passiva, se sganciate dalle politiche di investimento e di sostegno economico e sociale, non possono concorrere alla rivalorizzazione territoriale, ma in molti casi non possono neppure essere concretamente applicate (quali vincoli, ad esempio, potrebbero mai fermare lo sfacelo dei versanti terrazzati o la ruderizzazione incalzante dei villaggi montani?). Ma la separazione tra tutela e valorizzazione rischia, ancor più in generale, di nascondere un problema di fondo del nostro paese, quello della prevenzione dei rischi: un problema che torna alla luce dei riflettori mediatici solo in occasione di alluvioni o frane catastrofiche o di grandi sismi distruttivi, soprattutto se con vittime umane. D’altronde, i contenuti stessi della pianificazione paesaggistica, quali definiti dal Codice all’art. 143 (spostati e riformulati, con le recenti modifiche, nell’art. 135) sembrano richiedere azioni incompatibili con la rigida separazione delle competenze tra tutela e valorizzazione.
3.7. Le difficoltà che la pianificazione incontra nel perseguire l’effettivo allargamento delle politiche del paesaggio all’intero territorio, la considerazione integrata del patrimonio culturale territoriale, la saldatura tra misure di protezione ed azioni positive di sviluppo durevole, sono aggravate dalle incertezze e dalle confusioni concernenti l’articolazione orizzontale e verticale delle responsabilità istituzionali, i rapporti pubblico-privato e il ruolo degli attori locali e degli altri soggetti interessati. A questo proposito, il Codice del 2004 sembra lasciare aperti non pochi problemi, che le modifiche successive hanno per certi aspetti inasprito. In primo luogo sembrano fondati i timori di un oggettivo indebolimento del ruolo delle Regioni nei confronti dello Stato (come emergerebbe dal confronto tra il precedente ed il nuovo art. 135 circa la titolarità della pianificazione paesaggistica; o dalla riduzione, nel primo comma dell’art. 142, della possibilità del piano paesaggistico di ridefinire i vincoli per le aree tutelate per legge sulla base di criteri oggettivi e non puramente parametrici). In secondo luogo il Codice sembra ignorare l’orientamento, chiaramente sancito in alcune legislazioni regionali e riflesso in numerose esperienze di piano, ad articolare sul territorio il processo di pianificazione paesaggistica, con un forte coinvolgimento delle Province e dei Comuni: orientamento del tutto coerente non solo col principio di sussidiarierìtà, ma anche più specificamente con le indicazioni della CEP. Qui non è in gioco il localismo, ma l’efficacia dell’azione di governo, che è responsabilità primaria degli Enti locali e che chiama in causa i principì di cooperazione e integrazione. In terzo luogo, non si può non rilevare la sostanziale mancanza nel Codice di ogni riferimento alle percezioni e alle attese delle popolazioni e degli altri soggetti interessati, ed alla partecipazione della società civile nelle fasi cruciali del riconoscimento dei valori paesaggistici, della definizione degli obiettivi di qualità e di definizione e realizzazione delle politiche del paesaggio. Rischia così di smarrirsi proprio quella dimensione sociale del paesaggio che costituisce il fondamento principale della svolta politico-culturale impressa dalla Convenzione Europea.
4. Il PPR del Piemonte:
4.1.In un contesto legislativo, politico e culturale fluido ed evolutivo, quale quello tratteggiato nei paragrafi precedenti, l’esperienza avviata dalla Regione Piemonte nel 2005 presenta alcuni aspetti peculiari su cui vale la pena portare l’attenzione. Essa tenta infatti di raccogliere in modi originali la scommessa centrale che emerge dai problemi evocati: come costruire un piano paesaggistico autonomo e distinto (e in quanto tale capace di assumere pienamente l’efficacia normativa e la pregnanza culturale previste dal nuovo Codice) senza perdere i legami con la pianificazione territoriale, generale e di settore, volta a governare in tutto il territorio regionale, i processi di trasformazione da cui l’integrità e la qualità del paesaggio inesorabilmente dipendono. La risposta che i documenti programmatici finora approvati tentano di dare, e che dovrà ovviamente trovare esplicito e determinante riscontro nella nuova legislazione regionale in materia, parte dalla distinzione tra i singoli atti di pianificazione – tra cui il PPR - ed il processo complessivo di pianificazione territoriale, all’interno del quale i singoli atti e strumenti debbono convergere e coordinarsi in modo da conferire all’azione pubblica di governo la necessaria unitarietà e coerenza. Questa impostazione, a prescindere dai profili giuridici, ha rilevanti implicazioni tecniche e politiche. Sul piano politico, essa implica in particolare il coinvolgimento diretto e attivo, nella formazione del PPR, dei soggetti istituzionali (in primo luogo Province e Comuni) titolari di precise competenze di gestione territoriale, pur riserbando alla Regione – come prevede il Codice - la responsabilità di ogni determinazione riguardante lo stesso PPR. Sul piano tecnico-scientifico, è fin troppo facile constatare la complessità del coordinamento con cui legare i diversi strumenti di piano e, conseguentemente, le diverse attività di elaborazione conoscitiva e progettuale necessarie per produrli. A tal fine, i programmi di lavoro individuano alcuni momenti cruciali di convergenza delle operazioni avviate rispettivamente per il PPR e per il PTR.
4.2. L’interpretazione strutturale del territorio costituisce il primo e fondamentale momento di convergenza. Esso deve infatti consentire di fondare la formazione del PPR e più in generale delle scelte territoriali su una base ricognitiva che faccia emergere i fattori, elementi e relazioni di lunga durata, che hanno assunto o possono assumere un ruolo strutturante nei confronti dei processi di trasformazione del territorio regionale, assicurando la permanenza dei suoi caratteri identitari e la conservazione dei suoi sistemi di valori. Tale interpretazione implica un confronto selettivo tra le diverse letture del territorio (nei suoi aspetti fisici – biotici e abiotici – naturali ed antropici, storici, culturali e semiologici) in vista di una sintesi olistica e interdisciplinare, in grado di fissare, per così dire, i “punti fermi” di ogni percorso progettuale, ovvero, per fare riferimento a concetti che hanno già trovato riscontro in altre esperienze e legislazioni regionali, le “invarianti”, le regole statutarie, gli “statuti dei luoghi”. Sulla base di queste letture plurime si costruisce il Quadro di riferimento territoriale, che riassume l’insieme dei condizionamenti da cui né il PTR né il PPR possono prescindere. Nell’elaborazione del PPR, assume inoltre rilievo la distinzione tra fattori propriamente strutturanti e fattori caratterizzanti, qualificanti o, al contrario, di degrado o criticità; distinzione che si ripropone alle diverse scale di lettura (regionale, provinciale e locale). Se quindi in una visione regionale o trans-regionale spiccano alcuni grandi connotati (come la corona alpina, il sistema idrografico principale, la fascia pedemontana, la gerarchia dei centri), ben più articolata è la lettura che si impone alla scala locale. Ciò sollecita la partecipazione attiva delle diverse istituzioni alla costruzione progressiva della carta di interpretazione strutturale. Tale partecipazione è tanto più opportuna in quanto l’interpretazione, pur fondandosi su una ricognizione la più possibile oggettiva della realtà in atto e delle sue tendenze evolutive di lungo periodo, non può prescindere dalle opzioni di fondo che orientano il processo di pianificazione, soprattutto sotto il profilo della sostenibilità paesistico-ambientale: l’ambiente e il paesaggio non sono mai “un dato”. In questo senso l’interpretazione strutturale si configura come un ponte tra i riconoscimenti dei valori e delle criticità in atto e le scelte di progetto.
4.3. Un secondo fondamentale momento di convergenza tra la pianificazione paesaggistica e quella territoriale è costituito dal tentativo di costruire un quadro strategico unitario, col quale orientare le scelte su entrambi i versanti. Il tentativo di integrare la dimensione strategica nella pianificazione territoriale (anziché svilupparla in forme del tutto separate, come nell’esperienza di altre regioni) si articola a più livelli. In termini di politiche complessive di sviluppo regionale, esso trova riscontro in un apposito Documento strategico. Ma la “territorializzazione” delle politiche proposte si articola maggiormente sia all’interno del PTR (con riferimento alla partizione del territorio regionale in 34 “ambiti di integrazione territoriale”, largamente basati sulle progettualità e le iniziative locali), sia all’interno del PPR. Per quanto riguarda quest’ultimo, si avverte la necessità di disporre di un quadro di riferimento programmatico basato su visioni estremamente lungimiranti, che tenga conto di linee d’azione che competono ad una pluralità di soggetti istituzionali e di attori locali relativamente autonomi, che escono almeno in parte dalla sfera d’influenza regionale e che dipendono da congiunture e dinamiche evolutive scarsamente prevedibili. E’ opportuno sottolineare che, nella specifica situazione regionale, ampi margini di incertezza si profilano sia per quanto concerne gli effetti locali dei cambiamenti climatici globali e le necessarie misure di “adattamento”(basti pensare al rischio idrogeologico o alla “scomparsa” della neve nell’intero arco alpino), sia per quanto attiene alla realizzazione di grandi infrastrutture di rilevanza europea. Nonostante l’incertezza e la labilità delle previsioni, la costruzione progressiva di un quadro strategico flessibile e condiviso – e in quanto tale non direttamente vincolante - costituisce un impegno imprescindibile, al fine di contribuire efficacemente (anche ai sensi dell’art, 5 della Convenzione Europea del Paesaggio) alla “governance” dei processi di trasformazione di varia natura che incidono sull’ambiente e il paesaggio. D’altra parte va notato che la flessibilità delle indicazioni strategiche incorporate nel PPR trova un limite nella saldezza dell’interpretazione strutturale di cui all’inquadramento strutturale sopra evocato: da questo punto di vista l’interpretazione strutturale e l’inquadramento strategico sono destinati a svolgere ruoli complementari nel governo del territorio.
4.4. In prospettiva regionale, la territorializzazione delle politiche per l’ambiente e il paesaggio indicate dal PPR trova un valido riferimento negli “ambiti di paesaggio”, vale a dire in una partizione del territorio regionale ispirata a criteri prevalentemente ambientali, paesistici e culturali. E’ infatti il confronto coi caratteri storici e naturali delle realtà locali, coi loro sistemi di valori, coi loro problemi e le loro criticità in atto o potenziali, nonché (come prescrive la Convenzione Europea del Paesaggio) con le percezioni e le attese delle popolazioni locali, che le indicazioni strategiche regionali possono trovare opportuno riscontro in scelte di governo, indirizzi di piano e determinazioni normative. Di qui l’interesse per l’individuazione degli ambiti che, pur movendo dalle esigenze di tutela e valorizzazione paesistica affidate al PPR, non può non tenere conto delle dinamiche urbanistiche, economiche e sociali o di altra natura che investono le realtà locali. E’ in questa prospettiva che il territorio regionale è stato ripartito in 76 ambiti; ed è in questa prospettiva che prende rilievo il confronto di tali ambiti coi 34 “ambiti di integrazione territoriale” del PTR. Ciò detto, va evidenziato in particolare il ruolo normativo attribuito agli “ambiti di paesaggio” dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 135 e succ.): ruolo complementare a quello che trova riscontro nella tutela dei beni paesaggistici. Il che ha motivato l’interpretazione (riflessa già in altri piani paesaggistici come quello sardo o quello campano) di un “doppio strato normativo”, costituito appunto dalle norme per ambiti e da quelle per i singoli beni: interpretazione che porta a riconoscere proprio nella disciplina per ambiti il superamento innovativo della disciplina tradizionale, riferita a singoli oggetti di tutela (i beni) e indifferente ai contesti di cui fan parte integrante e inseparabile. Va però aggiunto che l’articolazione della disciplina per ambiti, proprio perché pregna di significato progettuale, non può che configurarsi come un processo, destinato a coinvolgere istituzioni locali, attori e portatori di interessi. Se, come afferma la Convenzione Europea, il paesaggio è “fondamento delle identità locali”, l’articolazione dei paesaggi non può ridursi ad un’operazione tecnica neutrale, ma implica un processo sociale di riconoscimento e riappropriazione culturale. In questa direzione, si profila l’opportunità di cogliere, anche all’interno degli ambiti di paesaggio, differenze e trame di connessione di rilevante valore identitario; in particolare, di riconoscere al loro interno, le “unità di paesaggio” (di dimensione più prossima a quella delle comunità locali) caratterizzate da specifici sistemi di relazioni ecologiche, storiche e culturali .
4.5. Come si è ripetutamente notato, gli apparati di tutela del paesaggio hanno conosciuto, anche nel nostro paese (dapprima con la L 431/1985, poi con la Convenzione Europea e con il Codice del 2004), un rilevante spostamento d’attenzione dalla protezione, prevalentemente passiva, dei singoli beni alla conservazione, tendenzialmente attiva, dei sistemi di relazioni contestuali in cui i beni stessi sono organicamente inseriti. Ma questo spostamento non implica un indebolimento dell’interesse pubblico per il valore intrinseco dei beni, che al contrario trova ampio riscontro nello stesso Codice. Ciò vale in particolare per i “beni paesaggistici”, in primo luogo per quelli già “tutelati per legge” con riferimento alle categorie già definite dalla L.431/1985 e poi riprese dal nuovo Codice (art.142). Per tali beni il piano paesaggistico deve infatti procedere alla loro puntuale individuazione e disciplina, impresa di non poco conto se si considera la vasta estensione del territorio regionale da essi interessato (montagne, laghi e fasce fluviali, boschi, ecc.).Ma l’opzione paesistica si amplia ulteriormente, non solo perché compete al piano l’individuazione e la disciplina di altri beni non ancora protetti (in particolare i cosiddetti “beni identitari” ed in genere i “beni culturali” di rilevanza anche paesistica) ma anche perché la tutela dei beni comporta spesso l’adozione di appropriate misure di disciplina d’uso o d’intervento per altre componenti non riconosciute, di per sé, come beni: è il caso, ad esempio, delle aree degradate da attività estrattive, o impegnate da attività agricole intensive, o minacciate da sviluppi urbanistici devastanti. A sua volta, questo inevitabile allargamento del campo d’attenzione costringe a mettere in discussione i modi, le forme e gli strumenti con cui conferire alle scelte di tutela e valorizzazione la necessaria efficacia. E’ del tutto evidente che, se la tutela rigorosa di alcuni pochi beni paesaggistici di particolare pregio (nell’ottica, per intendersi, della L 1497/1939) poteva essere perseguita – non senza innegabili successi – a suon di vincoli e limitazioni direttamente operanti, ben diversa è la situazione che si presenta quando l’opzione conservativa si allarga, come richiede la Convenzione, all’intero territorio. Alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia immediatamente operanti, occorre allora affiancare, in larga misura, indirizzi e direttive dirette ad una pluralità di soggetti istituzionali, cui compete la responsabilità di tradurle in disposizioni propriamente operative, alla luce dei necessari approfondimenti. Restando, le prescrizioni dirette, riservate ai casi in cui la salvaguardia degli irrinunciabili valori regionali non può essere adeguatamente assicurata a livello locale o in termini settoriali .L’azione di tutela si ramifica quindi in una molteplicità di misure di gestione e di controllo, che coinvolgono, in forme più o meno incisive, l’amministrazione pubblica a tutti i livelli e in tutti i settori, sollecitandone la cooperazione e ponendo crescenti esigenze di partecipazione sociale ai processi di formazione e validazione delle scelte. Da questo punto di vista, sembra innegabile che soltanto in un orizzonte autenticamente dialogico e cooperativo sia possibile conferire al PPR l’auspicata efficacia.
Riferimenti
- ANCSA, Un contributo italiano alla riqualificazione della città esistente. La Carta di Gubbio, Gubbio, 1990.
- R.Barthes, L’avventura semiologica, Einaudi, Torino, 1985.
- A.Berque, Les raisons du paysage, Hazan, 1985.
- G.Bertrand, L’image sociale du paysage: rationalité et irrationalité, Convegno su “Valori e interpretazione del paesaggio”, Istituto italiano di studi filosofici, Maratea 1998.
- Consiglio d’Europa, Convenzione Europea sul Paesaggio. Congr. poteri locali e regionali d’Europa, Firenze, 2000.
- R. Gambino, Conservare innovare: paesaggio, ambiente, territorio. Utet, Torino, 1997.
- R. Gambino, I paesaggi dell’identità europea, Prolusione a.a. 2004-2005, Politecnico di Torino, Torino 2004.
- ICCROM (International Center for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property), Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM, Rome, 1998.
- IUCN, Unione mondiale per la natura, Guidelines for Protected Area Management Categories, Gland, 1994.
- IUCN, Vth World Parks Congress: Benefits beyond Boundaries, Durban, 2003.
- IUCN, IIIth World Conservation Congress: People and Nature, only One World, Bangkok, 2004
- J. McHarg, Ecological Determinism, in “Future Environment of North America” (Darling and Milton ed.) The National History Press, Garden City, NewYork, 1966.
- C. Raffestin, Paysage et territorialité, Cahiers de Géeographie de Quebec, 21, 53-54, Quebec 1977.
- S. Schama, Paesaggio e memoria. Mondadori, Milano 1997 (1995).
- F. Steiner, Landscape as idea and as a framework for human adaptation, Rel.“Il senso del paesaggio”, Torino, 1998
- UE, Commissione Europea, Schema di sviluppo dello spazio europeo, Potsdam, 1999.
Il Paesaggio tra Coesione e Competitività
IL PAESAGGIO TRA COESIONE E COMPETITIVITÀ
PROVINCIA DI TRENTO/STEP 20/6/2011
Roberto Gambino
1.Paesaggi in pericolo
1.1. Il paesaggio, volto della società.
In una delle sue più intriganti parabole (citata da C.Magris, 1997), J.L. Borges parla di un pittore che si propone il compito di disegnare il mondo, ritrae i paesaggi più diversi e si accorge, alla fine, “che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto”. Il paesaggio è il volto di un uomo come della società, dei suoi vincoli fisici, delle sue vicende e delle sue speranze di vita. Le ferite del paesaggio, le sue cicatrici, i suoi difetti e le sue asimmetrie sono quelle stesse della società proiettate sul suolo. Il suo disfacimento riflette il disfacimento della società. Il paesaggio disegna il rapporto tra “vu” e “vecu”, tra ciò che si vede e ciò che è vissuto (Raffestin,1977).I mille paesaggi europei sono i mille volti dell’Europa. Le preoccupazioni per i paesaggi europei esprimono le tensioni sociali, politiche e culturali di un’Europa ancora in cerca di se stessa. Di un’Europa che cerca la propria identità non contro altre identità, ma contro “le proprie tentazioni, i propri demoni, i propri mostri” (A. Finkielkraut, 2003), nel dialogo, nell’inclusione e nella diversità. La difesa dei paesaggi europei non può in alcun modo disgiungersi da questa ricerca, non può in alcun modo ridursi ad un’operazione “cosmetica” o di “giardinaggio”, o ad un’operazione di razionalizzazione burocratica dei variegati sistemi nazionali di difesa dei segni superstiti del passato.
1.2. Il paesaggio, tra rischi emergenti ed ordinari.
E’ in questo senso complesso che il paesaggio è in pericolo. Ma le notizie e le immagini delle immani tragedie delle più diverse parti del globo sembrano travolgere ogni possibilità di approccio razionale, scientificamente orientato, alle grandi questioni dell’insediamento umano contemporaneo. Nonostante il clamore mediatico e la “domanda di verità” che accompagnano di regola le emergenze ambientali, è spesso troppo arduo o forse impossibile distinguere le questioni d’emergenza da quelle che si manifestano nel segno della quotidianità e dell’ordinarietà. Difficili, largamente inadeguati, i tentativi di cogliere i nessi che legano le catastrofi “naturali” all’opera più o meno consapevole e intenzionale dell’uomo. Non meno difficili i tentativi di riportare ad un’interpretazione unitaria gli esiti che si manifestano nei diversi settori dell’attività antropica, da quelli che riguardano le trasformazioni fisiche del territorio a quelli che riguardano l’uso ed i consumi delle risorse naturali, o le dinamiche sociali e culturali, o i processi economici e finanziari. E le difficoltà sono tanto maggiori quanto più all’interpretazione si tenta di associare la previsione, di anticipare il futuro. Ci si chiede se stiamo entrando “nell’età dei grandi rischi” (Scalfari 2011). Se non è casuale la concomitanza tra sommovimenti tellurici di inedita violenza, effetti disastrosi del cambio climatico globale (Kushner, 2011), drammatiche scosse d’assestamento geopolitico su scala internazionale, crisi economica globale ed esplosione della “bolla speculativa”. Non è certo questa la sede per rispondere a domande come queste. Ma, anche se si concentra l’attenzione sull’urbanistica e la pianificazione, non si può fare a meno di interrogarsi sui grandi cambiamenti che attraversano i territori della contemporaneità e sulle risposte che la cultura tecnica e scientifica ha elaborato o sta elaborando agli albori del terzo millennio. La “crisi della modernità” (Harvey 1990) consumata nel corso degli ultimi decenni aveva segnato la decadenza delle grandi narrazioni, delle idee di progresso e di giustizia sociale, delle questioni generali come quelle legate al controllo agli usi del suolo e delle risorse primarie. La frammentazione ecosistemica, prodotto perverso dell’urbanizzazione totale del territorio, sembrava trovare riscontro nella frantumazione del tessuto sociale e dei sistemi di relazione, nella estrema diversificazione degli interessi e delle domande sociali. E. di conseguenza, negare spazio alle interpretazioni unificanti, all’idea stessa che possa esistere un “interesse pubblico” cui riferirsi.
1.3. Il paesaggio e la crisi urbanistica.
Nel corso degli anni ’80, i dibattiti sulla crisi dell’urbanistica, caratterizzati dalla contrapposizione quasi caricaturale tra la cultura del piano e la cultura del progetto, sembravano destinati a smentire definitivamente l’efficacia sociale della pianificazione nell’interpretare l’interesse pubblico. Si osservava che “la domanda sociale a cui tradizionalmente gli urbanisti davano risposta [era] mutata, non più ‘questione generale’, ma problema di minoranze” (Mazza, 1990; Secchi 1990). Problemi d’ordine generale come quelli legati ai rapporti tra stato e mercato nella costruzione del territorio, e quindi al controllo dei valori del suolo, sembravano “rimossi dalle passioni e dagli interessi di buona parte degli urbanisti. L’attenzione di molti è piuttosto concentrata sulla questione della forma e del disegno della città”. Affascinata dai problemi dell’identità complessiva dell’urbs, la pianificazione sarebbe incapace di affrontare quelli della “frammentazione e l’articolazione della civitas e quindi la molteplicità delle forme secondo cui la nostra società tende ad autorappresentarsi”. Il contributo della pianificazione urbana e territoriale alla risoluzione della “questione urbana” su cui si era concentrata nei decenni precedenti la riflessione di studiosi come Castells, non senza potenti riscontri nei movimenti di base della società, sembrava indebolirsi; ed anzi la stessa questione - come questione, appunto, generale - sembrava perdere d’attualità e rilevanza nelle domande e nelle percezioni della società contemporanea.
1.4. La nuova questione urbana .
A più di vent’anni di distanza, ci si può chiedere se queste osservazioni siano ancora valide, o se invece la “nuova questione urbana” (Secchi 2011) – sempre più strettamente incrociata con la multiforme “questione ambientale” - costituisca ancora o nuovamente il quadro problematico con cui la pianificazione deve confrontarsi. E se l’uscita dalla crisi che sembra pervadere le nostre città e i nostri territori richieda la costruzione di un quadro interpretativo ampio e comprensivo: un quadro nel quale si possa tentare di situare coerentemente i grandi problemi della società contemporanea, da quelli che concernono le trasformazioni fisiche del pianeta a quelli che riflettono la radicalizzazione delle diseguaglianze economiche e sociali, le carenze ed il degrado delle condizioni abitative, la crescente mobilità delle popolazioni, delle attività e delle idee. In altre parole, dobbiamo chiederci se e come la cultura della pianificazione (in termini di statuti scientifici e competenze disciplinari, di capacità tecniche professionali, di apparati amministrativi, di strumenti giuridici e di quadri istituzionali, ma anche di attitudini e sensibilità culturali) possa oggi tradurre “le preoccupazioni individuali in questioni pubbliche” (Bauman, 2008). Si impone un cambio di prospettiva, per passare da una visione patrimoniale statica e inventariale – quale quella che ha orientato e tuttora in larga misura orienta l’azione di tutela del patrimonio culturale e naturale (Choay 1993) - a una visione dinamica e strutturale, in grado di cogliere le drammatiche criticità e l’attualità del territori. E’ una visione che sconta l’impossibilità di archiviare l’eredità storica nelle memorie e nei reperti del passato e spinge invece a riconoscere l’attualità del territorio storico nella sua incessante contemporaneità con la cultura della società che lo abita e lo produce. Una visione che, incrociando più vaste riflessioni sulle dinamiche della società contemporanea, ha aiutato a comprendere la (ri)scoperta del territorio come risorsa a rischio di perdita e di degrado, ma anche come insostituibile fondamento dell’azione politica e culturale.
-
Identità, valori e diritti.
2.1. Il paesaggio, fondamento dell’identità.
Nelle nuove retoriche che impregnano il discorso pubblico sul territorio contemporaneo, ha assunto grande rilievo il tema dell’identità, non a caso introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio nella definizione stessa del paesaggio, concepito non solo come esito dinamico dell’interazione tra fattori antropici e naturali, ma anche come “fondamento dell’identità” (art.5). Definizione che ha avuto largo riscontro nelle pratiche discorsive e progettuali degli ultimi decenni, in cui il paesaggio è stato spesso la bandiera della difesa e del rafforzamento delle culture e delle economie locali, anche in funzione di resistenza alle spinte omologanti della globalizzazione. In quanto sistema di valori identitari, il paesaggio interpreta non solo le peculiarità, i caratteri e le differenze del territorio, ma anche le sue potenzialità evolutive. Di qui l’importanza crescente attribuita al paesaggio ai fini della difesa della biodiversità ed ancor più della “diversità bio-culturale”, su cui l’Unesco e l ‘Unione mondiale della natura hanno ancora recentemente richiamato l’attenzione. Di qui anche il tentativo di contribuire, con le politiche del paesaggio, alla riscoperta e alla valorizzazione delle culture, delle agricolture e delle economie locali (basti pensare al successo di “slow food” e delle produzioni “a km zero”), ponendolo al centro del marketing urbano e territoriale. Tuttavia, a dispetto dell’enfasi sul paesaggio e sulla sua funzione identitaria, il concetto stesso di identità è stato oggetto di critiche crescenti. Da un lato infatti le rivendicazioni identitarie non hanno mancato di mostrare tendenze regressive, chiusure “autistiche” e derive nostalgiche nelle gabbie delle tradizioni. A tutte le scale, da quelle locali a quelle planetarie, si è avanzata minacciosa l’ombra delle identità “armate” o “bellicose” (Amartya Sen., 2006.). Dall’altro lato, il “salto di scala” di un numero crescente di problemi ambientali, economici e sociali (sempre meno trattabili a scala locale, sempre più richiedenti azioni e apparati di controllo a livello regionale, nazionale e soprattutto internazionale), ripropone i grandi temi dell’integrazione trans-scalare delle azioni pubbliche di regolazione, dei grandi racconti e delle “big pictures”su cui si fondano le strategie d’insieme Emblematico, in questo senso, il tema del “global change” e dello sconfinato insieme di attività e di politiche che dovrebbero contrastarne o mitigarne gli effetti più drammaticamente negativi.
2.2. Verso una nuova territorialità del paesaggio.
I cambiamenti di scala dei problemi da fronteggiare mettono in scacco le distorsioni identitarie poiché riguardano non soltanto i cambiamenti reali del mondo contemporaneo, ma anche i modi con cui li osserviamo, le concezioni, i miti e le utopie che guidano le nostre analisi e le nostre scelte. Non possiamo evitare di misurarci coi processi emergenti, ma “per farlo dobbiamo poterli riconoscere. E per riconoscerli capire quanto sta accadendo” (Hillman, 2011). A questo fine l’approccio “territorialista” – quale quello proposto dalla “Società dei territorialisti”: Magnaghi 2010 - ha svolto e può svolgere un ruolo significativo. “Questo approccio ha posto al centro dell’attenzione disciplinare il territorio come bene comune, nella sua identità storica, culturale, sociale, ambientale, produttiva, e il paesaggio in quanto sua manifestazione sensibile […]. Il ritorno al territorio come culla e risultato dell’agire umano esprime e simboleggia la necessità di reintegrare nell’analisi sociale e quindi anche economica, gli effetti delle azioni umane sulla mente umana e sull’ambiente naturale, sempre storicamente e geograficamente determinati”. Il territorio, dunque, non come inerte supporto delle attività antropiche, ma come sistema costitutivo delle relazioni che esse intrattengono con le dinamiche naturali. E' in questo contesto complesso e problematico che va concentrata la ricerca di una nuova territorialità, gravida di memorie e di consapevolezza ambientale, sullo sfondo di un'evoluzione del pensiero scientifico contemporaneo che sembra mutare il senso della presenza umana nel mondo.
-
Coesione e competitività.
In questa ricerca il riferimento alla dimensione locale è fondamentale. Una dimensione che evidenzia le identità e i caratteri su cui riposa la diversificazione del territorio, senza vincoli di scala. Che crea i paesaggi, con visione dinamica e trans-scalare, con collegamento incessante alle percezioni, alle attese ed ai progetti degli abitanti. ma i luoghi non sono frammenti autonomi e indipendenti, non sono mondi separati, sono “schegge del mondo” (Magris, 1997). La loro capacità di conservare i propri caratteri identitari dipende, non meno che dalle “chiusure operative” dei sistemi locali, dall’”apertura” verso il cambiamento e quindi dalla loro capacità di affacciarsi efficacemente sulle reti di relazioni che agiscono nel contesto territoriale, alle diverse scale. In entrambe le direzioni il paesaggio svolge un ruolo fondamentale. Da un lato esso lega fatti, luoghi e attività tangibili e intangibili, variamente dislocati nello spazio territoriale, in contesti tendenzialmente coesi, in cui le comunità locali possono riconoscersi ed interagire più o meno efficacemente. Il dispositivo paesistico è riflesso e strumento di coesione ecologica, economica, sociale e culturale, atto a rafforzare le capacità di resistenza e resilienza dei sistemi locali nei confronti delle pressioni e delle perturbazioni provenienti dall’esterno. Ma nel contempo il paesaggio è anche riflesso e strumento di competitività, nella misura in cui conferisce ai sistemi locali un’immagine caratterizzata e riconoscibile, che gli consente di partecipare con speranza di successo ai confronti che si profilano a tutti i livelli, mobilitando insiemi strutturati di risorse diversificate, dando voce al “territorio degli abitanti” o investendo nel marketing urbano e territoriale.
2.4.. Nuovi sistemi di valori potenzialmente in conflitto
La tutela del paesaggio, come quella della natura, ha a che fare con l’affermazione di sistemi di valori; ma i sistemi di valori non sono gli stessi. Contano, nel secondo caso, valori riconosciuti e presidiati dalle “scienze dure” (come la geologia o la biologia), in termini tali da quasi annullare ogni possibilità di scelta circa le misure di tutela da adottarsi. Tra il riconoscimento oggettivo e scientificamente inoppugnabile del valore e la scelta dei modi con cui proteggerlo, si profila una relazione stringente, al limite deterministica. Nel primo caso, la tutela del paesaggio, entrano in gioco valori di assai più incerta determinazione, che lasciano ampi spazi all’interpretazione e alla valutazione soggettiva, nonostante il poderoso ausilio delle scienze sociali, in primo luogo la storia. La labilità e la soggettività che ne derivano, in ordine alle misure di tutela e di gestione, sono state esplicitamente riconosciute dalla stessa Convenzione Europea del Paesaggio, che impegna le parti a tener conto, nella valutazione dei paesaggi, “dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate”(art.5). Questa distinzione non è peraltro rigida. Anche nel campo della conservazione della natura si è fatta strada una concezione più socialmente sensibile dei valori in gioco; mentre la stessa oggettività scientifica delle valutazioni è sempre più spesso revocata in dubbio (basterà ricordare l’aspra contesa che attraversò il mondo scientifico quando si trattò di scegliere la miglior strategia d’intervento, a fronte dello spaventoso incendio che devastò il Parco di Yellowstone qualche anno fa) E inversamente il determinismo ecologico (a partire dalla svolta degli anni ’60: McHarg 1966) ha profondamente impregnato la cultura del paesaggio, dietro le bandiere della Landscape Ecology.. Piuttosto che suggerire una biforcazione tra sistemi diversi di valori, l’esperienza sembra indicare l’intrinseca problematicità della identificazione dei valori, sia nel campo della conservazione della natura che in quella del paesaggio.
2.5. Principi e diritti
Il riconoscimento dei valori naturali e culturali, in particolare di quei valori che il mercato ignora o contrasta, è alla base delle lunghe lotte per il “diritto alla città” (Lefebvre 1970) e per la costruzione dello “stato sociale”, rese oggi più aspre dall’emergenza dei fenomeni d’immigrazione e dalle nuove iniquità sociali. Ma il riconoscimento di quei valori porta anche all’affermazione di nuovi diritti e di nuovi doveri, come quelli che in Italia si richiamano all’art. 9 della nostra Costituzione. Accordi e trattati internazionali hanno sancito una progressiva dilatazione dei “diritti ambientali”, fra cui quelli che – come tipicamente i “diritti all’esistenza” di beni ambientali irrinunciabili, in primis l’acqua - riflettono interessi collettivi trans-generazionali. Nel contempo si è ampliata la gamma dei “diritti di cittadinanza”, che riguardano ormai pacificamente anche valori “intangibili” come quelli estetici o letterari. Può sembrare ironico nel nostro paese, che ha lasciato gran parte delle proprie coste, dei propri paesaggi agrari, delle proprie montagne e dei propri centri storici alla mercè della speculazione immobiliare (e che anzi sembra tuttora assecondarne le spinte in nome dello sviluppo economico) pretendere il rispetto dei “diritti alla bellezza”: un lusso che secondo molti non possiamo permetterci. Ma non si può ignorare che sotto quella bandiera si stanno aggregando consistenti ed agguerriti movimenti d’opinione e coalizioni di interessi..Se si accetta l’idea che le politiche della natura e del paesaggio non possano prescindere dai nuovi diritti di cittadinanza, non si può evitare di chiedersi come assicurarne la concreta attuazione, tenendo conto della pluralità, della variabilità e dell’intrinseca conflittualità degli interessi e dei valori in gioco. Una conflittualità che certo non si limita allo scontro tra generici interessi pubblici ed interessi privati, ma contrappone sempre più spesso, come riportano le cronache, diversi interessi pubblici antagonisti. Perché e a quali condizioni il riconoscimento di un paesaggio urbano storico di grande rilievo o di un’impareggiabile paesaggio agrario deve impedire la realizzazione di un grattacielo per uffici pubblici o di una piattaforma logistica o di un grande complesso ospedaliero? Per sfuggire alle insidie del relativismo e reagire all’”indietreggiamento dei valori universali” (Touraine 2008.) si invoca l’accettazione di gerarchie di valori. Ma la battaglia sui valori assoluti sembra difficilmente riconducibile alle logiche del confronto democratico aperto ed inclusivo. Se ciascuna delle parti in conflitto si trincera dietro al proprio sistema di valori, l’esito del confronto non può che essere quello di una sopraffazione più o meno violenta e, si può aggiungere alla luce dell’esperienza, tendenzialmente a danno degli interessi pubblici più deboli, come quelli paesistici e ambientali. Di qui l’opportunità, nello spirito della Costituzione, di “ragionar per principì”, sostituendo alla logica dell’imposizione la logica della persuasione (Zagrebelsky 2009). E’ su questo terreno che può fondarsi la ricerca delle più opportune forme di regolazione pubblica dei processi che modellano il paesaggio.
2.6. Regolazione versus percezione?
Il relativismo dei valori e delle poste in gioco pone in grande evidenza il ruolo della percezione, riferimento imprescindibile (secondo la Convenzione) per la definizione delle politiche e per gli stessi riconoscimenti di valore. Apparentemente la percezione e la regolazione rappresentano due prospettive antitetiche. Da un lato, le percezioni paiono dominate dalla mutevolezza e instabilità delle condizioni dell’osservazione sensoriale (al variare della posizione dell’osservatore, al trascorrere delle stagioni, delle ore del giorno e del tempo atmosferico), dalla soggettività dei filtri culturali che ne condizionano la fruizione, delle sensibilità e delle conoscenze pregresse che mediano il processo percettivo. E’ in gioco la semiosi stessa del paesaggio, la sua apertura nei confronti dei processi di significazione, mai riducibili ad un sistema “dato” ed immutabile di segni oggettivamente riconoscibili e condivisibili. (Castelnovi 2000).
Dal lato della regolazione, la prospettiva sembra mutare radicalmente. Cambiano le ragioni, gli interessi e le poste in gioco, le modalità dell’intervento umano sui processi di trasformazione. Alla base, si situa il riconoscimento del paesaggio come bene comune, ormai esteso dai paesaggi eccezionali al paesaggio come bene di valore intrinseco e ubiquitario. L’ampia definizione della Convenzione Europea tende a sussumere l’insieme degli interessi collettivi largamente condivisi: da quelli ecologici a quelli economici e sociali direttamente connessi al benessere e “ben vivere” delle popolazioni locali e alle prospettive di sviluppo, a quelli antropologici e culturali in cui si esprimono i valori identitari locali, nazionali e mondiali.
Il riconoscimento di tali interessi implica un’affermazione di valori che si contrappone almeno in parte alle tendenze in atto, alle dinamiche di mercato, al trionfo degli interessi particolari suscettibili di pregiudicarne l’integrità o la fruibilità. Questa affermazione richiede quindi un’azione di sostegno e di difesa da parte dell’amministrazione pubblica, atta a configurare una “regolazione” dei processi trasformativi volta ad impedirne gli effetti indesiderabili e a incentivare quelli sinergici e positivi .Nel contempo la regolazione pubblica dei processi rischiosi è tanto più “democraticamente” legittimata quanto più i riconoscimenti di valore si traducano in diritti e doveri proclamati a livello nazionale o internazionale.; è il caso di molti diritti ambientali, come tipicamente i “diritti all’esistenza” di determinate risorse inalienabili (come l’acqua) che rispondono ad interessi collettivi trans-generazionali. L’approccio “a partire dai diritti” sta guadagnando terreno nel dibattito sulla conservazione del paesaggio, in stretto rapporto con quello riguardante la natura, sostenuto particolarmente dall’ IUCN. Non ci si può nascondere che queste designazioni a livello nazionale e sovranazionale possono entrare in collisione con visioni locali più attente agli interessi (di pochi) piuttosto che ai diritti (di tutti).
3. Conservazione e innovazione.
3.1.. Conservazione e innovazione, un rapporto inscindibile
Negli ultimi decenni il principio di conservazione ha conosciuto una sconcertante dilatazione del campo d’applicazione e del suo stesso significato, non senza ambiguità e contraddizioni. Sia nei confronti della natura che del patrimonio culturale, la conservazione si è progressivamente staccata da concetti come quelli di “preservazione”, salvaguardia, tutela passiva, implicanti il riconoscimento di una condizione di immodificabilità non perfettibile, per lasciare spazio a forme più o meno complesse di trasformabilità, gestione dinamica, attenta amministrazione (Passmore 1986), cura e innovazione. Sebbene la nuova concezione recuperi importanti lezioni del passato, come il conservazionismo di Marsh (1864) o di Leopold (1933), essa si nutre di riflessioni attuali. Da un lato, la constatazione che, più che in passato, non può darsi autentica e durevole conservazione che non comporti trasformazione innovativa (“non si possono separare le cose dal loro divenire”: Tiezzi 1999; “il cambiamento fa parte inscindibile della biosfera”: Botkin 1990). Ogni intervento sul patrimonio culturale implica tensione innovativa, quanto meno nel ridar senso alle cose; e, d’altro canto, non si fronteggiano efficacemente i rischi e le minacce derivanti dai cambiamenti globali senza “adattamenti” innovativi (Adams, 1996). Ma dall’altro lato e simmetricamente, la presa d’atto che ogni autentica innovazione nel mondo contemporaneo implica il confronto con una ingombrante eredità naturale e culturale, con sistemi complessi di “provenienze” (Petz, 2004) e di memorie (Schama, 1997), che non c’è oblio senza memorie, e che la gestione innovativa degli attuali ecosistemi non può prescindere dalla loro storia precedente (Botkin, 1990). In sintesi, la conservazione si configura sempre più come “luogo privilegiato dell’innovazione”, (ANCSA, “Carta di Gubbio”, 1990),. La conservazione innovativa, lungi dal potersi interpretare come un indebolimento delle opzioni di tutela, implica un impegno rafforzato per la cura dell’eredità territoriale e per la sua trasmissione alle future generazioni (Gambino, 1997).
3.2. La dilatazione dell’opzione conservativa
Ma il cambiamento di senso del principio di conservazione è tanto più rilevante in quanto è stato accompagnato da una vera e propria esplosione del suo campo d’applicazione, sia nei confronti della natura che del paesaggio e del patrimonio culturale. Per la conservazione della natura, il cambiamento forse più emblematico riguarda le “aree naturali protette” ed i loro rapporti coi territori circostanti. La ricerca di forme di protezione e di valorizzazione estese a tali territori (secondo lo slogan del Congresso IUCN di Durban, 2003: “Benefits beyond Boundaries”: benefici al di là di ogni frontiera), di politiche conservative “a scala di paesaggio”, di pianificazione ecosistemica per eco-regioni, di “messa in rete” di ampi sistemi di aree protette variamente caratterizzate, trova un’ispirazione comune nel nuovo modo di intendere il principio di conservazione. Analoga dilatazione si è prodotta in rapporto al patrimonio culturale, con lo spostamento d’attenzione, (che trova emblematica testimonianza nell’evoluzione del pensiero dell’ANCSA: Gabrielli, 1997) dai “monumenti” ai centri e agli insediamenti storici, al territorio storico nella sua interezza. Anzi questo spostamento di senso, dal monumento al patrimonio, è strettamente connesso – nei discorsi che da anni studiosi come Francoise Choay (2008) vanno sviluppando - alla “mondializzazione della salvaguardia del patrimonio storico”, ossia al riconoscimento internazionale che “non possiamo più permetterci il lusso di lasciarlo andare in rovina”. Ancora più esplicito, è appena il caso di ricordare, lo spostamento riguardante il paesaggio, espresso nella Convenzione Europea del Paesaggio, che sancisce l’obbligo di riconoscere valenza paesistica a tutto il territorio, applicando misure diversificate di salvaguardia, gestione e pianificazione. Sotto tutti questi profili – ed in contrasto, beninteso, con gran parte degli apparati e delle pratiche tradizionali di controllo e tutela- si afferma l’irriducibilità del principio di conservazione a singoli “pezzi”del patrimonio naturale-culturale staccati dal contesto; o in altre parole, l’impossibilità di dividere il patrimonio territoriale in parti da conservare e parti da lasciare alla mercè delle spinte trasformatrici .
3.3. Il rapporto natura-cultura.
In questa prospettiva, il rapporto tra natura e cultura svolge un ruolo cruciale, tutt’altro che scontato. Respinte le schematizzazioni meno sostenibili (come la divisione dicotomica del territorio in spazi naturali e spazi antropizzati: divisione che tuttavia ricorre ancora non solo nelle politiche dei parchi e delle aree protette "insularizzate", ma anche in molte politiche territoriali volte a contrastare con misure di esclusione i consumi dissennati di territorio) occorre riconoscere che la discussione è aperta, sul piano teorico non meno che politico ed operativo. Occorre da un lato de-naturalizzare le scelte di trasformazione antropica, troppo spesso occultate da generici richiami agli eventi naturali (le false emergenze naturali che coprono autentiche "calamità pianificate" e logiche devastanti di gestione "emergenziale" del territorio, ma anche quelle interpretazioni strutturali di piani urbanistici e territoriali che confondono il "dato" col progetto). Dall'altro occorre, dopo la svolta ecologista della metà del secolo scorso e le sue ricadute deterministiche (McHarg 1966), ricostruire i rapporti tra naturalità, ruralità e urbanità, riconoscendone la compresenza pervasiva in ogni angolo del pianeta. Si configura un radicale superamento di quella contrapposizione tra natura e cultura che ha svolto un ruolo centrale nella civiltà occidentale in età moderna, a partire dalle grandi utopie rinascimentali. Se ancora alla fine dell’800 Ebenezer Howard (1898) poteva proporre con la teoria dei tre magneti e l’idea della “Città giardino” una sintesi creativa, i grandi cambiamenti del secolo scorso (come l’industrializzazione dell’agricoltura o l’urbanizzazione “totale” dello spazio abitabile e la reciproca contaminazione dei rispettivi spazi dedicati) hanno messo fuori gioco i tradizionali modelli interpretativi e sollecitato l’elaborazione di nuovi rapporti.
3.4. Le responsabilità antropiche nelle dinamiche naturali.
Si afferma faticosamente una crescente consapevolezza delle responsabilità antropiche nella determinazione o nell’aggravamento dei rischi, delle calamità e del degrado ambientale, mentre i “nuovi paradigmi” che si profilano a livello internazionale (IUCN 2003) legano ormai ogni prospettiva di conservazione della natura alla promozione e regolazione dello sviluppo culturale, economico e sociale sostenibile. Da un lato l’enfasi sull’impegno internazionale per la difesa della bio-diversità concede uno spazio crescente all’importanza della diversità bio-culturale, ostaggio dei processi di urbanizzazione totale ma mai indipendente dalle dinamiche naturali (Unesco 2009). E’ questa la diversità che costituisce la ricchezza (il “capitale”) su cui basare lo sviluppo sostenibile del territorio. E d’altro canto non si può certo ignorare il significato culturale connesso all’utilizzazione antropica delle risorse naturali, alla fruizione, alla percezione e all’apprezzamento individuale e collettivo dei paesaggi e delle “bellezze naturali”. Già la scoperta humboldtiana del “nuovo mondo” (von Humboldt, 1860), come l’”invenzione” sette-ottocentesca delle Alpi, orientano gli sguardi e umanizzano irreversibilmente il mondo naturale, anche in assenza di rilevanti trasformazioni fisiche. Soprattutto nei territori europei in cui più densa e pervasiva è stata la sedimentazione culturale, la naturalità con cui abbiamo a che fare è quella storicamente determinata dalle vicende pregresse dell’appropriazione antropica dello spazio: non solo da quella che ci ha lasciato un patrimonio ammirevole di paesaggi culturali, ma anche dalle spinte omologatrici che hanno investito la campagna, ipersemplificato e banalizzato i paesaggi agrari ereditati da secoli di storia, piegato le dinamiche naturali alle logiche, spesso indecifrabili, dell’espansione urbana e della dispersione insediativa, smantellato i reticoli ecologici (fossi, canali, siepi ed alberate, ecc.), presidio prezioso della diversità paesistica e della stabilità ecosistemica. (Gambino 2000). Negli scenari che si vengono delineando a livello globale, la naturalità così “storicizzata” non è in alcun modo confinabile in “aree naturali” sottratte (illusoriamente) all’influenza antropica, ma incrocia ovunque l’opera dell’uomo, sia che essa si allei assecondandole con le dinamiche naturali, sia che le contrasti in forme più o meno calamitose.
3.5. Valori locali e valori universali.
Negli scenari internazionali anche il riferimento prioritario ai sistemi di valori sovra-locali è oggi in discussione. Da un lato infatti l’indietreggiamento dei valori universali, minacciati od aggrediti dagli attuali modelli di sviluppo, spinge a misure esemplari di tutela, quali quelle accordate ai siti inseriti nel World Heritage. Ma dall’altro lato, la rivalutazione dei sistemi locali e delle ragioni dello sviluppo locale, soprattutto in situazioni di marginalizzazione o di declino, trova riscontro nella riaffermazione dei valori identitari locali, visti spesso dalle comunità perdenti come le “radici del proprio futuro”. E’nei sistemi culturali locali che si radicano i valori universali, come dimostrano le ricerche e i dibattiti che hanno accompagnato varie esperienze di riconoscimento di Siti Unesco, compresa quella recente, relativa alle Dolomiti: inserite come “sito naturale” ma per ragioni che richiamano esplicitamente la rilevanza dei patrimoni culturali locali. Tra i valori locali e i valori universali sembra così delinearsi un rapporto di complementarietà, o più precisamente di forte interazione, che non cancella la possibilità di conflitti e di contraddizioni. (Gambino 2010). Pensata come un argine contro la perdita o la regressione dei valori universali, la difesa del migliaio di siti del World Heritage sparsi in tutti i continenti sembra spesso portare piuttosto il vessillo di “peculiari” valori locali, capaci di competere vantaggiosamente sull’arena globale. Non a caso le battaglie politico-culturali per le “nominations” dei Siti da inserire nelle liste Unesco sono sempre più spesso ingaggiate in nome del rilancio e del consolidamento di culture e di paesaggi locali (come tipicamente nel caso dei paesaggi viticoli francesi od italiani).
4. La riarticolazione della centralità urbana.
4.1. Luoghi e reti, metafore complementari.
La tensione tra valori naturali e culturali, tra valori locali e universali, evoca inevitabilmente il rapporto tra i luoghi e le reti, da tempo pensati come metafore complementari, per l’interpretazione e il progetto dei territori della contemporaneità (Gambino1994?). Esse possono aiutare a riconoscere la “territorialità del paesaggio” nell’ampio significato attribuitogli dalla Convenzione Europea. E’ nel paesaggio, quale risulta dall’incessante interazione delle dinamiche antropiche e naturali, che l’insediamento storico prende il suo pieno significato, di storicità ed attualità. E’ nel paesaggio che i centri storici dialogano non solo con la campagna “edificata” (per usare le parole di Cattaneo, 1845), nel corso dei secoli e dei millenni dalle reti agrarie, dai sistemi delle acque e dai sistemi della viabilità e delle infrastrutture, ma anche con la presenza mobile della natura, che, riluttante ad ogni confinazione, pervade e diversifica gli spazi che circondano le aree in vario modo costruite. Nonostante i processi di urbanizzazione diffusa, la proliferazione delle maglie infrastrutturali e la stessa “modernizzazione” della pratiche colturali – soprattutto nell’ultimo mezzo secolo - abbiano profondamente ed estesamente intaccato i paesaggi ereditati dal passato, frantumandone i reticoli connettivi e i caratteri identitari, è ancora in quei paesaggi e nella loro coerente evoluzione che si può tentare di recuperare la qualità, la bellezza e la riconoscibilità dei territori contemporanei. La ricostruzione di migliori equilibri ecologici e di più accettabili condizioni di sicurezza nel quadro di vita delle popolazioni, non meno che la ricerca di nuovi fondativi rapporti coi luoghi, trova nella diversità dei paesaggi un’espressione fondamentale. Ma anche, inversamente, la piena considerazione dei nuovi significati dell’urbanità conmporanea spinge ad interpretarli nel quadro della reinvenzione dei paesaggi della modernità. La chiave paesistica offre un ausilio potente per orientare il progetto di territorio al riconoscimento delle nuove forme del rapporto tra cultura e natura: passo obbligato per migliorare la qualità complessiva offerta agli abitanti non meno che ai turisti e ai visitatori.
4.2. Il paesaggio urbano storico.
Nel panorama internazionale e soprattutto europeo, è il paesaggio urbano, ove si compongono forme propriamente urbane con frange peri-urbane di “campagna urbana” (Donadieu 2006), ad attrarre sempre più (come già rilevava il Memorandum di Vienna nel 2005) visitatori, residenti e capitali. Nella transizione verso la società della cultura e della conoscenza, e a fronte delle spinte omologanti determinate dai processi di globalizzazione, il ruolo della città è sempre meno affidato alle relazioni strettamente economiche e funzionali (le funzioni “centrali” del terziario e del quaternario) e sempre più alle relazioni simboliche, alle immagini identitarie e alle dinamiche “intangibili”. E’ soprattutto su queste che fanno leva le politiche di marketing con le quali città e territori cercano di affrontare con speranze di successo le sfide competitive che si profilano a livello internazionale. E’ su queste che recenti documenti (Unesco 2009) richiamano l’attenzione, sottolineando il ruolo complesso che la “messinscena” paesistica svolge combinando le immagini durevoli della città storica con le suggestioni delle nuove architetture che ne ridisegnano i rapporti col contesto extraurbano. Le tensioni che ne derivano non sono certo esenti da equivoci e contraddizioni. Come dimostrano le aspre contese che hanno accompagnato la “verticalizzazione” di tante città europee (i grattacieli di Londra o di Parigi o di Milano) è evidente il rischio che proprio le nuove immagini della “modernizzazione urbana”, prendendo le distanze dall’eredità storica dei singoli paesaggi urbani e mettendosi al servizio degli stessi meccanismi speculativi che dominano il mercato immobiliare, ne configurino paradossalmente la sostanziale omologazione. In prospettiva internazionale, il rischio che i sogni della “città europea”, orgogliosamente contrapposta alla “città americana” per la complessità della sua stratificazione storica, cancellino ogni attenzione per i caratteri distintivi, le regole di coerenza e le qualità specifiche dell’urbanità contemporanea.
4.3. Nuova centralità e diritto alla città.
E’ questa la posta in gioco: la centralità urbana e il suo significato per la società contemporanea, come livello specifico dell’urbanità, essenza ultima di quel “diritto alla città” su cui si svilupparono le lotte urbane degli anni ’70; ma nuovamente al centro della domanda sociale di città e di memoria. E’ il caso paradigmatico dell’Aquila, dove l’urgenza dei nuovi interventi sostitutivi per i “terremotati” ha gettato nell’ombra l’esigenza di recuperare la città storica e i suoi valori socioculturali, appassionatamente propugnata dai suoi abitanti. In prospettiva internazionale, la crisi delle politiche “centriste” (emblematizzate dalle new towns e dalle villes nouvelles) concorre a mettere in discussione l’idea che soltanto lo spazio della convergenza e dell’aggregazione fisica – la piazza – possa ospitare i valori di centralità e che al contrario gli spazi aperti, la campagna e gli spazi della “dissoluzione urbana” vi si oppongano dialetticamente. Questa discussione ha particolare rilevanza per i centri storici. Essa ne investe anzitutto il ruolo “centrale” sotto il profilo economico-funzionale, sociale e culturale, nell’ambito dei rapporti tra città compatta e città diffusa. Rapporti assai più problematici di quanto non emergesse nelle critiche alla dispersione urbana dei decenni scorsi, che vanno ripensati a fronte dell’emergere della città “reticolare” (Dematteis 1995, Gambino 2009), preludio forse di nuove più complesse forme di metropolizzazione (Indovina 2010), In queste nuove configurazioni urbane i grandi eventi prendono sempre più spesso forma fuori dei luoghi tradizionali, la quotidianità si appropria di spazi inconsueti, i giovani reinventano continuamente gli spazi della creatività. Ma la discussione investe anche l’altro termine del concetto di centro storico, la sua storicità, negandone in radice la possibilità di ancorarla a precise e stabili delimitazioni spaziali. La riarticolazione della centralità urbana non riguarda pezzi di città o brani staccabili di territorio, ma il territorio storico nella sua complessità.
5. Il nuovo ruolo degli spazi liberi
5.1. Riportare la natura in città.
Nella città e nel territorio storico contemporaneo, dentro o ai bordi dello spazio “costruito”, gli spazi liberi sono sempre meno interpretabili con la metafora ambigua del ”verde urbano”, sempre più spesso teatro della nuova fenomenologia urbana. Teatro che non si racchiude nei confini stabili dell’urbano, poiché si ramifica dinamicamente nelle reti territoriali, che entrano ed escono dalla città compatta (tipicamente con le fasce fluviali e i sistemi delle acque), la attraversano e la legano al contesto territoriale. In questo quadro la “rinaturalizzazione” della città, oggetto di politiche urbane e territoriali ricorrenti a livello internazionale, può assumere un significato nuovo e diverso. Va pensata non tanto per concedere al verde qualche metro in più, quanto per riportare la natura in città restituendole la pienezza di quel significato ecologico, storico e culturale, che traspare vividamente dall’iconografia storica. Gli sforzi che in tante città europee a cominciare da Londra si stanno facendo per ripensare e attualizzare l’idea delle “cinture verdi”, nelle nuove prospettive della città reticolare diramata sul territorio, testimoniano la difficoltà di individuare nuove logiche organizzative, capaci di integrare spazi aperti e spazi chiusi, paesaggi urbani e paesaggi rurali, dinamiche insediative e dinamiche ambientali. In questa direzione le politiche di conservazione della natura e del paesaggio sembrano destinate a sfidare la cultura urbanistica, costringendola ad uscire dai suoi recinti tradizionali (legati più o meno rigidamente all’ambiente costruito) per assumersi nuove più pesanti responsabilità in ordine alla realizzazione dello spazio pubblico e dello stato sociale.
5.2. Dalle reti ecologiche alle infrastrutture ambientali.
D’altronde, nell’esperienza europea la costruzione delle reti ecologiche – per contrastare o ridurre la frammentazione ecologica e paesistica del territorio, restituendogli un minimo di connettività e di permeabilità, soprattutto nelle grandi aree urbanizzate – ha già assunto scopi diversi e più complessi di quelli, strettamente biologici, originari (Ced-Ppn, 2008). Nella città reticolare che si profila nei nuovi orizzonti urbani, le reti di connessione non possono avere solo funzioni biologiche, di collegamento tra habitat e risorse naturali che rischiano l’insularizzazione, ma assumono inevitabilmente un significato più denso e complesso, che integra natura e cultura collegando risorse e valori diversi. Si avverte sempre più l’esigenza di realizzare nuove “infrastrutture ambientali” capaci di innervare l’intero territorio, svolgendo un ruolo di sostegno non meno importante di quello tradizionalmente assegnato alle reti dei trasporti, delle comunicazioni o dell’energia. Ma questa esigenza non si manifesta solo “in uscita” dalla città, vale a dire verso i territori della dispersione insediativa e dell’espansione urbana, ma anche “in entrata”, vale a dire nelle maglie della città compatta. L’interesse crescente per i programmi di rigenerazione volti a riportare la natura in città (“greening the city”), per i progetti di recupero e riqualificazione delle fasce fluviali e per i sistemi delle acque storicamente consolidati, per il riuso non meramente immobiliare dei “vuoti urbani” e delle grandi aree dismesse, segnala il maturare di una nuova consapevolezza dei grovigli di deficit che occorre rimuovere.
5.3.Collegare tutela e valorizzazione.
Lungi dal potersi rinchiudere in orizzonti settoriali, in pratiche “cosmetiche” o in pericolose politiche d’emergenza, la conservazione innovativa della qualità del territorio richiede strategie lungimiranti d’intervento strutturale e preventivo, che guardino non solo alle “eccellenze” ma all’insieme del territorio; è questo che va salvato e valorizzato, non i singoli “oggetti” che ospita. Le nuove visioni che caratterizzano gli scenari internazionali, i nuovi paradigmi che dovrebbero guidare la conservazione della natura, le prospettive reticolari che si profilano nelle città e nei territori contemporanei, sollecitano strategie diramate e complesse, trans-scalari e pluri-settoriali. Calamità falsamente naturali e tragedie ambientali quotidiane ribadiscono la necessità e l’urgenza di collegare la tutela e la valorizzazione delle città e dei centri storici, dei paesaggi e del patrimonio culturale al rispetto della natura e del contesto ambientale, oggi oggetto di politiche largamente, drammaticamente separate. Convergono, nella crisi che attraversiamo, cause diverse, che attengono all’indebolimento e alla inadeguatezza degli apparati istituzionali e di governo, ma anche alla scarsa fiducia negli atteggiamenti cooperativi, nelle possibilità di partnership e di collaborazione inter-istituzionale: anche quando, come nel nostro paese, la “leale collaborazione”tra le istituzioni di governo è esplicitamente richiesta dalla stessa Costituzione. Si determina quindi una difficoltà insuperabile nella costruzione di quella “intelligenza collettiva” dell’impresa, della politica e del progetto (SIU, 2011) che costituisce una condizione indispensabile per affrontare con speranza di successo le sfide del territorio.
5.4. Integrare politiche della natura e politiche del paesaggio.
Nel tentativo di cambiare rotta, si profilano in particolare nuove alleanze tra politiche per la natura e politiche per il paesaggio (Gambino 2009, 2010). Le ragioni sono molteplici e affondano le radici nella comune esigenza di incidere positivamente nel governo del territorio. Da un lato si constata che le politiche di conservazione della natura, nonostante le carenze e le contraddizioni dell’azione pubblica, stanno assumendo un rilievo inaspettato nelle politiche locali e regionali. In particolare, nel 2010, l’Anno della Biodiversità, è stato largamente ribadito il ruolo centrale dei parchi e delle “aree naturali protette”, sia di quelle istituite dai singoli Stati con riferimento alle definizioni dell’Unione Mondiale della natura (IUCN 1994), sia di quelle istituite a livello sovra-nazionale, come la Rete Natura 2000 per i paesi dell’Unione Europea. Una spettacolare e incessante crescita dell’insieme di aree protette ha portato negli ultimi decenni ad estenderle ad una quota assai rilevante del territorio complessivo: in Europa si stima che un quarto ne sia coperto e che circa un quarto della popolazione sia direttamente influenzata dalla loro gestione (CED-PPN 2008). Tale quota può essere ulteriormente aumentata se si considera che i “nuovi paradigmi” sanciti dall’IUCN spingono ad estendere i benefici delle aree protette ai rispettivi contesti territoriali (IUCN 2003). Dall’altro lato, le politiche del paesaggio, secondo gli orientamenti fissati dalla Convenzione Europea, riguardano l’intero territorio e sono esplicitamente chiamate ad incidere su ogni politica, dall’urbanistica ai trasporti all’agricoltura, che possa comportare la conservazione e la trasformazione del paesaggio. Ma, nonostante la concordanza dei fini e la larga sovrapposizione tra le aree naturali protette e i paesaggi a vario titolo tutelati, le rispettive politiche sono, in generale, sostanzialmente separate: le politiche dei parchi fanno capo ad istituzioni, a strumenti e forme di regolazione e a strategie generalmente diverse, salvo che nel caso di vera e propria sovrapposizione (come per le “aree protette” ricadenti nei “paesaggi protetti” così classificati dall’IUCN, che coprono peraltro più di metà del territorio protetto). Nel caso dell’Italia, la difficoltà del raccordo tra i due ordini di politiche è ben rappresentata dalla contraddizione tra l’art.12 L.394, che affida ai Piani dei Parchi un ruolo “sostitutivo” nei confronti di ogni altro piano, e l’art.145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che attribuisce invece ai Piani Paesaggistici una sorta di primato nei confronti anche dei Piani dei Parchi.
5.5. Nuove alleanze per il progetto di territorio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra dunque profilarsi una doppia necessità di integrazione, delle politiche della natura e del paesaggio con le politiche del territorio. Un ambizioso programma di ricerca in tal senso, avente come campo d’attenzione l’intera Europa, fu presentato a Barcellona nell’ambito del Congresso IUCN (CED-PPN, 2008). L’alleanza tra parchi e paesaggi non può che trovare un terreno comune di applicazione nel contesto territoriale e in una prospettiva autenticamente progettuale. Il “progetto di territorio” (Magnaghi 1998) è stato da tempo indicato come il luogo dell’integrazione degli interessi pubblici diversi, della valutazione e composizione dei valori e dell’orientamento strategico delle politiche di regolazione dei processi trasformativi. E già 50 anni fa documenti come la Carta di Gubbio (ANCSA, 1960) attribuivano al Piano Regolatore il compito di delineare le “azioni d’insieme” necessarie per il risanamento dei centri storici,.Molti altri problemi attinenti l’insediamento umano hanno concorso in seguito a complessificare ed aggravare la questione urbana, sollecitando politiche pluritematiche convergenti, in grado di contrastare la settorialità dell’azione pubblica e la sua schiacciante dipendenza dalle logiche dell’emergenza E’ difficile pensare che esse possano fare a meno del “progetto di territorio” latamente inteso, come processo sociale ampio e condiviso, capace di rispecchiare, per dirla col Sereni, i “disegni territoriali” delle popolazioni locali. Processo che non può evitare di muoversi in un orizzonte cooperativo, in cui l’azione fondamentale dei soggetti e dei poteri locali trovi i necessari riscontri a livello regionale, nazionale e sovra-nazionale.
Riferimenti bibliografici
- ANCSA, 1990: La nuova Carta di Gubbio. Un contributo italiano alla riqualificazione della città esistente, XI Convegno-congresso nazionale, Gubbio.
- -- 1997: Patrimonio 2000. Un progetto per il territorio storico nei prossimi decenni, XII congresso naz., Modena.
- Bauman Z., 2008: La solitudine del cittadino globale, UE Feltrinelli, Milano.
- Castelnovi P., 1998: Rel. introduttiva al Seminario Il senso del paesaggio, ISSU, Torino.
- Cattaneo C., 1845: Industria e morale, in Atti della Società d’Incoraggiamento d’arti e mestieri, Milano.
- CoE, Consiglio d’Europa, 2000: Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze.
- CED-PPN (Centro Europeo Documentazione Pianificazione dei Parchi Naturali), 2008: Parchi d’Europa, ETS, Pisa.
- Choay F., 1993: L’allegoria del patrimonio, Officina, Roma.
- Dematteis G., 1995: Progetto implicito, F.Angeli, Milano.
- Donadieu P.,2006 La campagna urbana ( a cura di M.Mininni), Donzelli, Roma.
-Finkielkraut A., 2003: Il fantasma antisemita che attraversa l’Europa, La Repubblica, dicembre 2003
- Kushner J.A., 2008: Global Climate Change and the Road to Extinction,Caroline Academic Press, Durham.
-Gabrielli B.,(a c.), 1997: Patrimonio 2000: un progetto per il territorio storico, Rel. -Congresso ANCSA, Modena.
- Gambino R., 1983: Centralità e territorio, Celid, Torino.
- Gambino R.,1994, “Luoghi e reti: nuove metafore per il piano”, in Archivio di studi urbani e regionali, 1994, Milano
- Gambino R., 1997: Conservare Innovare, Utet Libreria , Torino
- Gambino R., 2000: Reti ecologiche e governo del territorio, in Parchi, n.29/2000.
- Gambino R., 2002: Parks Policies: a European Perspective, in Environments Studies, vol. 30, n.2. Toronto.
- Gambino R., 2009: Parchi e paesaggi d’Europa, Lectio Magistralis, Politecnico di Torino, Torino.
- Gambino R., 2010, Landscape Analysis and Planning, Unesco Master on World Heritage at Work, Turin.
- Howard E., 1898: Garden Cities of Tomorrow, London.
- Harvey D., 1990: La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano.
- Hillman J., 2011:”American Psyche” intervista su La Repubblica, 13/3/2011.
- IUCN (the World Conservation Union) 1994: Guidelines for Protected Area Management Categories, Gland:.
---2003, Vth World Parks Congress: Benefits beyond Boundaries, Durban.
- Lefebvre H., 1970: Il diritto alla città, Marsilio, Padova.
-Magris C., 1997: Microcosmi, Garzanti ed., Cernusco s.n.
- McHarg J, 1966 : “Ecological Determinism « , in FF.Darling, J.P.Milton, ed., Future Environments of North America, The National History Press, Garden City, New York
- Magnaghi A., 1998: Il territorio degli abitanti, Dunod, Milano;
---2010: Manifesto della Società dei territorialisti (bozza in corso di pubblicazione).
- Marsh G.P. 1864: Man and Nature, Ch. Scribner, New York
- Mazza L. 1990: “Il suolo ineguale”, Urbanistica n.98, 1990.
--Raffestin C., 1977: Paysage et territorialité, Cahiers de Géographie de Québec, vol.21, septembre-décembre.
-Schama S.,1997: Paesaggio e memoria, Mondadori, Milano
- Secchi B., 1990: “Tre Piani”, in Urbanistica n.98, 1990;
----, 2011: “La nuova questione urbana, in CRIOS n.1/2011.
-Sen A., 2006: Identità e violenza, Laterza, Bari.
-Tiezzi E., 1998: “Il capitale naturale tra evoluzione e conservazione”, Oikos n.4/98.
- Touraine A. 2008: “Ecco come muoiono i nostri valori universali”, LaRepubblica, 22/2/2008.
- UNESCO, 1972: Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris.
- UNESCO, 2009: Investing in Cultural Diversity and Inter-culture Dialogue, Gland.
- von Humboldt A., 1860: Cosmos. Saggio di una descrizione fisica del mondo, Venezia.
-von Petz U., 2004: “Sulla provenienza”, Critica della razionalità urbanistica, n.16/2004 Alinea, Napoli.
- Zagrebelsky G., 2008: “Valori e diritti”, La Repubblica, 22/2/2008.
Il Paesaggio tra Coesione e Competitività
IL PAESAGGIO TRA COESIONE E COMPETITIVITÀ
PROVINCIA DI TRENTO/STEP 20/6/2011
Roberto Gambino
1.Paesaggi in pericolo
1.1. Il paesaggio, volto della società.
In una delle sue più intriganti parabole (citata da C.Magris, 1997), J.L. Borges parla di un pittore che si propone il compito di disegnare il mondo, ritrae i paesaggi più diversi e si accorge, alla fine, “che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto”. Il paesaggio è il volto di un uomo come della società, dei suoi vincoli fisici, delle sue vicende e delle sue speranze di vita. Le ferite del paesaggio, le sue cicatrici, i suoi difetti e le sue asimmetrie sono quelle stesse della società proiettate sul suolo. Il suo disfacimento riflette il disfacimento della società. Il paesaggio disegna il rapporto tra “vu” e “vecu”, tra ciò che si vede e ciò che è vissuto (Raffestin,1977).I mille paesaggi europei sono i mille volti dell’Europa. Le preoccupazioni per i paesaggi europei esprimono le tensioni sociali, politiche e culturali di un’Europa ancora in cerca di se stessa. Di un’Europa che cerca la propria identità non contro altre identità, ma contro “le proprie tentazioni, i propri demoni, i propri mostri” (A. Finkielkraut, 2003), nel dialogo, nell’inclusione e nella diversità. La difesa dei paesaggi europei non può in alcun modo disgiungersi da questa ricerca, non può in alcun modo ridursi ad un’operazione “cosmetica” o di “giardinaggio”, o ad un’operazione di razionalizzazione burocratica dei variegati sistemi nazionali di difesa dei segni superstiti del passato.
1.2. Il paesaggio, tra rischi emergenti ed ordinari.
E’ in questo senso complesso che il paesaggio è in pericolo. Ma le notizie e le immagini delle immani tragedie delle più diverse parti del globo sembrano travolgere ogni possibilità di approccio razionale, scientificamente orientato, alle grandi questioni dell’insediamento umano contemporaneo. Nonostante il clamore mediatico e la “domanda di verità” che accompagnano di regola le emergenze ambientali, è spesso troppo arduo o forse impossibile distinguere le questioni d’emergenza da quelle che si manifestano nel segno della quotidianità e dell’ordinarietà. Difficili, largamente inadeguati, i tentativi di cogliere i nessi che legano le catastrofi “naturali” all’opera più o meno consapevole e intenzionale dell’uomo. Non meno difficili i tentativi di riportare ad un’interpretazione unitaria gli esiti che si manifestano nei diversi settori dell’attività antropica, da quelli che riguardano le trasformazioni fisiche del territorio a quelli che riguardano l’uso ed i consumi delle risorse naturali, o le dinamiche sociali e culturali, o i processi economici e finanziari. E le difficoltà sono tanto maggiori quanto più all’interpretazione si tenta di associare la previsione, di anticipare il futuro. Ci si chiede se stiamo entrando “nell’età dei grandi rischi” (Scalfari 2011). Se non è casuale la concomitanza tra sommovimenti tellurici di inedita violenza, effetti disastrosi del cambio climatico globale (Kushner, 2011), drammatiche scosse d’assestamento geopolitico su scala internazionale, crisi economica globale ed esplosione della “bolla speculativa”. Non è certo questa la sede per rispondere a domande come queste. Ma, anche se si concentra l’attenzione sull’urbanistica e la pianificazione, non si può fare a meno di interrogarsi sui grandi cambiamenti che attraversano i territori della contemporaneità e sulle risposte che la cultura tecnica e scientifica ha elaborato o sta elaborando agli albori del terzo millennio. La “crisi della modernità” (Harvey 1990) consumata nel corso degli ultimi decenni aveva segnato la decadenza delle grandi narrazioni, delle idee di progresso e di giustizia sociale, delle questioni generali come quelle legate al controllo agli usi del suolo e delle risorse primarie. La frammentazione ecosistemica, prodotto perverso dell’urbanizzazione totale del territorio, sembrava trovare riscontro nella frantumazione del tessuto sociale e dei sistemi di relazione, nella estrema diversificazione degli interessi e delle domande sociali. E. di conseguenza, negare spazio alle interpretazioni unificanti, all’idea stessa che possa esistere un “interesse pubblico” cui riferirsi.
1.3. Il paesaggio e la crisi urbanistica.
Nel corso degli anni ’80, i dibattiti sulla crisi dell’urbanistica, caratterizzati dalla contrapposizione quasi caricaturale tra la cultura del piano e la cultura del progetto, sembravano destinati a smentire definitivamente l’efficacia sociale della pianificazione nell’interpretare l’interesse pubblico. Si osservava che “la domanda sociale a cui tradizionalmente gli urbanisti davano risposta [era] mutata, non più ‘questione generale’, ma problema di minoranze” (Mazza, 1990; Secchi 1990). Problemi d’ordine generale come quelli legati ai rapporti tra stato e mercato nella costruzione del territorio, e quindi al controllo dei valori del suolo, sembravano “rimossi dalle passioni e dagli interessi di buona parte degli urbanisti. L’attenzione di molti è piuttosto concentrata sulla questione della forma e del disegno della città”. Affascinata dai problemi dell’identità complessiva dell’urbs, la pianificazione sarebbe incapace di affrontare quelli della “frammentazione e l’articolazione della civitas e quindi la molteplicità delle forme secondo cui la nostra società tende ad autorappresentarsi”. Il contributo della pianificazione urbana e territoriale alla risoluzione della “questione urbana” su cui si era concentrata nei decenni precedenti la riflessione di studiosi come Castells, non senza potenti riscontri nei movimenti di base della società, sembrava indebolirsi; ed anzi la stessa questione - come questione, appunto, generale - sembrava perdere d’attualità e rilevanza nelle domande e nelle percezioni della società contemporanea.
1.4. La nuova questione urbana .
A più di vent’anni di distanza, ci si può chiedere se queste osservazioni siano ancora valide, o se invece la “nuova questione urbana” (Secchi 2011) – sempre più strettamente incrociata con la multiforme “questione ambientale” - costituisca ancora o nuovamente il quadro problematico con cui la pianificazione deve confrontarsi. E se l’uscita dalla crisi che sembra pervadere le nostre città e i nostri territori richieda la costruzione di un quadro interpretativo ampio e comprensivo: un quadro nel quale si possa tentare di situare coerentemente i grandi problemi della società contemporanea, da quelli che concernono le trasformazioni fisiche del pianeta a quelli che riflettono la radicalizzazione delle diseguaglianze economiche e sociali, le carenze ed il degrado delle condizioni abitative, la crescente mobilità delle popolazioni, delle attività e delle idee. In altre parole, dobbiamo chiederci se e come la cultura della pianificazione (in termini di statuti scientifici e competenze disciplinari, di capacità tecniche professionali, di apparati amministrativi, di strumenti giuridici e di quadri istituzionali, ma anche di attitudini e sensibilità culturali) possa oggi tradurre “le preoccupazioni individuali in questioni pubbliche” (Bauman, 2008). Si impone un cambio di prospettiva, per passare da una visione patrimoniale statica e inventariale – quale quella che ha orientato e tuttora in larga misura orienta l’azione di tutela del patrimonio culturale e naturale (Choay 1993) - a una visione dinamica e strutturale, in grado di cogliere le drammatiche criticità e l’attualità del territori. E’ una visione che sconta l’impossibilità di archiviare l’eredità storica nelle memorie e nei reperti del passato e spinge invece a riconoscere l’attualità del territorio storico nella sua incessante contemporaneità con la cultura della società che lo abita e lo produce. Una visione che, incrociando più vaste riflessioni sulle dinamiche della società contemporanea, ha aiutato a comprendere la (ri)scoperta del territorio come risorsa a rischio di perdita e di degrado, ma anche come insostituibile fondamento dell’azione politica e culturale.
-
Identità, valori e diritti.
2.1. Il paesaggio, fondamento dell’identità.
Nelle nuove retoriche che impregnano il discorso pubblico sul territorio contemporaneo, ha assunto grande rilievo il tema dell’identità, non a caso introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio nella definizione stessa del paesaggio, concepito non solo come esito dinamico dell’interazione tra fattori antropici e naturali, ma anche come “fondamento dell’identità” (art.5). Definizione che ha avuto largo riscontro nelle pratiche discorsive e progettuali degli ultimi decenni, in cui il paesaggio è stato spesso la bandiera della difesa e del rafforzamento delle culture e delle economie locali, anche in funzione di resistenza alle spinte omologanti della globalizzazione. In quanto sistema di valori identitari, il paesaggio interpreta non solo le peculiarità, i caratteri e le differenze del territorio, ma anche le sue potenzialità evolutive. Di qui l’importanza crescente attribuita al paesaggio ai fini della difesa della biodiversità ed ancor più della “diversità bio-culturale”, su cui l’Unesco e l ‘Unione mondiale della natura hanno ancora recentemente richiamato l’attenzione. Di qui anche il tentativo di contribuire, con le politiche del paesaggio, alla riscoperta e alla valorizzazione delle culture, delle agricolture e delle economie locali (basti pensare al successo di “slow food” e delle produzioni “a km zero”), ponendolo al centro del marketing urbano e territoriale. Tuttavia, a dispetto dell’enfasi sul paesaggio e sulla sua funzione identitaria, il concetto stesso di identità è stato oggetto di critiche crescenti. Da un lato infatti le rivendicazioni identitarie non hanno mancato di mostrare tendenze regressive, chiusure “autistiche” e derive nostalgiche nelle gabbie delle tradizioni. A tutte le scale, da quelle locali a quelle planetarie, si è avanzata minacciosa l’ombra delle identità “armate” o “bellicose” (Amartya Sen., 2006.). Dall’altro lato, il “salto di scala” di un numero crescente di problemi ambientali, economici e sociali (sempre meno trattabili a scala locale, sempre più richiedenti azioni e apparati di controllo a livello regionale, nazionale e soprattutto internazionale), ripropone i grandi temi dell’integrazione trans-scalare delle azioni pubbliche di regolazione, dei grandi racconti e delle “big pictures”su cui si fondano le strategie d’insieme Emblematico, in questo senso, il tema del “global change” e dello sconfinato insieme di attività e di politiche che dovrebbero contrastarne o mitigarne gli effetti più drammaticamente negativi.
2.2. Verso una nuova territorialità del paesaggio.
I cambiamenti di scala dei problemi da fronteggiare mettono in scacco le distorsioni identitarie poiché riguardano non soltanto i cambiamenti reali del mondo contemporaneo, ma anche i modi con cui li osserviamo, le concezioni, i miti e le utopie che guidano le nostre analisi e le nostre scelte. Non possiamo evitare di misurarci coi processi emergenti, ma “per farlo dobbiamo poterli riconoscere. E per riconoscerli capire quanto sta accadendo” (Hillman, 2011). A questo fine l’approccio “territorialista” – quale quello proposto dalla “Società dei territorialisti”: Magnaghi 2010 - ha svolto e può svolgere un ruolo significativo. “Questo approccio ha posto al centro dell’attenzione disciplinare il territorio come bene comune, nella sua identità storica, culturale, sociale, ambientale, produttiva, e il paesaggio in quanto sua manifestazione sensibile […]. Il ritorno al territorio come culla e risultato dell’agire umano esprime e simboleggia la necessità di reintegrare nell’analisi sociale e quindi anche economica, gli effetti delle azioni umane sulla mente umana e sull’ambiente naturale, sempre storicamente e geograficamente determinati”. Il territorio, dunque, non come inerte supporto delle attività antropiche, ma come sistema costitutivo delle relazioni che esse intrattengono con le dinamiche naturali. E' in questo contesto complesso e problematico che va concentrata la ricerca di una nuova territorialità, gravida di memorie e di consapevolezza ambientale, sullo sfondo di un'evoluzione del pensiero scientifico contemporaneo che sembra mutare il senso della presenza umana nel mondo.
-
Coesione e competitività.
In questa ricerca il riferimento alla dimensione locale è fondamentale. Una dimensione che evidenzia le identità e i caratteri su cui riposa la diversificazione del territorio, senza vincoli di scala. Che crea i paesaggi, con visione dinamica e trans-scalare, con collegamento incessante alle percezioni, alle attese ed ai progetti degli abitanti. ma i luoghi non sono frammenti autonomi e indipendenti, non sono mondi separati, sono “schegge del mondo” (Magris, 1997). La loro capacità di conservare i propri caratteri identitari dipende, non meno che dalle “chiusure operative” dei sistemi locali, dall’”apertura” verso il cambiamento e quindi dalla loro capacità di affacciarsi efficacemente sulle reti di relazioni che agiscono nel contesto territoriale, alle diverse scale. In entrambe le direzioni il paesaggio svolge un ruolo fondamentale. Da un lato esso lega fatti, luoghi e attività tangibili e intangibili, variamente dislocati nello spazio territoriale, in contesti tendenzialmente coesi, in cui le comunità locali possono riconoscersi ed interagire più o meno efficacemente. Il dispositivo paesistico è riflesso e strumento di coesione ecologica, economica, sociale e culturale, atto a rafforzare le capacità di resistenza e resilienza dei sistemi locali nei confronti delle pressioni e delle perturbazioni provenienti dall’esterno. Ma nel contempo il paesaggio è anche riflesso e strumento di competitività, nella misura in cui conferisce ai sistemi locali un’immagine caratterizzata e riconoscibile, che gli consente di partecipare con speranza di successo ai confronti che si profilano a tutti i livelli, mobilitando insiemi strutturati di risorse diversificate, dando voce al “territorio degli abitanti” o investendo nel marketing urbano e territoriale.
2.4.. Nuovi sistemi di valori potenzialmente in conflitto
La tutela del paesaggio, come quella della natura, ha a che fare con l’affermazione di sistemi di valori; ma i sistemi di valori non sono gli stessi. Contano, nel secondo caso, valori riconosciuti e presidiati dalle “scienze dure” (come la geologia o la biologia), in termini tali da quasi annullare ogni possibilità di scelta circa le misure di tutela da adottarsi. Tra il riconoscimento oggettivo e scientificamente inoppugnabile del valore e la scelta dei modi con cui proteggerlo, si profila una relazione stringente, al limite deterministica. Nel primo caso, la tutela del paesaggio, entrano in gioco valori di assai più incerta determinazione, che lasciano ampi spazi all’interpretazione e alla valutazione soggettiva, nonostante il poderoso ausilio delle scienze sociali, in primo luogo la storia. La labilità e la soggettività che ne derivano, in ordine alle misure di tutela e di gestione, sono state esplicitamente riconosciute dalla stessa Convenzione Europea del Paesaggio, che impegna le parti a tener conto, nella valutazione dei paesaggi, “dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate”(art.5). Questa distinzione non è peraltro rigida. Anche nel campo della conservazione della natura si è fatta strada una concezione più socialmente sensibile dei valori in gioco; mentre la stessa oggettività scientifica delle valutazioni è sempre più spesso revocata in dubbio (basterà ricordare l’aspra contesa che attraversò il mondo scientifico quando si trattò di scegliere la miglior strategia d’intervento, a fronte dello spaventoso incendio che devastò il Parco di Yellowstone qualche anno fa) E inversamente il determinismo ecologico (a partire dalla svolta degli anni ’60: McHarg 1966) ha profondamente impregnato la cultura del paesaggio, dietro le bandiere della Landscape Ecology.. Piuttosto che suggerire una biforcazione tra sistemi diversi di valori, l’esperienza sembra indicare l’intrinseca problematicità della identificazione dei valori, sia nel campo della conservazione della natura che in quella del paesaggio.
2.5. Principi e diritti
Il riconoscimento dei valori naturali e culturali, in particolare di quei valori che il mercato ignora o contrasta, è alla base delle lunghe lotte per il “diritto alla città” (Lefebvre 1970) e per la costruzione dello “stato sociale”, rese oggi più aspre dall’emergenza dei fenomeni d’immigrazione e dalle nuove iniquità sociali. Ma il riconoscimento di quei valori porta anche all’affermazione di nuovi diritti e di nuovi doveri, come quelli che in Italia si richiamano all’art. 9 della nostra Costituzione. Accordi e trattati internazionali hanno sancito una progressiva dilatazione dei “diritti ambientali”, fra cui quelli che – come tipicamente i “diritti all’esistenza” di beni ambientali irrinunciabili, in primis l’acqua - riflettono interessi collettivi trans-generazionali. Nel contempo si è ampliata la gamma dei “diritti di cittadinanza”, che riguardano ormai pacificamente anche valori “intangibili” come quelli estetici o letterari. Può sembrare ironico nel nostro paese, che ha lasciato gran parte delle proprie coste, dei propri paesaggi agrari, delle proprie montagne e dei propri centri storici alla mercè della speculazione immobiliare (e che anzi sembra tuttora assecondarne le spinte in nome dello sviluppo economico) pretendere il rispetto dei “diritti alla bellezza”: un lusso che secondo molti non possiamo permetterci. Ma non si può ignorare che sotto quella bandiera si stanno aggregando consistenti ed agguerriti movimenti d’opinione e coalizioni di interessi..Se si accetta l’idea che le politiche della natura e del paesaggio non possano prescindere dai nuovi diritti di cittadinanza, non si può evitare di chiedersi come assicurarne la concreta attuazione, tenendo conto della pluralità, della variabilità e dell’intrinseca conflittualità degli interessi e dei valori in gioco. Una conflittualità che certo non si limita allo scontro tra generici interessi pubblici ed interessi privati, ma contrappone sempre più spesso, come riportano le cronache, diversi interessi pubblici antagonisti. Perché e a quali condizioni il riconoscimento di un paesaggio urbano storico di grande rilievo o di un’impareggiabile paesaggio agrario deve impedire la realizzazione di un grattacielo per uffici pubblici o di una piattaforma logistica o di un grande complesso ospedaliero? Per sfuggire alle insidie del relativismo e reagire all’”indietreggiamento dei valori universali” (Touraine 2008.) si invoca l’accettazione di gerarchie di valori. Ma la battaglia sui valori assoluti sembra difficilmente riconducibile alle logiche del confronto democratico aperto ed inclusivo. Se ciascuna delle parti in conflitto si trincera dietro al proprio sistema di valori, l’esito del confronto non può che essere quello di una sopraffazione più o meno violenta e, si può aggiungere alla luce dell’esperienza, tendenzialmente a danno degli interessi pubblici più deboli, come quelli paesistici e ambientali. Di qui l’opportunità, nello spirito della Costituzione, di “ragionar per principì”, sostituendo alla logica dell’imposizione la logica della persuasione (Zagrebelsky 2009). E’ su questo terreno che può fondarsi la ricerca delle più opportune forme di regolazione pubblica dei processi che modellano il paesaggio.
2.6. Regolazione versus percezione?
Il relativismo dei valori e delle poste in gioco pone in grande evidenza il ruolo della percezione, riferimento imprescindibile (secondo la Convenzione) per la definizione delle politiche e per gli stessi riconoscimenti di valore. Apparentemente la percezione e la regolazione rappresentano due prospettive antitetiche. Da un lato, le percezioni paiono dominate dalla mutevolezza e instabilità delle condizioni dell’osservazione sensoriale (al variare della posizione dell’osservatore, al trascorrere delle stagioni, delle ore del giorno e del tempo atmosferico), dalla soggettività dei filtri culturali che ne condizionano la fruizione, delle sensibilità e delle conoscenze pregresse che mediano il processo percettivo. E’ in gioco la semiosi stessa del paesaggio, la sua apertura nei confronti dei processi di significazione, mai riducibili ad un sistema “dato” ed immutabile di segni oggettivamente riconoscibili e condivisibili. (Castelnovi 2000).
Dal lato della regolazione, la prospettiva sembra mutare radicalmente. Cambiano le ragioni, gli interessi e le poste in gioco, le modalità dell’intervento umano sui processi di trasformazione. Alla base, si situa il riconoscimento del paesaggio come bene comune, ormai esteso dai paesaggi eccezionali al paesaggio come bene di valore intrinseco e ubiquitario. L’ampia definizione della Convenzione Europea tende a sussumere l’insieme degli interessi collettivi largamente condivisi: da quelli ecologici a quelli economici e sociali direttamente connessi al benessere e “ben vivere” delle popolazioni locali e alle prospettive di sviluppo, a quelli antropologici e culturali in cui si esprimono i valori identitari locali, nazionali e mondiali.
Il riconoscimento di tali interessi implica un’affermazione di valori che si contrappone almeno in parte alle tendenze in atto, alle dinamiche di mercato, al trionfo degli interessi particolari suscettibili di pregiudicarne l’integrità o la fruibilità. Questa affermazione richiede quindi un’azione di sostegno e di difesa da parte dell’amministrazione pubblica, atta a configurare una “regolazione” dei processi trasformativi volta ad impedirne gli effetti indesiderabili e a incentivare quelli sinergici e positivi .Nel contempo la regolazione pubblica dei processi rischiosi è tanto più “democraticamente” legittimata quanto più i riconoscimenti di valore si traducano in diritti e doveri proclamati a livello nazionale o internazionale.; è il caso di molti diritti ambientali, come tipicamente i “diritti all’esistenza” di determinate risorse inalienabili (come l’acqua) che rispondono ad interessi collettivi trans-generazionali. L’approccio “a partire dai diritti” sta guadagnando terreno nel dibattito sulla conservazione del paesaggio, in stretto rapporto con quello riguardante la natura, sostenuto particolarmente dall’ IUCN. Non ci si può nascondere che queste designazioni a livello nazionale e sovranazionale possono entrare in collisione con visioni locali più attente agli interessi (di pochi) piuttosto che ai diritti (di tutti).
3. Conservazione e innovazione.
3.1.. Conservazione e innovazione, un rapporto inscindibile
Negli ultimi decenni il principio di conservazione ha conosciuto una sconcertante dilatazione del campo d’applicazione e del suo stesso significato, non senza ambiguità e contraddizioni. Sia nei confronti della natura che del patrimonio culturale, la conservazione si è progressivamente staccata da concetti come quelli di “preservazione”, salvaguardia, tutela passiva, implicanti il riconoscimento di una condizione di immodificabilità non perfettibile, per lasciare spazio a forme più o meno complesse di trasformabilità, gestione dinamica, attenta amministrazione (Passmore 1986), cura e innovazione. Sebbene la nuova concezione recuperi importanti lezioni del passato, come il conservazionismo di Marsh (1864) o di Leopold (1933), essa si nutre di riflessioni attuali. Da un lato, la constatazione che, più che in passato, non può darsi autentica e durevole conservazione che non comporti trasformazione innovativa (“non si possono separare le cose dal loro divenire”: Tiezzi 1999; “il cambiamento fa parte inscindibile della biosfera”: Botkin 1990). Ogni intervento sul patrimonio culturale implica tensione innovativa, quanto meno nel ridar senso alle cose; e, d’altro canto, non si fronteggiano efficacemente i rischi e le minacce derivanti dai cambiamenti globali senza “adattamenti” innovativi (Adams, 1996). Ma dall’altro lato e simmetricamente, la presa d’atto che ogni autentica innovazione nel mondo contemporaneo implica il confronto con una ingombrante eredità naturale e culturale, con sistemi complessi di “provenienze” (Petz, 2004) e di memorie (Schama, 1997), che non c’è oblio senza memorie, e che la gestione innovativa degli attuali ecosistemi non può prescindere dalla loro storia precedente (Botkin, 1990). In sintesi, la conservazione si configura sempre più come “luogo privilegiato dell’innovazione”, (ANCSA, “Carta di Gubbio”, 1990),. La conservazione innovativa, lungi dal potersi interpretare come un indebolimento delle opzioni di tutela, implica un impegno rafforzato per la cura dell’eredità territoriale e per la sua trasmissione alle future generazioni (Gambino, 1997).
3.2. La dilatazione dell’opzione conservativa
Ma il cambiamento di senso del principio di conservazione è tanto più rilevante in quanto è stato accompagnato da una vera e propria esplosione del suo campo d’applicazione, sia nei confronti della natura che del paesaggio e del patrimonio culturale. Per la conservazione della natura, il cambiamento forse più emblematico riguarda le “aree naturali protette” ed i loro rapporti coi territori circostanti. La ricerca di forme di protezione e di valorizzazione estese a tali territori (secondo lo slogan del Congresso IUCN di Durban, 2003: “Benefits beyond Boundaries”: benefici al di là di ogni frontiera), di politiche conservative “a scala di paesaggio”, di pianificazione ecosistemica per eco-regioni, di “messa in rete” di ampi sistemi di aree protette variamente caratterizzate, trova un’ispirazione comune nel nuovo modo di intendere il principio di conservazione. Analoga dilatazione si è prodotta in rapporto al patrimonio culturale, con lo spostamento d’attenzione, (che trova emblematica testimonianza nell’evoluzione del pensiero dell’ANCSA: Gabrielli, 1997) dai “monumenti” ai centri e agli insediamenti storici, al territorio storico nella sua interezza. Anzi questo spostamento di senso, dal monumento al patrimonio, è strettamente connesso – nei discorsi che da anni studiosi come Francoise Choay (2008) vanno sviluppando - alla “mondializzazione della salvaguardia del patrimonio storico”, ossia al riconoscimento internazionale che “non possiamo più permetterci il lusso di lasciarlo andare in rovina”. Ancora più esplicito, è appena il caso di ricordare, lo spostamento riguardante il paesaggio, espresso nella Convenzione Europea del Paesaggio, che sancisce l’obbligo di riconoscere valenza paesistica a tutto il territorio, applicando misure diversificate di salvaguardia, gestione e pianificazione. Sotto tutti questi profili – ed in contrasto, beninteso, con gran parte degli apparati e delle pratiche tradizionali di controllo e tutela- si afferma l’irriducibilità del principio di conservazione a singoli “pezzi”del patrimonio naturale-culturale staccati dal contesto; o in altre parole, l’impossibilità di dividere il patrimonio territoriale in parti da conservare e parti da lasciare alla mercè delle spinte trasformatrici .
3.3. Il rapporto natura-cultura.
In questa prospettiva, il rapporto tra natura e cultura svolge un ruolo cruciale, tutt’altro che scontato. Respinte le schematizzazioni meno sostenibili (come la divisione dicotomica del territorio in spazi naturali e spazi antropizzati: divisione che tuttavia ricorre ancora non solo nelle politiche dei parchi e delle aree protette "insularizzate", ma anche in molte politiche territoriali volte a contrastare con misure di esclusione i consumi dissennati di territorio) occorre riconoscere che la discussione è aperta, sul piano teorico non meno che politico ed operativo. Occorre da un lato de-naturalizzare le scelte di trasformazione antropica, troppo spesso occultate da generici richiami agli eventi naturali (le false emergenze naturali che coprono autentiche "calamità pianificate" e logiche devastanti di gestione "emergenziale" del territorio, ma anche quelle interpretazioni strutturali di piani urbanistici e territoriali che confondono il "dato" col progetto). Dall'altro occorre, dopo la svolta ecologista della metà del secolo scorso e le sue ricadute deterministiche (McHarg 1966), ricostruire i rapporti tra naturalità, ruralità e urbanità, riconoscendone la compresenza pervasiva in ogni angolo del pianeta. Si configura un radicale superamento di quella contrapposizione tra natura e cultura che ha svolto un ruolo centrale nella civiltà occidentale in età moderna, a partire dalle grandi utopie rinascimentali. Se ancora alla fine dell’800 Ebenezer Howard (1898) poteva proporre con la teoria dei tre magneti e l’idea della “Città giardino” una sintesi creativa, i grandi cambiamenti del secolo scorso (come l’industrializzazione dell’agricoltura o l’urbanizzazione “totale” dello spazio abitabile e la reciproca contaminazione dei rispettivi spazi dedicati) hanno messo fuori gioco i tradizionali modelli interpretativi e sollecitato l’elaborazione di nuovi rapporti.
3.4. Le responsabilità antropiche nelle dinamiche naturali.
Si afferma faticosamente una crescente consapevolezza delle responsabilità antropiche nella determinazione o nell’aggravamento dei rischi, delle calamità e del degrado ambientale, mentre i “nuovi paradigmi” che si profilano a livello internazionale (IUCN 2003) legano ormai ogni prospettiva di conservazione della natura alla promozione e regolazione dello sviluppo culturale, economico e sociale sostenibile. Da un lato l’enfasi sull’impegno internazionale per la difesa della bio-diversità concede uno spazio crescente all’importanza della diversità bio-culturale, ostaggio dei processi di urbanizzazione totale ma mai indipendente dalle dinamiche naturali (Unesco 2009). E’ questa la diversità che costituisce la ricchezza (il “capitale”) su cui basare lo sviluppo sostenibile del territorio. E d’altro canto non si può certo ignorare il significato culturale connesso all’utilizzazione antropica delle risorse naturali, alla fruizione, alla percezione e all’apprezzamento individuale e collettivo dei paesaggi e delle “bellezze naturali”. Già la scoperta humboldtiana del “nuovo mondo” (von Humboldt, 1860), come l’”invenzione” sette-ottocentesca delle Alpi, orientano gli sguardi e umanizzano irreversibilmente il mondo naturale, anche in assenza di rilevanti trasformazioni fisiche. Soprattutto nei territori europei in cui più densa e pervasiva è stata la sedimentazione culturale, la naturalità con cui abbiamo a che fare è quella storicamente determinata dalle vicende pregresse dell’appropriazione antropica dello spazio: non solo da quella che ci ha lasciato un patrimonio ammirevole di paesaggi culturali, ma anche dalle spinte omologatrici che hanno investito la campagna, ipersemplificato e banalizzato i paesaggi agrari ereditati da secoli di storia, piegato le dinamiche naturali alle logiche, spesso indecifrabili, dell’espansione urbana e della dispersione insediativa, smantellato i reticoli ecologici (fossi, canali, siepi ed alberate, ecc.), presidio prezioso della diversità paesistica e della stabilità ecosistemica. (Gambino 2000). Negli scenari che si vengono delineando a livello globale, la naturalità così “storicizzata” non è in alcun modo confinabile in “aree naturali” sottratte (illusoriamente) all’influenza antropica, ma incrocia ovunque l’opera dell’uomo, sia che essa si allei assecondandole con le dinamiche naturali, sia che le contrasti in forme più o meno calamitose.
3.5. Valori locali e valori universali.
Negli scenari internazionali anche il riferimento prioritario ai sistemi di valori sovra-locali è oggi in discussione. Da un lato infatti l’indietreggiamento dei valori universali, minacciati od aggrediti dagli attuali modelli di sviluppo, spinge a misure esemplari di tutela, quali quelle accordate ai siti inseriti nel World Heritage. Ma dall’altro lato, la rivalutazione dei sistemi locali e delle ragioni dello sviluppo locale, soprattutto in situazioni di marginalizzazione o di declino, trova riscontro nella riaffermazione dei valori identitari locali, visti spesso dalle comunità perdenti come le “radici del proprio futuro”. E’nei sistemi culturali locali che si radicano i valori universali, come dimostrano le ricerche e i dibattiti che hanno accompagnato varie esperienze di riconoscimento di Siti Unesco, compresa quella recente, relativa alle Dolomiti: inserite come “sito naturale” ma per ragioni che richiamano esplicitamente la rilevanza dei patrimoni culturali locali. Tra i valori locali e i valori universali sembra così delinearsi un rapporto di complementarietà, o più precisamente di forte interazione, che non cancella la possibilità di conflitti e di contraddizioni. (Gambino 2010). Pensata come un argine contro la perdita o la regressione dei valori universali, la difesa del migliaio di siti del World Heritage sparsi in tutti i continenti sembra spesso portare piuttosto il vessillo di “peculiari” valori locali, capaci di competere vantaggiosamente sull’arena globale. Non a caso le battaglie politico-culturali per le “nominations” dei Siti da inserire nelle liste Unesco sono sempre più spesso ingaggiate in nome del rilancio e del consolidamento di culture e di paesaggi locali (come tipicamente nel caso dei paesaggi viticoli francesi od italiani).
4. La riarticolazione della centralità urbana.
4.1. Luoghi e reti, metafore complementari.
La tensione tra valori naturali e culturali, tra valori locali e universali, evoca inevitabilmente il rapporto tra i luoghi e le reti, da tempo pensati come metafore complementari, per l’interpretazione e il progetto dei territori della contemporaneità (Gambino1994?). Esse possono aiutare a riconoscere la “territorialità del paesaggio” nell’ampio significato attribuitogli dalla Convenzione Europea. E’ nel paesaggio, quale risulta dall’incessante interazione delle dinamiche antropiche e naturali, che l’insediamento storico prende il suo pieno significato, di storicità ed attualità. E’ nel paesaggio che i centri storici dialogano non solo con la campagna “edificata” (per usare le parole di Cattaneo, 1845), nel corso dei secoli e dei millenni dalle reti agrarie, dai sistemi delle acque e dai sistemi della viabilità e delle infrastrutture, ma anche con la presenza mobile della natura, che, riluttante ad ogni confinazione, pervade e diversifica gli spazi che circondano le aree in vario modo costruite. Nonostante i processi di urbanizzazione diffusa, la proliferazione delle maglie infrastrutturali e la stessa “modernizzazione” della pratiche colturali – soprattutto nell’ultimo mezzo secolo - abbiano profondamente ed estesamente intaccato i paesaggi ereditati dal passato, frantumandone i reticoli connettivi e i caratteri identitari, è ancora in quei paesaggi e nella loro coerente evoluzione che si può tentare di recuperare la qualità, la bellezza e la riconoscibilità dei territori contemporanei. La ricostruzione di migliori equilibri ecologici e di più accettabili condizioni di sicurezza nel quadro di vita delle popolazioni, non meno che la ricerca di nuovi fondativi rapporti coi luoghi, trova nella diversità dei paesaggi un’espressione fondamentale. Ma anche, inversamente, la piena considerazione dei nuovi significati dell’urbanità conmporanea spinge ad interpretarli nel quadro della reinvenzione dei paesaggi della modernità. La chiave paesistica offre un ausilio potente per orientare il progetto di territorio al riconoscimento delle nuove forme del rapporto tra cultura e natura: passo obbligato per migliorare la qualità complessiva offerta agli abitanti non meno che ai turisti e ai visitatori.
4.2. Il paesaggio urbano storico.
Nel panorama internazionale e soprattutto europeo, è il paesaggio urbano, ove si compongono forme propriamente urbane con frange peri-urbane di “campagna urbana” (Donadieu 2006), ad attrarre sempre più (come già rilevava il Memorandum di Vienna nel 2005) visitatori, residenti e capitali. Nella transizione verso la società della cultura e della conoscenza, e a fronte delle spinte omologanti determinate dai processi di globalizzazione, il ruolo della città è sempre meno affidato alle relazioni strettamente economiche e funzionali (le funzioni “centrali” del terziario e del quaternario) e sempre più alle relazioni simboliche, alle immagini identitarie e alle dinamiche “intangibili”. E’ soprattutto su queste che fanno leva le politiche di marketing con le quali città e territori cercano di affrontare con speranze di successo le sfide competitive che si profilano a livello internazionale. E’ su queste che recenti documenti (Unesco 2009) richiamano l’attenzione, sottolineando il ruolo complesso che la “messinscena” paesistica svolge combinando le immagini durevoli della città storica con le suggestioni delle nuove architetture che ne ridisegnano i rapporti col contesto extraurbano. Le tensioni che ne derivano non sono certo esenti da equivoci e contraddizioni. Come dimostrano le aspre contese che hanno accompagnato la “verticalizzazione” di tante città europee (i grattacieli di Londra o di Parigi o di Milano) è evidente il rischio che proprio le nuove immagini della “modernizzazione urbana”, prendendo le distanze dall’eredità storica dei singoli paesaggi urbani e mettendosi al servizio degli stessi meccanismi speculativi che dominano il mercato immobiliare, ne configurino paradossalmente la sostanziale omologazione. In prospettiva internazionale, il rischio che i sogni della “città europea”, orgogliosamente contrapposta alla “città americana” per la complessità della sua stratificazione storica, cancellino ogni attenzione per i caratteri distintivi, le regole di coerenza e le qualità specifiche dell’urbanità contemporanea.
4.3. Nuova centralità e diritto alla città.
E’ questa la posta in gioco: la centralità urbana e il suo significato per la società contemporanea, come livello specifico dell’urbanità, essenza ultima di quel “diritto alla città” su cui si svilupparono le lotte urbane degli anni ’70; ma nuovamente al centro della domanda sociale di città e di memoria. E’ il caso paradigmatico dell’Aquila, dove l’urgenza dei nuovi interventi sostitutivi per i “terremotati” ha gettato nell’ombra l’esigenza di recuperare la città storica e i suoi valori socioculturali, appassionatamente propugnata dai suoi abitanti. In prospettiva internazionale, la crisi delle politiche “centriste” (emblematizzate dalle new towns e dalle villes nouvelles) concorre a mettere in discussione l’idea che soltanto lo spazio della convergenza e dell’aggregazione fisica – la piazza – possa ospitare i valori di centralità e che al contrario gli spazi aperti, la campagna e gli spazi della “dissoluzione urbana” vi si oppongano dialetticamente. Questa discussione ha particolare rilevanza per i centri storici. Essa ne investe anzitutto il ruolo “centrale” sotto il profilo economico-funzionale, sociale e culturale, nell’ambito dei rapporti tra città compatta e città diffusa. Rapporti assai più problematici di quanto non emergesse nelle critiche alla dispersione urbana dei decenni scorsi, che vanno ripensati a fronte dell’emergere della città “reticolare” (Dematteis 1995, Gambino 2009), preludio forse di nuove più complesse forme di metropolizzazione (Indovina 2010), In queste nuove configurazioni urbane i grandi eventi prendono sempre più spesso forma fuori dei luoghi tradizionali, la quotidianità si appropria di spazi inconsueti, i giovani reinventano continuamente gli spazi della creatività. Ma la discussione investe anche l’altro termine del concetto di centro storico, la sua storicità, negandone in radice la possibilità di ancorarla a precise e stabili delimitazioni spaziali. La riarticolazione della centralità urbana non riguarda pezzi di città o brani staccabili di territorio, ma il territorio storico nella sua complessità.
5. Il nuovo ruolo degli spazi liberi
5.1. Riportare la natura in città.
Nella città e nel territorio storico contemporaneo, dentro o ai bordi dello spazio “costruito”, gli spazi liberi sono sempre meno interpretabili con la metafora ambigua del ”verde urbano”, sempre più spesso teatro della nuova fenomenologia urbana. Teatro che non si racchiude nei confini stabili dell’urbano, poiché si ramifica dinamicamente nelle reti territoriali, che entrano ed escono dalla città compatta (tipicamente con le fasce fluviali e i sistemi delle acque), la attraversano e la legano al contesto territoriale. In questo quadro la “rinaturalizzazione” della città, oggetto di politiche urbane e territoriali ricorrenti a livello internazionale, può assumere un significato nuovo e diverso. Va pensata non tanto per concedere al verde qualche metro in più, quanto per riportare la natura in città restituendole la pienezza di quel significato ecologico, storico e culturale, che traspare vividamente dall’iconografia storica. Gli sforzi che in tante città europee a cominciare da Londra si stanno facendo per ripensare e attualizzare l’idea delle “cinture verdi”, nelle nuove prospettive della città reticolare diramata sul territorio, testimoniano la difficoltà di individuare nuove logiche organizzative, capaci di integrare spazi aperti e spazi chiusi, paesaggi urbani e paesaggi rurali, dinamiche insediative e dinamiche ambientali. In questa direzione le politiche di conservazione della natura e del paesaggio sembrano destinate a sfidare la cultura urbanistica, costringendola ad uscire dai suoi recinti tradizionali (legati più o meno rigidamente all’ambiente costruito) per assumersi nuove più pesanti responsabilità in ordine alla realizzazione dello spazio pubblico e dello stato sociale.
5.2. Dalle reti ecologiche alle infrastrutture ambientali.
D’altronde, nell’esperienza europea la costruzione delle reti ecologiche – per contrastare o ridurre la frammentazione ecologica e paesistica del territorio, restituendogli un minimo di connettività e di permeabilità, soprattutto nelle grandi aree urbanizzate – ha già assunto scopi diversi e più complessi di quelli, strettamente biologici, originari (Ced-Ppn, 2008). Nella città reticolare che si profila nei nuovi orizzonti urbani, le reti di connessione non possono avere solo funzioni biologiche, di collegamento tra habitat e risorse naturali che rischiano l’insularizzazione, ma assumono inevitabilmente un significato più denso e complesso, che integra natura e cultura collegando risorse e valori diversi. Si avverte sempre più l’esigenza di realizzare nuove “infrastrutture ambientali” capaci di innervare l’intero territorio, svolgendo un ruolo di sostegno non meno importante di quello tradizionalmente assegnato alle reti dei trasporti, delle comunicazioni o dell’energia. Ma questa esigenza non si manifesta solo “in uscita” dalla città, vale a dire verso i territori della dispersione insediativa e dell’espansione urbana, ma anche “in entrata”, vale a dire nelle maglie della città compatta. L’interesse crescente per i programmi di rigenerazione volti a riportare la natura in città (“greening the city”), per i progetti di recupero e riqualificazione delle fasce fluviali e per i sistemi delle acque storicamente consolidati, per il riuso non meramente immobiliare dei “vuoti urbani” e delle grandi aree dismesse, segnala il maturare di una nuova consapevolezza dei grovigli di deficit che occorre rimuovere.
5.3.Collegare tutela e valorizzazione.
Lungi dal potersi rinchiudere in orizzonti settoriali, in pratiche “cosmetiche” o in pericolose politiche d’emergenza, la conservazione innovativa della qualità del territorio richiede strategie lungimiranti d’intervento strutturale e preventivo, che guardino non solo alle “eccellenze” ma all’insieme del territorio; è questo che va salvato e valorizzato, non i singoli “oggetti” che ospita. Le nuove visioni che caratterizzano gli scenari internazionali, i nuovi paradigmi che dovrebbero guidare la conservazione della natura, le prospettive reticolari che si profilano nelle città e nei territori contemporanei, sollecitano strategie diramate e complesse, trans-scalari e pluri-settoriali. Calamità falsamente naturali e tragedie ambientali quotidiane ribadiscono la necessità e l’urgenza di collegare la tutela e la valorizzazione delle città e dei centri storici, dei paesaggi e del patrimonio culturale al rispetto della natura e del contesto ambientale, oggi oggetto di politiche largamente, drammaticamente separate. Convergono, nella crisi che attraversiamo, cause diverse, che attengono all’indebolimento e alla inadeguatezza degli apparati istituzionali e di governo, ma anche alla scarsa fiducia negli atteggiamenti cooperativi, nelle possibilità di partnership e di collaborazione inter-istituzionale: anche quando, come nel nostro paese, la “leale collaborazione”tra le istituzioni di governo è esplicitamente richiesta dalla stessa Costituzione. Si determina quindi una difficoltà insuperabile nella costruzione di quella “intelligenza collettiva” dell’impresa, della politica e del progetto (SIU, 2011) che costituisce una condizione indispensabile per affrontare con speranza di successo le sfide del territorio.
5.4. Integrare politiche della natura e politiche del paesaggio.
Nel tentativo di cambiare rotta, si profilano in particolare nuove alleanze tra politiche per la natura e politiche per il paesaggio (Gambino 2009, 2010). Le ragioni sono molteplici e affondano le radici nella comune esigenza di incidere positivamente nel governo del territorio. Da un lato si constata che le politiche di conservazione della natura, nonostante le carenze e le contraddizioni dell’azione pubblica, stanno assumendo un rilievo inaspettato nelle politiche locali e regionali. In particolare, nel 2010, l’Anno della Biodiversità, è stato largamente ribadito il ruolo centrale dei parchi e delle “aree naturali protette”, sia di quelle istituite dai singoli Stati con riferimento alle definizioni dell’Unione Mondiale della natura (IUCN 1994), sia di quelle istituite a livello sovra-nazionale, come la Rete Natura 2000 per i paesi dell’Unione Europea. Una spettacolare e incessante crescita dell’insieme di aree protette ha portato negli ultimi decenni ad estenderle ad una quota assai rilevante del territorio complessivo: in Europa si stima che un quarto ne sia coperto e che circa un quarto della popolazione sia direttamente influenzata dalla loro gestione (CED-PPN 2008). Tale quota può essere ulteriormente aumentata se si considera che i “nuovi paradigmi” sanciti dall’IUCN spingono ad estendere i benefici delle aree protette ai rispettivi contesti territoriali (IUCN 2003). Dall’altro lato, le politiche del paesaggio, secondo gli orientamenti fissati dalla Convenzione Europea, riguardano l’intero territorio e sono esplicitamente chiamate ad incidere su ogni politica, dall’urbanistica ai trasporti all’agricoltura, che possa comportare la conservazione e la trasformazione del paesaggio. Ma, nonostante la concordanza dei fini e la larga sovrapposizione tra le aree naturali protette e i paesaggi a vario titolo tutelati, le rispettive politiche sono, in generale, sostanzialmente separate: le politiche dei parchi fanno capo ad istituzioni, a strumenti e forme di regolazione e a strategie generalmente diverse, salvo che nel caso di vera e propria sovrapposizione (come per le “aree protette” ricadenti nei “paesaggi protetti” così classificati dall’IUCN, che coprono peraltro più di metà del territorio protetto). Nel caso dell’Italia, la difficoltà del raccordo tra i due ordini di politiche è ben rappresentata dalla contraddizione tra l’art.12 L.394, che affida ai Piani dei Parchi un ruolo “sostitutivo” nei confronti di ogni altro piano, e l’art.145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che attribuisce invece ai Piani Paesaggistici una sorta di primato nei confronti anche dei Piani dei Parchi.
5.5. Nuove alleanze per il progetto di territorio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra dunque profilarsi una doppia necessità di integrazione, delle politiche della natura e del paesaggio con le politiche del territorio. Un ambizioso programma di ricerca in tal senso, avente come campo d’attenzione l’intera Europa, fu presentato a Barcellona nell’ambito del Congresso IUCN (CED-PPN, 2008). L’alleanza tra parchi e paesaggi non può che trovare un terreno comune di applicazione nel contesto territoriale e in una prospettiva autenticamente progettuale. Il “progetto di territorio” (Magnaghi 1998) è stato da tempo indicato come il luogo dell’integrazione degli interessi pubblici diversi, della valutazione e composizione dei valori e dell’orientamento strategico delle politiche di regolazione dei processi trasformativi. E già 50 anni fa documenti come la Carta di Gubbio (ANCSA, 1960) attribuivano al Piano Regolatore il compito di delineare le “azioni d’insieme” necessarie per il risanamento dei centri storici,.Molti altri problemi attinenti l’insediamento umano hanno concorso in seguito a complessificare ed aggravare la questione urbana, sollecitando politiche pluritematiche convergenti, in grado di contrastare la settorialità dell’azione pubblica e la sua schiacciante dipendenza dalle logiche dell’emergenza E’ difficile pensare che esse possano fare a meno del “progetto di territorio” latamente inteso, come processo sociale ampio e condiviso, capace di rispecchiare, per dirla col Sereni, i “disegni territoriali” delle popolazioni locali. Processo che non può evitare di muoversi in un orizzonte cooperativo, in cui l’azione fondamentale dei soggetti e dei poteri locali trovi i necessari riscontri a livello regionale, nazionale e sovra-nazionale.
Riferimenti bibliografici
- ANCSA, 1990: La nuova Carta di Gubbio. Un contributo italiano alla riqualificazione della città esistente, XI Convegno-congresso nazionale, Gubbio.
- -- 1997: Patrimonio 2000. Un progetto per il territorio storico nei prossimi decenni, XII congresso naz., Modena.
- Bauman Z., 2008: La solitudine del cittadino globale, UE Feltrinelli, Milano.
- Castelnovi P., 1998: Rel. introduttiva al Seminario Il senso del paesaggio, ISSU, Torino.
- Cattaneo C., 1845: Industria e morale, in Atti della Società d’Incoraggiamento d’arti e mestieri, Milano.
- CoE, Consiglio d’Europa, 2000: Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze.
- CED-PPN (Centro Europeo Documentazione Pianificazione dei Parchi Naturali), 2008: Parchi d’Europa, ETS, Pisa.
- Choay F., 1993: L’allegoria del patrimonio, Officina, Roma.
- Dematteis G., 1995: Progetto implicito, F.Angeli, Milano.
- Donadieu P.,2006 La campagna urbana ( a cura di M.Mininni), Donzelli, Roma.
-Finkielkraut A., 2003: Il fantasma antisemita che attraversa l’Europa, La Repubblica, dicembre 2003
- Kushner J.A., 2008: Global Climate Change and the Road to Extinction,Caroline Academic Press, Durham.
-Gabrielli B.,(a c.), 1997: Patrimonio 2000: un progetto per il territorio storico, Rel. -Congresso ANCSA, Modena.
- Gambino R., 1983: Centralità e territorio, Celid, Torino.
- Gambino R.,1994, “Luoghi e reti: nuove metafore per il piano”, in Archivio di studi urbani e regionali, 1994, Milano
- Gambino R., 1997: Conservare Innovare, Utet Libreria , Torino
- Gambino R., 2000: Reti ecologiche e governo del territorio, in Parchi, n.29/2000.
- Gambino R., 2002: Parks Policies: a European Perspective, in Environments Studies, vol. 30, n.2. Toronto.
- Gambino R., 2009: Parchi e paesaggi d’Europa, Lectio Magistralis, Politecnico di Torino, Torino.
- Gambino R., 2010, Landscape Analysis and Planning, Unesco Master on World Heritage at Work, Turin.
- Howard E., 1898: Garden Cities of Tomorrow, London.
- Harvey D., 1990: La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano.
- Hillman J., 2011:”American Psyche” intervista su La Repubblica, 13/3/2011.
- IUCN (the World Conservation Union) 1994: Guidelines for Protected Area Management Categories, Gland:.
---2003, Vth World Parks Congress: Benefits beyond Boundaries, Durban.
- Lefebvre H., 1970: Il diritto alla città, Marsilio, Padova.
-Magris C., 1997: Microcosmi, Garzanti ed., Cernusco s.n.
- McHarg J, 1966 : “Ecological Determinism « , in FF.Darling, J.P.Milton, ed., Future Environments of North America, The National History Press, Garden City, New York
- Magnaghi A., 1998: Il territorio degli abitanti, Dunod, Milano;
---2010: Manifesto della Società dei territorialisti (bozza in corso di pubblicazione).
- Marsh G.P. 1864: Man and Nature, Ch. Scribner, New York
- Mazza L. 1990: “Il suolo ineguale”, Urbanistica n.98, 1990.
--Raffestin C., 1977: Paysage et territorialité, Cahiers de Géographie de Québec, vol.21, septembre-décembre.
-Schama S.,1997: Paesaggio e memoria, Mondadori, Milano
- Secchi B., 1990: “Tre Piani”, in Urbanistica n.98, 1990;
----, 2011: “La nuova questione urbana, in CRIOS n.1/2011.
-Sen A., 2006: Identità e violenza, Laterza, Bari.
-Tiezzi E., 1998: “Il capitale naturale tra evoluzione e conservazione”, Oikos n.4/98.
- Touraine A. 2008: “Ecco come muoiono i nostri valori universali”, LaRepubblica, 22/2/2008.
- UNESCO, 1972: Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris.
- UNESCO, 2009: Investing in Cultural Diversity and Inter-culture Dialogue, Gland.
- von Humboldt A., 1860: Cosmos. Saggio di una descrizione fisica del mondo, Venezia.
-von Petz U., 2004: “Sulla provenienza”, Critica della razionalità urbanistica, n.16/2004 Alinea, Napoli.
- Zagrebelsky G., 2008: “Valori e diritti”, La Repubblica, 22/2/2008.
Compiti per le Vacanze: Io sono Appennino
L’Appennino, unità olistica che comprende gli appennini locali, è un’immagine con un’identità complessa e multipla, indescrivibile a priori nelle sue generalità ma certamente presente nella nostra geografia personale.
E’ un’immagine indescrivibile astrattamente perché è fatta di una molteplicità di ingredienti, come il piatto di verdure cucinate che nel Mediterraneo si declina tra ratatouille e ciambotta, tra caponata e briami: ingredienti riconoscibili e sempre compresenti, ma in proporzioni e trattamenti diversi a seconda delle tradizioni locali. Così per l’Appennino: ci sono alcuni aspetti e modalità di sguardo presenti comunque e dovunque, ma dosati in misura per ciascuno diversa in base alle sue storie e alle sue competenze (insider o outsider, settentrionale o meridionale, indirizzato alla natura o alla storia, operativo o riflessivo etc.). Così ognuno arriva a una sua propria sintesi di riferimento che configura non solo un’immagine ma anche un peculiare criterio valoriale riferito all’idea di Appennino. E’ un senso che si usa sistematicamente nei giudizi e nelle scelte, anche senza rendersene conto: un senso dell’abitare (e dell’essere) “appenninico” .
Dunque, per esplorare la vision dell’Appennino dobbiamo ascoltare la descrizione di chi se la sente di dire:
IO SONO APPENNINO
Proponiamo quindi di avviare una riflessione sulle sintesi soggettive del senso generale dell’Appennino che ciascuno ha elaborato, per conto proprio, nella sua vita.
Per rendere confrontabili le sintesi ricorriamo ad un modo molto schematico e semplificato, gestibile come un gioco: sulla base di una traccia organizzata come una ricetta si richiedono a ciascuno le personali dosature di ingredienti prestabiliti (salvo aggiunte, sempre benvenute).
D’altra parte ciascuno di questi ingredienti dell’idea generale che abbiamo dell’Appennino, alimenta qualche sfaccettatura della nostra visione strategica della qualità della vita, almeno se siamo tra quelli che vogliono abitare la compresenza (di passato e futuro, di nord e sud, di città e campagna, di comune e di personale,…).
Dunque accreditare una visione multipla e complessa del senso dell’abitare a partire dall’Appennino può diventare un buon modo non solo per rafforzarne il valore, ma anche per dare spazio e luogo a chi cerca una qualità della vita più etica ed estetica di quella che ci passa il normale modello metropolitano.
Il primo campione cui chiedere di giocare è costituito dai partecipanti alla giornata dell’incontro di Treia dedicata all’Appennino: ovviamente son benvenuti tutti gli altri disponibili a compilare il test in agosto.
Partecipa all’indagine compilando il test: quota in % ciascuno dei temi qui sotto proposti
secondo la sua incidenza nella tua vision personale dell’Appennino
|
1. Una schiena abituata ai carichi |
|
|
2. Il ponte verde tra le città |
|
|
3. La terra del nostro pane quotidiano |
|
|
4. La resilienza che si inventa ogni giorno |
|
|
5. La civildiversità come bene comune |
|
|
6. Piccolo è bello, se è in rete |
|
|
7. Si passa perché c’è chi resta |
|
|
8. Esperienze primarie per la qualità della vita |
|
|
9. Altro: Descrizione |
|
|
Il tuo nome e un tuo motto di sintesi |
100 |
|
tema |
1 Una schiena abituata ai carichi |
2 Il ponte verde tra le città |
3 La terra del nostro pane quotidiano |
4 La resilienza che si inventa ogni giorno |
5 La civildiversità come bene comune |
6 Piccolo è bello, se è in rete |
7 Si passa perché c’è chi resta |
8 Esperienze primarie per la qualità della vita |
|
risorsa |
struttura profonda |
riserva di naturalità |
modello di territorio rurale preindustriale |
luogo di equilibri produttivi sostenibili |
terra dei Liberi Comuni e della Resistenza |
reti consolidate nell’uso di servizi e filiere produttive |
insediamento aperto al transito abituale degli altri |
paesaggio del silenzio e dell’arcano |
|
Indice del racconto |
La spina dorsale della penisola: una tettonica molto antica che si assesta ogni giorno, resistendo all’impatto sismico di placche continentali |
Un sistema quasi naturale in quota che fa sentire i suoi effetti sino al mare e al piano. Il mediatore del global change nel Mediterraneo. |
L’anticittà come modello vitale: un territorio adatto all’integrazione dell’innovazione nei sistemi rurali tradizionali |
Il senso del luogo e della continuità contro gli strappi dell’azienda produttiva autocentrata e sradicabile: si innova per resistere alle crisi e non per una ubris di cambiamento |
Il sentimento partecipato e diffuso di autonomia e di indipendenza. Modelli gestionali del territorio, impliciti, basati su solidarietà locale e sobrietà |
Piccoli poli specializzati (università, centri di ricerca, produzioni innovative) resistenti perché in un territorio storicamente ricco di reti tra i centri |
Abitare sugli incroci impossibili: la transumanza in quota, i passi in valle, in mezzo gli abitanti resilienti anche ai terremoti |
Piaceri dell’anima ormai rari: la solitudine, la vista vasta, i siti e i cammini del sacro, |
|
immagine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immagine 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Per il paesaggio: dalle regole al riconoscimento operoso
Il piano paesaggistico piemontese è il tentativo più maturo di mettere a punto un paradigma operativo per valorizzare il paesaggio, utilizzando al meglio i piani urbanistici.
Ma il tentativo mostra i limiti profondi della macchina regolativa di governo del territorio, pur prodotta dalla migliore legislazione urbanistica regionale, e del paesaggio, pur con le migliori intenzioni del Codice.
La storia delle scelte di metodo del Piano piemontese evidenzia, oltre ai limiti, una prospettiva interessante, che è rimasta sottotraccia, ma che potrebbe motivare nuovi accordi per il paesaggio.
For Landscape: from rules to the engaged recognition
The Piemonte Landscape Plan is the most mature effort of developing an operative paradigm to enhance landscape, making the best use of urban plans.
The attempt, despite the good intention of the law, shows the deep constraints of governmental regulation even though those rule are the result of the best regional urban an landscape legislation.
The history of the choices of the Piemonte Plan points out, besides the limits, an interesting scenario that remained undisclosed until now, which could inspire new partnerships for the landscape.
1. Il paesaggio nel piano contribuisce alla perdita di grip delle regole universali
Per raccontare l’impostazione sperimentale del Piano paesaggistico piemontese partiamo da lontano, perché il PPR cerca di affrontare alcuni temi irrisolti negli ultimi 70 anni nella storia italiana di gestione del territorio.
Per una legge ciclica che solo sospettiamo, vista la sua ricorrenza, molti meccanismi di funzionamento della società perdono efficacia e credibilità, proprio mentre il loro assetto istituzionale sembra consolidarsi e diventare pratica ordinaria. Ora è il turno delle riforme di una cinquantina d’anni (10 più 10 meno): la scuola, la sanità, il decentramento regionale sono in crisi strutturale. Anche la cultura delle regole urbanistiche, coeva a quelle riforme nelle sue leggi fondamentali, ormai sistematicamente applicata, sta volgendo al tramonto.
E’ un processo di sclerosi che si è svolto sottotraccia da oltre vent’anni, che dobbiamo rileggere per capire le ragioni dell’attuale situazione di stallo, quando da una parte non ci si può più affidare alla norma urbanistica per qualificare lo spazio pubblico ma dall’altra non si hanno altri strumenti efficaci per convogliare le singole energie progettuali al bene comune della città e del territorio.
La sconsiderata separazione tra urbanistica e progettazione, consumatasi fin dentro il corso di studi, ha favorito la formazione di una doppia professionalità: quella dell’applicazione sistematica delle regole per attuare i piani e quella del loro aggiramento per dare spazio al progetto. Come per giocare a guardie e ladri, per ciascuno dei due ruoli sono maturate etiche, ossessioni e furbizie mirate contro l’altro ma compartecipanti in una sorta di sacra rappresentazione, un rito al quale ormai ci stiamo abituando: l’urbanista predica una normalità neutra, ordinata, ottocentesca; il progettista invoca il segno, l’emergenza, la sregola come espediente della contemporaneità per farsi notare.
In questa dialettica esasperata, legittimata dal contrasto “alto” tra il progetto e la regola, ha trovato spazio la peggiore sciatteria e il disprezzo di quel bene comune che l’urbanistica in teoria cerca di garantire: la qualità funzionale e identitaria della città in costruzione. Si verifica, caso per caso, l’incapacità della norma a indirizzare alla qualità il disegno urbano quando si costruisce e a limitarne il degrado quando lo si gestisce.
D’altra parte si deve tener conto che la legge obbliga tutti i comuni ad approvare il piano regolatore, in cui si applicano norme standardizzate e parametriche a situazioni molto diversificate e caratterizzate. Ciò dipende dalla “necessità” di univocità della norma: un mito tecnico e addirittura morale del nostro tempo, mentre semmai sarebbe più corretto per il bene comune richiedere un medesimo livello di qualità delle prestazioni di interesse generale, ottenendolo “naturalmente” con modalità diversificate in base alle diverse situazioni.
L’incapacità dell’urbanistica a tener conto delle specificità di ogni luogo è stata tamponata con quella sorta di deroga che si è inventata per le zone A (dopo lunghe battaglie culturali e politiche), salvando i centri storici da scempi perpetrati in nome proprio delle regole uniformi di costruzione della città. Ma non è accaduto lo stesso nei confronti della città che si espande verso la campagna.
D’altra parte, negli ultimi 30 anni alcune qualità del territorio aperto sono state difese dalla cultura ambientalista, che ha portato al rispetto di valori sino ad allora sconosciuti (nel dopoguerra il PRG cingeva le città di “zone bianche”, hic sunt leones, le terre non urbane, considerate unicamente in quanto riserve a disposizione dei futuri piani di fabbricazione). La cultura ambientalista ci ha fatto forti di norme di rispetto e attenzione, importanti ma del tutto a-progettuali, e a-locali. Lo strumento più utilizzato per gestire la relazione ambientale dei nuovi interventi, la “valutazione d’impatto”, teoricamente esamina gli effetti positivi e negativi delle trasformazioni, ma di fatto considera (per lo più in modo inutile ed edulcorato) solo gli effetti negativi dei progetti e dei piani. Ogni intervento viene misurato con indici standardizzati di incidenza sull’ambiente ed è considerato necessariamente dannoso. Nella procedura di valutazione il soggetto pubblico assume le vesti di badante di un malato cronico senza speranza, il territorio, per il quale si cercano di attenuare le peggiori conseguenze, cercando di limitare l’incidenza delle azioni proposte, a prescindere.
Ma da una ventina d’anni, quando l’urbanistica è un fortino assediato che resiste invocando la qualità etica delle norme uguali per tutti, si fa avanti una cultura del paesaggio che sdogana la soggettività, esalta la qualità percepita e le specificità locali, introduce tra i compiti della mano pubblica anche la promozione e la valorizzazione e non solo la conservazione. In pratica si propone di applicare all’intero territorio le attenzioni rivolte ai centri storici.
E’ un colpo fatale al mito dello standard che in nome dell’equità normativa azzera le differenze. Si deve rivedere il modo di applicare le attenzioni di interesse generale e si richiede una nuova “tecnica” per valorizzare il territorio conservandone l’identità e le caratteristiche locali.
Ecco: il piano paesaggistico piemontese, oltre dieci anni fa, muove da un contesto culturale, tecnico e politico di questo genere, che attende non solo uno strumento innovativo, ma un paradigma logico e un riferimento metodologico che argini le aporie dell’urbanistica e in generale della gestione del territorio.
Si pone però un caso di doppio vincolo quasi irresolubile: il paesaggio e la progettualità di interesse comune impongono attenzione alle caratteristiche particolari dei singoli luoghi, mentre il piano regionale agisce a una scala che non può tener conto della situazione specifica.
2. La risposta all’ubris normativa del Codice: regole per ambiti, regole per beni
Il Codice dei beni culturali, nel 2004, affronta il paesaggio muovendo da una evoluzione discontinua del concetto e delle sue definizioni operative. Da una parte è occorso metabolizzare la definizione storica, che considera alcuni pochi selezionati paesaggi come beni irripetibili e cerca di conservare qualità “viventi” applicando ingenuamente le provvisioni degli altri beni culturali, immobili. D’altra parte si è dovuto far fronte all’irruzione degli aspetti ambientali portati dalla legge Galasso, che sottopone ad attenzione oltre un terzo del territorio e poi alla Convenzione europea, che considera paesaggio ogni “singola parte” del territorio.
Va anche considerata la polemica specifica in cui si muove il Ministero dei Beni culturali, nei primi anni 2000, sottoposto a un’intensa critica per la soggettività nei controlli autorizzativi, e per la mancanza di criteri espliciti di riferimento e di argomentazione nelle valutazioni. La procedura incontrollabile dei controllori diventa insostenibile a fronte dell’aumentare vertiginoso ed eterogeneo dei casi da autorizzare.
Insomma una formalizzazione dei termini della procedura autorizzativa era politicamente richiesta.
Con il Codice si raccoglie la sfida e ci si sforza di coniugare l’attenzione ad hoc, allo specifico dei luoghi e dei beni, con una strumentazione regolativa normalizzante, per categorie, che è propria dei piani urbanistici.
È come raccogliere violette coi guantoni da boxe: la legge illuminista, uguale per tutti, non è compatibile con la considerazione olistica e progettuale che viene richiesta per valutare le mille situazioni in cui versa ciascun bene. Imporre attenzioni uniformi a tutto ciò che sta entro 150 metri dalle rive di un fiume appare immediatamente come una scelta rozza e da perfezionare, a cui non si può sempre sfuggire con la mannaia della negazione assoluta di ogni intervento.
Ma comunque nel Codice si sceglie di normare tutto, declinando con differenti ordini di prescrizioni le attenzioni ad oggetti di diversa complessità e dimensione e scaricandone l’onere tecnico sui piani regionali.
Ad essi si richiede di individuare gli ambiti di paesaggio come dimensione adatta per distinguere le diverse caratteristiche del territorio, e si ordina di predisporre specifiche normative d’uso a quella scala: un’invenzione senza precedenti, sia perché l’uso non è mai stato oggetto specifico di norma, sia perché la dimensione territoriale degli ambiti sfugge a norme efficaci sul piano del vincolo giuridico.
D’altra parte si utilizza l’occasione dei Piani regionali per ottenere anche una schedatura per ciascuno dei beni vincolati che possa contenere “prescrizioni intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi”, e lo stesso si richiede per le aree di interesse paesaggistico della legge Galasso, anche se si sa che esse coprono oltre il 40% del territorio e non possono essere normate specificamente, a meno di non essere i funzionari della Mappa dell’Impero in scala 1:1, di borgesiana memoria.
Nella redazione del Piano paesaggistico piemontese, nel 2007, ci si è trovati a sperimentare la (allora) nuova procedura individuata dal Codice, provando a districarsi nella congerie di versanti normativi richiesti.
Alla fine si fanno convivere diversi strumenti regolativi:
- una specifica molto precisa per ogni bene paesaggistico vincolato, la cosiddetta “vestizione dei vincoli”, che risponde al requisito di esplicitare i criteri di attenzione da seguire in ogni intervento su quei luoghi specifici, al costo di uno sforzo descrittivo ponderosissimo ma purtroppo necessariamente statico (e quindi inadeguato man mano che il tempo passa);
- una generica indicazione degli aspetti di insieme di cui tener conto negli ambiti di paesaggio (grandi mediamente 18/20 comuni) e nelle “unità di paesaggio” che li compongono, di dimensioni molto minori, che individuano contesti sottoposti a omogenei processi trasformativi, con indirizzi di attenzione e il rinvio di verifica dell’efficacia normativa ai piani d’area vasta o locali;
- una normativa per “componenti” (della struttura regionale del paesaggio), categoria del Piano piemontese che comprende anche i beni paesistico ambientali del Codice derivanti dalla Legge Galasso: fasce territoriali da precisare nei loro confini e regole di attenzione da declinare in modo prescrittivo nei piani locali, per ciascun tipo di bene.
E’ un quadro normativo complesso, che fa fronte all’insieme delle indicazioni del Codice, ma che di fatto dribbla il doppio vincolo omogeneità generale/specificità locale, rimandando alle Province e ai Comuni l’onere della declinazione locale delle regole per gli ambiti e della precisazione delle parti del territorio a cui applicarle per le componenti.
3. L’interpretazione e il riconoscimento delle relazioi identitarie e delle strategie locali
Per aiutare gli enti locali a superare le difficoltà e i limiti del versante normativo imposto dal Codice, nel Piano piemontese si affronta il tema del paesaggio con un’impostazione multitasking. Roberto Gambino, coordinatore scientifico del Piano, propone una tripartizione paradigmatica, dopo averla sperimentata in altri piani d’area vasta. In tale impostazione la funzione regolativa non è il vertice a cui tutto il Piano è inteso, ma è accompagnata, pari grado, dalla funzione strategica e da quella conoscitiva.
Il ruolo della funzione strategica assegna al piano regionale il compito che sta alla base dei piani europei, spesso avarissimi di regole e invece centrati sul coordinamento e la promozione di programmi strategici di azione locale e di buone pratiche. E’ un’apertura alla programmazione e all’intesa politica tra i vari settori, che negli anni potrebbe dare splendidi frutti, anche se per ora ciascun ufficio regionale continua a programmare per proprio conto.
Ma il compito innovativo è assegnato alla funzione conoscitiva: dal ruolo ancillare e di servizio previo, a cui è condannata nel resto dell’urbanistica e della pianificazione, ad un ruolo di proposta interpretativa, che tenta di dare strumenti sistematici e in progress a comuni e province, per superare i problemi della specificità locale, imprendibile a scala regionale, e della rigidità delle regole generali, spesso inutili o dannose a scala locale.
La proposta del piano è di collaborazione interistituzionale. Con un’azione culturale, di riconoscimento del proprio patrimonio secondo il modello interpretativo proposto dal piano regionale, comuni e province dovrebbero poter articolare, in modo condiviso e credibile politicamente, le regole che nel piano definiscono in modo generale e schematico le modalità di salvaguardia e di valorizzazione del paesaggio.
A comuni e province è proposto, nell’ambito del previsto adeguamento dei propri strumenti di governo del territorio, di completare l’indagine e l’interpretazione dei valori presenti secondo il nuovo modello predisposto per il piano regionale, che tenta di facilitare la progettualità ad hoc, ove rispettosa del paesaggio locale e delle relazioni sistemiche d’area vasta, per la prima volta definite e in parte individuate.
Il quadro di indagine proposto è indirizzato a declinare i valori del territorio in modo da farli riconoscere alle diverse scale e a facilitare l’attuazione locale del piano attraverso regole e strategie ad hoc, in particolare evidenziando filoni interpretativi inediti ma fondamentali per il paesaggio:
- il ruolo delle relazioni locali,
per cui al centro dell’attenzione si pongono le relazioni (di omogeneità o di complementarità) tra diversi elementi presenti, stimolando a riconoscere il valore di ogni emergenza (un castello, una cascata, un grattacielo,) o di ogni tessuto (un versante a vigneto, una stazione di villeggiatura, un sistema di nuclei storici di crinale,) non in sé ma come prodotto di un effetto di posizione, di situazione ambientale, di processo storico o di assetto costruito che portano a valorizzare non solo l’oggetto in questione ma soprattutto le relazioni con il contesto locale o temporale. Gli elenchi di edifici e luoghi tradizionalmente utilizzati per delineare le caratterizzazioni d’ambito vengono sostituiti da indicazioni di sistema (naturale e/o storico) che rendono comprensibili più facilmente le regole relazionali da seguire;
- il ruolo delle reti sovralocali,
per cui si tracciano le connessioni fondamentali delle reti ambientali, storiche e funzionali che, a livello sovralocale, disegnano i grandi tratti distintivi del paesaggio regionale (i corridoi ecologici, le infrastrutture storiche, le grandi relazioni visive, ..), e si richiede che la valorizzazione di tali nessi, rilevanti ad una scala così grande che spesso non sono percepiti a livello locale, venga invece assunta alla base delle scelte localizzative delle trasformazioni territoriali locali;
- l’interpretazione strutturale e l’articolazione in componenti,
per cui si abbozza uno schema di relazioni fondamentali del paesaggio regionale (la struttura) per rendere possibile la distinzione degli aspetti specifici per cui una sua parte (una componente) va tutelata e valorizzata. Un fiume non interessa tanto come corpo idrico ma per il segno curvilineo che lo rende riconoscibile, per la continuità della fascia vegetale attorno, per il ruolo di corridoio ecologico che svolge. Perciò interessa molto non rettificarlo, non pelarne le rive, non interromperlo tombandolo o ponendo uno sbarramento insormontabile. Capendo il ruolo strutturale delle componenti, caso per caso, si distinguono e si rendono comprensibili le attenzioni da porre, e, senza eccedere in generici divieti, si consente di definire le più opportune condizioni di compensazione e di attenuazione dei casi di impatto;
- il ruolo delle dinamiche trasformative,
per cui si articola il territorio riconoscendone lo stato dei processi trasformativi in corso, spesso del tutto indipendente dai valori relazionali e strutturali evidenziati con il resto dell’indagine. Così si fa entrare nella gestione del paesaggio la dimensione temporale, riconoscendo l’esistenza di processi di produzione continua di paesaggi, condivisi dalle popolazioni anche se ben poco identitari, ben diversi da quelli cristallizzati nel piano. Quindi si identificano i luoghi come unità base del paesaggio, da queli in cui i processi trasformativi sono accelerati e stanno producendo assetti completamente nuovi, periferie in cui il cambiamento continuo delle forme è una parte importante della percezione del paesaggio, a tutti i gradi intermedi sino a quelli stabili, dove anche il più piccolo cambiamento è percepito come alterazione grave. Capendo le dinamiche in corso è possibile individuare gli interventi necessari a stabilizzare i processi, a ridurre il “rumore” generato dal cambiamento continuo, e quindi a riportare l’attenzione e il senso identitario sugli aspetti strutturali del territorio.
In questi termini l’ipotesi operativa che sta alla base del PPR è che il quadro conoscitivo e il suo metodo, adottato come motore di indagine e di interpretazione locale possa diventare il viatico per declinare le regole generali sul territorio. La macchina regionale dovrebbe favorire gli sforzi di ogni ente locale per riconoscere le qualità del proprio territorio, secondo le impostazioni strutturali e relazionali del PPR. Su quella base dovrebbero essere provate buone pratiche e facilitate procedure per disegnare i nuovi PRG, come già la Regione aveva tentato con gli Indirizzi di qualità paesaggistica degli insediamenti, rimasti un esercizio accademico anche perché non muniti di connessioni operative con le procedure ordinarie di pianificazione.
Ma il processo deve diffondersi, non può restare un compito d’ufficio, un dovere burocratico cui ottemperare per poter variare il solito vecchio PRG. Occorre chiamare a dare una mano quelli, e sono tanti, che comunque al paesaggio, alle relazioni storiche e ambientali, alle caratteristiche locali stanno dedicando le loro imprese, il loro tempo libero, la loro azione politica. Con loro il riconoscimento diventa non un lavoro scolastico e tecnico, ma un processo operoso, carico di progetti, favorendo anche i singoli che usano bene il proprio territorio. Insomma, per il riconoscimento operoso delle relazioni paesistiche caratterizzanti occorre mettere a frutto il paesaggio attivo, come ho provato a delineare nell’articolo pubblicato sullo scorso numero di questa rivista.
Ricominciare dal Paesaggio Attivo
1. Sempre più difficile sentirsi cittadini della propria città
I nostalgici dei luoghi di ogni cittadina hanno il loro ritrovo sul web. Formano comunità folte, trasversali le formazioni culturali più diverse, disinteressate d’altro che non sia la fascinazione della propria città, non oggi, ma “com’era”.
Chi, ogni giorno, mette in mostra una cartolina di 50 o 100 anni fa, sa di innescare una sorta di corrente emozionale collettiva, che mescola brandelli di vissuti personali e di miti urbani. Si commenta ringraziando il pubblicatore per la scintilla che ha animato il ricordo, come una canzone di gioventù, ci si vanta di individuare luogo e tempo delle immagini partendo da particolari significativi solo per i veri esperti. E’ un gioco di società, apparentemente senza regole, ma di fatto riservato a chi ha mantenuto memoria dei luoghi che ha vissuto (o che gli hanno raccontato e che ormai appartengono al proprio mito personale, come i Lari antichi).
Ad animare i gruppi del “come era” è la nostalgia, quella che Claude Raffestin pone alla base del senso del paesaggio: il desiderio di qualcosa che non c’è più. Ma se si pone attenzione a quel rito di post, di commenti, di complimenti e di lamenti si capisce che la nostalgia non riguarda tanto i luoghi quanto una relazione che tradizionalmente appartiene all’abitante: una vera e propria competenza della città, che era conosciuta come una pertinenza di casa propria, in ogni androne, ogni negozio, ogni slargo che era percorso a piedi, in mezzo agli altri. Era un senso del paesaggio urbano che si costituiva come bene comune: i suoi partecipanti erano concittadini non solo per la condivisione dello stesso spazio, ma soprattutto per la condivisione della stesa competenza spaziale.
Certamente la città di allora era più piccola, con una struttura dello spazio pubblico potente, organica, che in quegli anni si era qualificata con l’impegno dell’intera società. I cittadini andavano fieri delle loro piazze, ogni ricorrenza riempiva le Poste di “cartoline illustrate”, che appunto mettevano in mostra le bellezze dei propri luoghi. Si esibivano i monumenti storici, ma anche le novità: i nuovi giardini, i quartieri recenti, fino ai caffè o ai grandi negozi.
Era la faccia concreta del Comune, il patrimonio che il cittadino attivo considerava “suo”. Solo per questo senso ancora vivo, di “proprietà culturale” del proprio territorio, le migliaia di Comuni italiani sono tutt’oggi irriducibili e resistono alle disfunzioni che la loro dimensione minuscola comporta. Ma dei Comuni, anche quelli dell’Italia “rugosa” cara a Fabrizio Barca, è certamente il capoluogo, che in Italia è una città, per piccolo che sia, a raccogliere gli aspetti di valore dell’identità e l’immagine dell’attaccamento radicato alla propria terra. Non c’è dubbio che il senso di cittadinanza sta nei borghi e nelle piccole città: è in quelli che diventa tangibile nelle forme di un senso di sicurezza e di partecipazione irripetibile. Un paesaggio che produce cittadinanza è città, e lo sanno bene quelli che ritornano al paese, sentendolo proprio e forte più ancora delle città in cui sono consegnati dalla vita, dove si sentono (non a caso) “spaesati” per decenni.
Ma la figura retorica dei “ritornanti” non basta a spiegare la potenza delle città (grandi o piccole) tradizionali: l’urbanizzazione sino a pochi anni fa è stata una risorsa fondamentale per tutti, indigeni e non. I nuovi arrivati sono attratti dalla fama della città come luogo delle opportunità, ma queste sono captate solo da chi sa cercarle, non solo nei rapporti sociali ma anche, fisicamente, nel complesso labirinto di pietra e gente. Chi approda dalla campagna sa che l’essere “cittadino” comporta la conoscenza sistematica dello spazio pubblico urbano. Quindi per l’abitante consolidato il rapporto con la città è un fattore identitario attivo, ma per tutti è una vera e propria competenza: solo per chi la conosce si rivela un habitat fecondo, dove appare più facile sviluppare il proprio progetto.
Oggi chi partecipa ai gruppi Facebook del “com’era” percepisce una diversa potenza rappresentativa della città dei padri rispetto a quella odierna. La città di allora era familiare, come un grande vicinato di quartiere, mentre oggi non ci si riconosce più in quella attuale che sta diventando un non-luogo. Un abitante allora poteva vantarsi di conoscere spazi e usi ignoti al turista, aveva un’esperienza diretta e specifica dei segni della “sua” città; oggi tutti sono oggetto della stessa comunicazione commerciale, poco dedicata e poco differente da una capitale all’altra.
Certamente questa perdita di complessità e di specificità diventa stridente nei territori dove gli abitanti sono eredi di giganteschi investimenti culturali (e spesso economici), che intere comunità hanno fatto per generazioni sulla loro città. Soprattutto in Italia, dove il senso millenario del “Comune” sta alla base delle nostre città, è eclatante il senso corale delle storie locali.
Lo sforzo epocale compiuto per secoli da migliaia di cittadini per qualificare il loro spazio ci appare inconfrontabile con il modo che abbiamo oggi di abitarlo. Oggi non ci sentiamo più proprietari a buon diritto delle nostre città, il diritto di chi si sente di aver partecipato alla loro produzione, ma ci sentiamo city-user, ospiti di città fatte da altri, progenitori così lontani da non sentirne più né la fatica né il lascito.
Non siamo ancora del tutto consapevoli di aver perso il senso del paesaggio urbano, ma abbiamo continuamente una sgradevole sensazione: di non sentirci più cittadini, di stare perdendo il contatto vivo e verificato ogni giorno con i valori di quella comunità che finora si è identificata con gli spazi e le relazioni fisiche della nostra città. Si spiega così quella sorta di saudade del paesaggio che si sta diffondendo nel territorio contemporaneo, di cui i gruppi nostalgici su Facebook sono uno degli esiti visibili: la punta di un iceberg di magone dei vecchi e di smarrimento dei giovani.
D’altra parte si tratta di un processo in corso in tutti i paesaggi italiani: anche in quella “campagna” che una volta era frutto della competenza di chi la coltivava (oltre che abitarla) e che oggi è ormai sommersa da strati di cose e segni non rurali e da modalità di coltivazione uguali dappertutto, come una sorta di gramigna culturale invasiva e inutile, che fa perdere il senso di “proprietà” dei luoghi anche ai figli di chi ancora fa di mestiere l’agricoltore, e quindi fisicamente produce quel paesaggio.
Ormai i giochi sono fatti: la semiologia del paesaggio, urbano e non, si sta semplificando e soprattutto si sta omogeneizzando: ci mancano i centri di attenzione significativi della nostra storia e del nostro progetto e finiamo per essere accampati in una gigantesca periferia dove non si generano più differenze sostanziali e condivise. E questo è grave non soltanto per una difesa generica della diversità paesistica (da rispettare comunque, anche senza davvero capire cosa significa, come si fa per la biodiversità), ma piuttosto per un aspetto strutturale di “cultura politica”.
Infatti se ogni luogo, nella sua complessità e compresenza di tanti elementi, ma anche nella concretezza della sua esperienza quotidiana, non genera più valore culturale, se perdiamo i criteri di riferimento localizzati, che avevamo costruito sulla base delle esperienze dirette nostre o della gente che conosciamo, a cosa affidiamo le nostre scelte, il nostro giudizio sul mondo?
Se perdiamo il gusto degli spazi e dei comportamenti a cui siamo affezionati, che condividiamo con una comunità eterogenea e folta, come è avvenuto sinora nelle città italiane, perdiamo il fondamento esperienziale della conoscenza sentimentale collettiva, quella che è alla base del giudizio politico democratico. La conoscenza della città recente è noiosa e defatigante, se non altro perché manca di incontri e di possibile appartenenza a un senso comune; e d’altra parte come si può fare, se non si incontra nessuno che vada a piedi e che non guardi il cellulare?
I non-luoghi dei nostri supermercati e delle strade di periferia sono ormai solo piccola parte del territorio in cui ci si comporta come in un non-luogo: non è più il contesto a impedirci ogni relazione significativa, sono i nostri tic comportamentali a renderci ciechi e sordi ai segni specifici dell’intorno.
Si è inceppato il nostro miglior strumento di cultura politica, quello che ci assicurava una intrinseca essenza democratica. Infatti, se non siamo più cittadini di una precisa città che ci dà competenza politica a partire dal nostro vissuto, a cui teniamo nella sua complessità e nelle sue contraddizioni, senza ideologie, allora stiamo diventando cittadini generici, astratti, a cui rimangono solo emozioni indirette, generate dai media, dal “sentito dire”, che non verifichiamo più nei contatti quotidiani e nei nostri affetti sedimentati: non abbiamo più materia viva e personale per formarci un’opinione e decidere il da farsi. Si disintegra così il senso di proprietà culturale del territorio che è stato il bene comune fondamentale della storia italiana sin dal Medioevo, inventando il termine Comune per identificare il territorio fatto proprio da uomini liberati dai vincoli feudali.
2. La necessità di rimanere proprietari culturali del proprio paesaggio
Ma se il senso del bene comune è strutturalmente alla scala del campanile e della torre civica, è stata un’impresa culturale e politica romantica farlo diventare parte del “senso della nazione”, quando ciascuno ha portato in dote a una patria ideale il senso di partecipazione concreto e fattuale alla vita della propria città. Tutto il Risorgimento è fatto di questi struggenti doni locali ad altri territori, a cui ci si lega sulla base di spinte emozionali travolgenti: gli emiliani e i toscani, ciascuno a partire dalla propria città, “si regalano” ai Savoia per diventare Italia; i bergamaschi e i bresciani confluiscono a Genova per salire con Garibaldi su due navi e andare a compiere l’opera in Sicilia, accorrendo in un mondo diverso dal proprio, accomunato solo dalla lingua parlata dai colti e dai discorsi esagitati di un gruppetto di intellettuali esaltati.
E’ impressionante constatare che i Mille si muovono in gran parte proprio dalle città libere, quelle che hanno fatto la Storia dell’Arte italiana, per andare ad agitare l’idea del Risorgimento in regioni sonnolente e senza una diffusa progettualità.
Per fare gli italiani, ciò che occorre una volta fatta l’Italia (come borbottò Massimo d’Azeglio), si mise in campo anche l’immenso patrimonio culturale e i mille paesaggi.
In tempi di forte concentrazione nel governo centrale del comando e delle risorse (un modello pericoloso che impegnò tutti, dai liberali ai fascisti), il Touring Club italiano mise mano ad un’opera titanica: la documentazione fotografica di ciascuna regione e città, nella dichiarata convinzione che l’unità della nazione fosse salda solo se ogni comunità si sentiva partecipante, testimoniata nei suoi tesori di piazze e paesaggi.
Il Touring Club si era già impegnato, nei primi decenni del ‘900, a descrivere il nostro territorio con carte e con guide scritte (che rimangono tra le migliori a livello internazionale), ma nulla eguagliò il fascino e la potenza comunicativa del nuovo strumento: la fotografia. In ogni salotto della giovane borghesia italiana facevano bella mostra di sé i volumi azzurri delle regioni, dove ciascuno poteva trovare un’immagine scelta del proprio paese. Ciascuno, nel suo tinello, si è fatta l’idea che la bellezza fosse presente in ogni angolo d’Italia, anche in quelle tante regioni sconosciute, e si è detto che comunque non potevano essere così male se c’erano belle chiese, ricche campagne e castelli come a casa sua!
L’operazione del Touring Club, tenacemente perseguita nei decenni di mezzo del ‘900, attraverso il fascismo, la guerra e la ricostruzione, ha certamente influito nella “costruzione della nazione” non con il metodo sabaudo e fascista, di omologazione del sistema istituzionale, ma con una modalità illuministica, quella dell’Encyclopédie: un affresco del territorio come prodotto corale di migliaia di storie, di saperi, di impegni d’arte e di buone pratiche.
È stato un messaggio che in quegli anni ha stimolato, oltre ogni aspettativa, il senso di appartenenza ad un’idea di Paese fatto come un gigantesco patchwork di paesi, compreso il proprio, riducendo drasticamente la sensazione di colonizzazione che l’accelerato processo di unificazione nazionale aveva comunque comportato in molte regioni.
Questo cambiamento di scala dell’identità collettiva è stato possibile solo grazie ad una forte e condivisa identità di ogni città e territorio, sicura di sé, proattiva, non gelosa, capace di darsi, su cui (e non “contro cui”) si è fondato il progetto culturale dell’Italia unita.
L’incredibile retroprocesso oggi in corso, di regioni e città che “rivogliono indietro” la loro dedizione alla nazione di 150 anni fa, è ormai la manifestazione plateale del disagio che comporta la crisi dell’identità locale. E’ uno degli autoinganni che si mettono in scena per rappresentare la crisi identitaria come un misfatto la cui colpa si addossa ad altri, come se l’identità fosse un bene rubabile dai nuovi venuti.
Al contrario aiuterebbe la consapevolezza che la crisi è generata da un processo endogeno, che si innesca quando gli investimenti culturali collettivi di molte generazioni si riducono fino ad azzerarsi e ad essi si preferisce la polverizzazione degli investimenti (culturali, economici e istituzionali) per ottenere un benessere individuale.
Purtroppo finisce che è proprio il senso di mancanza dell’identità collettiva a diventare uno dei pochi tratti ancora riconoscibili di quell’idem sentire a cui si appoggiano le proposte politiche attuali, deboli anche perché partono solo da un disagio (in primis culturale) e non riconoscono le cause generatrici e le risorse (in primis culturali) necessarie per superarlo.
Sono per lo più proposte deboli perché autistiche e chiuse, paradossalmente impegnate a parole a difendere, arroccandosi, una cultura che è nata e si è sviluppata nell’integrazione e nell’accoglienza, che ha l’apertura agli altri e alle altre esperienze nel proprio DNA, per questo unico e apprezzato.
Sino ad ora si è tentato di far fronte a questo disagio con politiche centralistiche, miranti a salvaguardare il grosso del patrimonio, non fidandosi della capacità d’azione positiva delle mille città e senza dedicare energie e progetto a un coinvolgimento di risorse umane per attivare insieme tutti i territori e con una chiamata di corresponsabilità degli enti locali. È un limite esiziale dei programmi istituzionali per la nostra cultura e per la nostra terra. Lo mostrano i fallimenti clamorosi, sul piano politico, dei programmi strategici per i nostri beni culturali, sempre orfani del paesaggio, come quello di lancio dei grandi musei a scapito dei territori, o degli interventi emergenziali, come gridano dal cratere del terremoto migliaia di abitanti costretti all’inazione, prigionieri di un centro decisionale che dopo tre anni ancora non agisce.
D’altra parte non si è neppure provato, fuori dalle istituzioni centralistiche, ad attivare strategie gestionali sostenibili. Sui princìpi tutti sono d’accordo: ogni iniziativa di conservazione o di valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli diffusi (come il paesaggio), dura nel tempo solo se c’è una capacità gestionale. Ma nei fatti non si sono promosse esperienze significative di gestione sostenibile, i piani sono affidati alle regole e non ai progetti e i bilanci degli enti locali in rosso sono ogni anno tentati di cancellare innanzitutto i costi gestionali di attività poco frequentate, per lo più connesse al patrimonio culturale.
Ormai è chiaro che, nei fatti, la gestione economicamente sostenibile del patrimonio diffuso, fuor dai tecnicismi, si ottiene solo se un gruppo di operatori attivo e duraturo riesce a mantenere nella comunità locale un senso di responsabilità condivisa sui valori riconosciuti. Il postulato, che i beni culturali diffusi non possono che essere salvaguardati dalla società, quella che li utilizza e quella che li utilizzerà, è verificato per certo per il patrimonio immateriale, e si sta affermando anche per il patrimonio materiale, constatato che è sempre stato così. Ma se alla dedizione di alcuni (pochi) operatori non corrisponde più un ruolo riconosciuto e condiviso del patrimonio nel progetto sociale, né locale né nazionale, non c’è strategia di gestione che sia realistica e di successo.
La mancanza di risposte operative e il fallimento delle prove più impegnative fa avanzare, nell’opinione politica qualunquista, una domanda radicale che sta facendo breccia anche tra i tecnici del settore: ma è proprio necessario puntare ad una condivisione profonda, culturalmente partecipata, delle strategie per il patrimonio culturale urbano e diffuso?
Credo che si possa ancora rispondere, nella crisi di questi giorni, che, ancora per qualche tempo (non tanto: mesi, non anni) ci sono ancora le condizioni per dire: sì, ocorrono strategie che comportino una condivisione profonda, culturalmente partecipata. Si risponde così data la certezza del disastro a cui si va incontro nel praticare, oggi, strategie non coinvolgenti la popolazione. Il rischio è che il patrimonio culturale del territorio smetta di essere “paesaggio”, prodotto da un’interazione con chi lo vive, e diventi un relitto archeologico, riducendosi alla testimonianza inerte e frammentaria di un sapere ormai staccato dalla cultura operativa delle nuove generazioni.
Ma il vero rischio è di abituarci ad un masochismo politico e tecnico, perché abbandoniamo lo strumento principale a disposizione, in Italia, per reagire alla crisi identitaria collettiva.
A poco serve una città e un territorio carichi di risorse culturali ma incapaci di trasmettere il loro contenuto, non capiti nelle integrazioni tra passato e futuro che suggeriscono, non più percepiti come paesaggio, in cui siamo ridotti a spettatori e non siamo più attori.
Non possiamo sprecare questa last call della nostra identità, per la quale ancora per qualche anno l’Italia ci offre un habitat culturale per giocare in casa, per tentare sinergie e rapporti “alla pari” tra la dimensione locale, conosciuta o almeno conoscibile, e quella globale, inconoscibile nonostante le seduzioni della rete, ma certamente prepotente e priva di quelle specificità che amiamo.
3. Valorizzare il paesaggio urbano, cioè valorizzare chi lo cura: il “paesaggio attivo”
In questo quadro storico di difficoltà e di resilienze ci sembra che si possa ancora far emergere, particolarmente in Italia, una potenzialità strategica legata al paesaggio, cioè all’interazione culturale tra abitanti e territori. Ci pare che sia stata proprio questa relazione simbiotica in ciascuna città, grande o piccola, ad alimentare un flusso di impegno innovativo diffuso che da secoli genera nuove interpretazioni e nuovi modelli di riferimento della cultura, utili per il benessere sociale, l’economia, e soprattutto l’etica pubblica. Sono quelle fasi di cultura urbana che poi hanno preso un nome noto, nei libri di Storia, a partire dal Buongoverno dei secoli dei Comuni, alle mille versioni di Signoria illuminata del Rinascimento, alla frammentate e complesse pulsioni locali alla base delle epopee di difesa e valorizzazione dei propri territori del Risorgimento e della Resistenza.
Da almeno mille anni in Italia la cultura produce meraviglie perché è frutto di un clima di sapere e di ecosistemi locali generativi di pensiero e di pratiche che sono diffusi in tutto il paese e che hanno costituito, un secolo qui un secolo là, il momento “topico” di centri molto differenti ma tutti potenti per la capacità di irraggiare le loro innovazioni.
L’Italia è stata per mille anni “solo” (!) una rete di città collegate tra loro non da disegni politici o da governi sovrastanti ma da un’unità di linguaggio, quello parlato ma soprattutto quello agito nelle maestrie d’arte e di costruzione, che sono sempre andate al di là delle frontiere e degli egoismi di questo o quel nobile locale. Alla base di queste fruttuose stagioni ci sono state sempre le città, ciascuna capace di impastare e di rendere sinergiche le sue pietre con le sue generazioni, dai signori agli artigiani, dagli studiosi ai mercanti, dagli artisti locali a quelli chiamati da fuori. Insomma le città si sono identificate per secoli in quella variegata antologia di intelligenze, di sensibilità e di creatività che si sono adoperate per mantenere e innovare l’habitat culturale dei loro cittadini: un’armata di talenti che possiamo definire il “paesaggio attivo” di ogni città.
Tra questi, chiamati ad essere gli attori del paesaggio, aiutati da quanto realizzato prima, si sono costituite reti inusitate di ambizioni, competenze, capacità d’investimento duraturo e di continuità del sapere, che convergevano tutte sulla più potente e condivisa strumentazione politica dell’epoca: la produzione culturale che dava lustro al bene comune. In Italia la cultura produceva una fama e una potenza di gran lunga maggiore del denaro o delle armi.
La macchina culturale locale del “paesaggio attivo” è rimasta politicamente produttiva sino a poco tempo fa: nelle prime generazioni della Nazione tutti, dalla Sicilia al Trentino, erano in fibrillazione soprattutto per l’occasione epocale di qualificare la propria città. Basta leggere i discorsi dei Sindaci dell’Italia Unita, o quelli della neonata Repubblica, per trovare ampie pagine dedicate alla cultura locale, all’intenzione di valorizzarne la storia, di implementarne i beni, di far bello e più attraente lo spazio pubblico.
Da qualche decennio è tramontata questa retorica ottimista e di impegno civile assegnato alla cultura e viceversa si è sviluppata una retorica colpevolizzante, che fa apparire insostenibile il peso del patrimonio di beni culturali, con il suo carico di responsabilità sugli eredi, e la convinzione delle nuove generazioni di non essere all’altezza di tanto lascito. E’ un contesto psicosociale che ha obnubilato la consapevolezza fondamentale: che il Patrimonio in Italia non sono tanto i prodotti quanto le produzioni culturali, le capacità secolari degli abitanti delle città di formare l’habitat adatto a generare arte e cultura. E che siamo tuttora in condizione di continuare questa competenza unica al mondo.
Ora, seguendo questa versione dei fatti, potremmo descrivere la situazione attuale del paesaggio italiano come una scena della “Bella addormentata”, dove ci sono tutti gli ingredienti per alzare il sipario e recitare, ma tutto è inanimato, sotto incantamento.
C’è il patrimonio, poco valorizzato ma ancora in discreto stato, ci sono le macchine istituzionali ormai secolari e anchilosate ma comunque insediate, c’è una grande disponibilità di “paesaggio attivo” in termini di risorse umane diffuse, le cui preparazioni e capacità di dedizione sono del tutto trascurate ma presenti. Oggi, nella pandemia che ha sconvolto tutte le organizzazioni istituzionali, non sono solo i sanitari a mostrare una capacità operativa vitale molto al di là della macchina, anzi che salva la macchina con tutte le sue mancanze e inadeguatezze. Sono gli insegnanti delle scuole che improvvisano un e-learning che l’Italia non aveva mai voluto neppure approcciare, sono i musei che mandano in giro per il web immagini e video di sale e tesori tenuti segreti, sono i divulgatori che girano per le città vuote e ce ne fanno vedere i particolari come le nudità di un’amata.
E’ sulle risorse umane del “paesaggio attivo” che si fonda la speranza: si tratta di competenze acquisite per scelta, per una passione che quasi sempre dura tutta la vita, anche se spesso le loro figure professionali sono trasparenti ai più, che non le vedono come non si vedono gli accattoni o chi svolge i servizi più umili ma essenziali. Sono le migliaia di funzionari addetti ai beni culturali periferici, frustrati dai continui cambi di strategia e di dirigenza; sono le decine di migliaia di insegnanti a cui le scuole chiedono un decimo della propria sensibilità e potenza culturale e un’infinita pazienza burocratica; sono le centinaia di migliaia di ragazzi che hanno scelto di studiare architettura, conservazione dei beni culturali e ambientali, letteratura e arte e che le università hanno sfornato negli ultimi 50 anni in un mercato del lavoro senza sbocchi; ma soprattutto sono i milioni di persone impegnate nel volontariato che gestiscono, in modo per lo più autonomo e trascurato dalle istituzioni, i centri studio, i piccoli musei, le fondazioni private e l’infinità di beni minori che pullulano, deo gratias, nel nostro paese.
Ancora oggi il “paesaggio attivo” è un enorme giacimento di materia prima intellettuale in cui sono ben presenti tutti i fondamentali per servire in un progetto strategico sostenibile: è intergenerazionale, composto da persone sensibili e votate alla cultura, a partire da quella locale che spesso hanno studiato e amato, con un rapporto con il denaro del tutto strumentale rispetto al progetto personale, da tempo frustrate dal sottoutilizzo e dalla marginalità sociopolitica del quadrante culturale.
È vero che in ogni città questo insieme di soggetti appare come uno sciame disorganizzato e pieno di nicchie di attività intense ma autistiche, ma i fondamentali ci sono, certo più di quanto ci fossero per gli operai all’inizio della rivoluzione industriale o per gli informatici all’inizio di quella digitale. Semmai occorrono strumenti efficaci per far percepire la rete implicita, le relazioni che già ci sono anche se non vengono sfruttate: parafrasando un saggio barbuto ormai dimenticato, c’è il paesaggio attivo “in sé”, ora occorre lavorare al paesaggio attivo “per sé”.
Paolo Castelnovi
Abbandono: non sprechiamo un’occasione epocale
Contributo su Paesaggi scartati a cura di Fausto Carmelo Nigrelli manifestolibri 2021
L’abbandono: crisi nei processi territoriali
Le spiagge erano punteggiate di barche rovesciate, che d’inverno erano ritinteggiate di bianco o celeste da certi tipi rugosi e taciturni; in montagna tre o quattro domeniche l’anno tutta la valle si dedicava a una corvée di pulizia e ripristino di sentieri e mulattiere, con una giornata di lavoro febbrile ma in un clima di festa e di incontro che non di rado portava figli un paio di stagioni dopo.
Il territorio vuole manutenzione e curarsi della manutenzione è l’essenza primaria del senso di heimat, di appartenenza a un territorio. È uno dei tre pilastri fondanti la cultura materiale dell’evo rurale che l’Europa ha attraversato nell’ultimo millennio, con la sostenibilità implicita nel modello produttivo e con la sobrietà implicita nel modello dei consumi,.
Ora quel sistema, in cui sono cresciute anche le città medioevali e sino al 1800, crolla. È un crollo largamente annunciato nelle sue dinamiche strutturali (economiche, demografiche, organizzative), ma poco esplorato dal punto di vista dei comportamenti culturali e degli esiti territoriali. Coperti da questa ignavia non ci vergogniamo a stupirci dei danni degli abbandoni, dell’insostenibilità, del consumismo, che invece sono esito di una dinamica evidente e sotto gli occhi di tutti da almeno 50 anni.
Per l’abbandono gridiamo ancora allo scandalo alla vista dei villaggi vuoti e in rovina, dei coltivi e dei frutteti incolti, delle linee ferroviarie inerbite, delle fabbriche dismesse. Fingiamo di non esserci accorti che quei luoghi, mancavano da anni di una comunità, di un soggetto sociale vivace che se ne sentisse proprietario culturalmente, che integrasse nel proprio comportamento normale, senza sforzi eroici, il minimo vitale di manutenzione del territorio. E fingiamo di non vedere la parallela vicenda che accade alle periferie, dove non si riesce a consolidare un nucleo abitante che faccia proprio quel lembo di città, lasciato orfano di gente che lo curi e nato già perso al sentire comune, fuori dagli affetti primari. Anch’esso condannato all’abbandono sin dalla posa della prima pietra. Le case in cemento armato dureranno più o meno come i muretti a secco, poi il loro degrado le farà sembrare estranee alla città, e sarà impossibile capire se sia il degrado a chiamare la marginalità degli abitanti o viceversa sia la condizione di dropout a impedire il radicamento e la cura per sé dei luoghi che si abitano. E non rimarrà che azzerare tutto, demolire i muri, disperdere ogni possibile memoria, tornare alla materia prima del suolo per riproporre nuovi spazi a nuovi arrivati, senza mai essere sicuri di riuscire a stabilire il contatto e la temperatura che consente di non fare impazzire quella maionese tra uomini e spazi che fa la città.
Son vicende che sappiamo, o almeno sentiamo, ma fingiamo di non sapere, con la “falsa coscienza” che ancora ci fa scandalizzare a fronte dell’insostenibilità del nostro modello di consumi, quel modello che fingiamo di non vedere trasformato radicalmente nelle ultime due generazioni e accelerato verso un binario morto e mortale. Sapere ma non agire di conseguenza non è un vezzo radical-chic, ma un male oscuro che pervade profondamente la nostra cultura, dalle competenza tecniche prive di indirizzi etici all’emergere di bisogni e di “diritti” non equilibrati da adeguate “prese in carico” responsabili.
Così si sbriciolano apparati disciplinari che credevamo fondamentali, come quelli degli urbanisti, dedicati a una tecnica di governo dei cambiamenti territoriali che, anche se ci fossero ancora sindaci che la vogliono applicare, risulterebbe del tutto inefficace confronto alle attuali dinamiche epocali. Ma non va meglio agli economisti e agli amministratori pubblici, privi di riferimenti a strategie paganti sul breve periodo e inetti a sostenere politiche strutturali e culturali, (forse) paganti sul medio-lungo periodo.
Abbiamo avuto tutti almeno 30 anni per adeguare le nostre tecniche alle nuove dinamiche in corso e abbiamo invece messo a punto sistemi apparentemente più efficaci per governare le vecchie situazioni. I piani regolatori operativi e i premi di cubatura in urbanistica ormai valgono come riempire di coccodrilli i fossati di cinta quando i cannoni sbriciolano ogni muro.
Forse il problema sembra affrontabile perché pare ancora episodico. Come tutte le patologie endogene l’abbandono ha cominciato con l’erodere le parti più deboli: dalle fabbriche della prima industria a quelle fasulle dei finanziamenti europei, dagli insediamenti d’emergenza (dove emergenti sono le masse crescenti di chi chiede città senza saperla usare) ai versanti terrazzati. Ogni sindaco pensa di essere incappato in una vicenda particolare, e si batte per trovare la soluzione speciale per il proprio caso: fioccano i quartieri demoliti, i soldi spillati a una fondazione bancaria per allestire musei autoriferiti, centri multi funzionali deserti, contenimenti di frane lungo strade che portano a rovine abbandonate da tutto salvo che dagli scaricatori di rifiuti, per non parlare dell’accanimento terapeutico per le fabbriche decotte, in nome dei posti di lavoro (in decottura anch’essi).
Ma se alziamo lo sguardo all’area vasta, e guardiamo le medie valli di montagna, i litorali lontano dai centri maggiori, le distese di zone industriali mai decollate, diventa chiaro che non si possono pensare centinaia di soluzioni speciali, ciascuna con il suo investimento a perdere, il suo quartiere di sfollati, il suo museo sempre chiuso, la sua insostenibilità gestionale.
È innegabile che fuori dalle città l’abbandono è un processo epocale di dimensioni addirittura continentali. In Italia non ha più senso fare riferimento al valore di scambio per l’immobiliare rurale, con gli alloggi in vendita a mille euro, con l’incubo dell’IMU delle case dei padri contadini a turbare i, magri bilanci dei figli cittadini. D’altra parte non possiamo che constatare la fine del valore d’uso dei luoghi abbandonati, l’estinzione della domanda, di chi è interessato ad avere a disposizione quello strumento per abitare e produrre ancora in quel modo millenario.
Finora ogni progetto aveva cercato di rattoppare la macchina riproduttiva delle condizioni tradizionali; ora dobbiamo attestare che l’abbandono territoriale segna la fine di una proprietà culturale dei luoghi, quella che derivava da quel modo di abitare fatto di lavoro manuale sistematico, di continua manutenzione, di ritmi stagionali, di estrema sobrietà nei consumi e nei rapporti sociali.
È ormai chiaro che non c’è più alcuna possibilità di restaurare la continuità del mondo rurale dell’ultimo millennio. È chiaro che il futuro dei territori come i nostri sarà organizzato e gerarchizzato secondo valori e comportamenti diversi da quelli a cui siamo abituati. E viene in mente la lucida etica del progetto che Gambino avanzava già oltre 20 anni fa: «conservare è innovare».
I nuovi montanari
Come la nave abbandonata anche dal suo capitano diventa relitto a disposizione di chiunque se ne impossessi, così un luogo abbandonato anche dall’ultimo coltivatore è di chi lo riabita.
Se guardiamo cosa è successo lungo le coste, con l’avvento del turismo del sole che ha sradicato i modi e i luoghi dell’abitare rivierasco, capiamo l’incommensurabilità dei due modelli, con quello attuale vincente che ha ridotto a comparse da riserva indiana pescatori e barcaioli, che erano i protagonisti del modello consolidato per secoli e prevalente fino a 50 anni fa. E pensando a quella dinamica e allo sfascio ecosistemico, paesaggistico, morale che ne è derivato, ci pare che si sia sprecata un’occasione irripetibile, quella di valorizzare un unicum planetario, come sarebbero le nostre coste senza l’osceno realizzato nelle ultime due o tre generazioni.
Ora tocca alla montagna, non importa se appenninica o alpina, tocca a migliaia di insediamenti sopra i 600 metri, fuori dal centinaio di mete turistiche e dagli itinerari delle grandi strade di passo. Ora quella montagna è spopolata. Pochi e spesso temporanei gli attuali abitanti, figli e nipoti dell’ultima generazione di indigeni indipendenti, per lo più incapaci a mantenere tra loro un minimo di comunità locale reale e non solo di rappresentanza. Accanto a questi sono crescenti i forestieri che per scelta (per lo più gli europei) o per necessità (per lo più gli altri) non stanno in città.
A prima vista si potrebbero chiamare mountain users, diversi dai montanari quanto i city users son diversi dagli abitanti di città. Infatti c’è qualche radicale differenza di comportamento e di cultura dei luoghi: i nuovi arrivi sono quasi sempre di gente che è vissuta in ambiente urbano, che ha assaporato lo status del cittadino, di chi ha facile accesso ai servizi, è immerso in un, mare di opportunità, conosce superficialmente molti luoghi e molte persone, comunica prima di pensare, ha un rapporto raro e sporadico con la natura.
Eppure, se trascuriamo chi lo fa per necessità, quei cittadini hanno scelto l’habitat montano proprio perché sanno dare prestazioni inverse a quelle di città: l’accesso ai servizi è faticoso, il ventaglio delle possibili attività è molto modesto, sia per il lavoro che per il tempo libero (per lo più ricalcano le attività svolte secolarmente, ora con meno fatica), le frequentazioni di persone sono limitate (ancora più di quelle delle passate generazioni, quando i villaggi erano ben popolati), le comunicazioni sono ridotte e saltuarie (anche i cellulari spesso non hanno campo), e d’altra parte il rapporto con la natura è sistematico e continuo, ineludibile (anche data la generale modestia degli spazi al chiuso).
Insomma, coloro che, per nostalgia o senso di impresa, vanno oggi a vivere in montagna, fanno consapevolmente la scelta di un modello di vita culturalmente alternativo a quello urbano a cui sono abituati, forse proprio perché delusi da qualche competenza disciplinare che doveva consentire di progettare il futuro e invece.... Sono scelte che si traducono in comportamenti nuovi, difficili da distinguere tra quelli indotti da mode passeggere e quelli che si stanno radicando in una nuova struttura socioculturale.
In generale si riscontrano alcuni aspetti costanti: se da una parte si cerca di mantenere un kit minimo di urbanità a cui si è abituati, d’altra parte si esige che rimangano intatte quelle diversità alternative per cui si è deciso di salire ad abitare in quota con un senso di liberazione, dopo generazioni che invece scendevano a valle col magone nel cure. Il nuovo montanaro apprezza la natura e il paesaggio in modo “colto”, molto più esplicitamente e con attenzione dell’abitante storico; ha un modello di vita sobrio, spesso per scelta o per rendere più sostenibile la sua scelta di vita; ha un modello di lavoro o almeno di tempo libero con consistenti quote di attività fisiche all’aria aperta.
Fin qui si tratta di un identikit facilmente constatabile, che tiene insieme quasi tutto l’eterogeneo accrocchio dei nuovi montanari., ma si verifica anche una situazione disgregante: chi sceglie la montagna per difendersi dalla società dei social e della comunicazione ossessiva e obbligatoria ha certamente un progetto di vita, ma spesso stretto in una chiusura autistica che porta alle scelte solitarie, all’individualismo sociale. Insomma la montagna desiderata è pensata nell’immaginario dei nuovi abitanti più come un eremo che come un cenobio.
Con questo atteggiamento è forse la dimensione del villaggio quella che più si è persa con la fine delle comunità storiche. Era una comunità modesta, di poche decine o centinaia di persone, che è sempre stata stretta ai più giovani, ma che ha reso potente il progetto implicito dell’insediamento rurale, perché capace di lavori titanici come i terrazzamenti, le canalizzazioni, gli spietramenti e i disboscamenti per aver pascoli, sfalci e seminativi. Era quella comunità di fatica e regole di sopravvivenza che ancora durava nel coutumier tradizionale (il prontuario dei comportamenti consolidati che sostituiva la legge ufficiale, di città) e che dava alla riunione dei capofamiglia un ruolo strategico per le imprese comuni di fronte alle avversità collettive.
Oggi chi abita la montagna sembra preferire “la vita solitaria”, o più probabilmente soddisfa le proprie esigenze di relazioni sociali partecipando a reti aterritoriali, tra persone anche molto distanti, attraverso i social o incontrate direttamente in modo saltuario e individuale, non condiviso con i vicini. È chiaro che, con questo nuovo approccio, l’insediamento montano in cui si abita viene vissuto più come un condominio piuttosto che un villaggio: genera problemi di gestione dell’esistente piuttosto che spingere a progettare imprese collettive per garantire un futuro migliore a quel luogo e alle stirpi che lo abiteranno.
Sono gli effetti che riscontriamo un paio di lustri dopo interventi, pur sempre preziosi, di riabilitazione di interi nuclei in abbandono, o di programmi di reintroduzione di pratiche rurali che si erano andate perdendo, o di organizzazione ad albergo diffuso di abitati sparsi in vallate tagliate fuori dal turismo invernale. Si tratta quasi sempre di progetti sostenuti da una forte capacità di mobilitazione e senso imprenditoriale di un soggetto promotore e da un sostanzioso contributo pubblico, che talvolta superano mille difficoltà nella fase di creazione dell’infrastruttura o della sede fisica della nuova attrezzatura e che poi vanno perdendo energia e sostenibilità quando si passa alla fase gestionale e alla imprenditorialità distribuita tra i fruitori dell’intervento: i nuovi abitanti sinora non ne sanno fare tesoro ed è in agguato il rischio di un secondo abbandono in meno di un secolo.
Una rivoluzione per i progetti territoriali
Emerge da questo racconto un aspetto sinora trascurato, ma fondamentale per chi studia strategie di valorizzazione territoriale. Si può sintetizzare brutalmente così: l’insediamento montano può disporre in prospettiva di nuove risorse umane che lo abitano riconoscendone i valori primari, ma che dispongono di una strumentazione progettuale e organizzativa probabilmente inadeguata ad affrontare i problemi di un territorio così impegnativo, mancando spesso la capacità di intervento collettivo e di lungo periodo.
Ora, se questi sono i caratteri della tipologia socioculturale e psicologica dei nuovi abitanti, con questi dobbiamo affrontare il problema: nel breve periodo non possiamo contare su cambiamenti diffusi e strutturali di un trend generazionale che si sta appena consolidando e che non ha alternative se non peggiori: l’abbandono totale o la devastazione consumistica.
Dunque ogni programma che si prefigga una valorizzazione sostenibile dell’insediamento montano non può prescindere dalle caratteristiche di questa nuova tipologia di abitanti, pena la perdita dell’investimento, delle energie di tutti i soggetti, dell’impegno dei migliori progettisti e dei denari pubblici. In una situazione come questa, quali sono le strategie da mettere a punto?
Si deve ovviamente scartare la forzatura a comportarsi “come” in un villaggio tradizionale, che, come abbiamo visto, era organico a un sistema di vita e di scelte chiuso localmente, ma spinto ad azioni collettive e di lungo periodo, mentre qui abbiamo a che fare con soggetti aperti al mondo, ma che tendono a non aderire convintamente ad azioni locali organizzate.
D’altra parte si sta dimostrando necessaria, ma non sufficiente la strategia della diffusione degli standard di servizio urbani, centrale nel Programma Aree Interne. Infatti gli interventi previsti nel Programma Aree interne soddisfano (forse) la richiesta di accessibilità a dotazioni minime di servizi, ma (probabilmente) poco riescono ad incidere sulla particolarità specifica del vivere in montagna.
La vita di montagna è desiderata dai nuovi abitanti, ma questi in molti casi non riescono a sostenerla nel tempo, non tanto per la mancanza di servizi per loro, ma per la mancanza di progettualità e di competenza riguardo i lavori che loro possono svolgere, riguardo le produzioni o i servizi che loro possono fornire ai cittadini di pianura.
Infatti i nuovi montanari tendono a trascurare una risorsa implicita nella loro stessa storia biografica: la loro conoscenza del sistema città, dei gusti e dei modi dei cittadini. È d’altra parte evidente che una prospettiva decente di vita nei contesti montani si può raggiungere solo con una nuova relazione con la pianura, che è il naturale complemento necessario per ogni integrazione economicamente sostenibile.
Dunque, se non si vuole che la montagna diventi, come il litorale, un archetipo dei luoghi di abitazione di cittadini non attivi (perché ricchi, o in vacanza, o pensionati), occorre facilitare iniziative produttive di nuova generazione per i nuovi abitanti, promuovendo quelle che valorizzano in modo sostenibile le risorse proprie della montagna, mettendole a disposizione dei cittadini di pianura, ma curando che ciò possa realizzarsi anche da parte del singolo operatore, non necessariamente integrato in una comunità di intenti con gli altri abitanti.
È una prospettiva di notevole difficoltà, che chiede di superare la fiducia nelle opere di interesse generale, sinora considerate infrastrutture di base generatrici automatiche di progettualità e sviluppo diffuso.
Quindi non fidiamoci più “soltanto” di recuperare interi nuclei abbandonati, o di completare sistemi di strade forestali che danno accesso a ogni pascolo, o di costruire servizi scolastici o per il tempo libero teoricamente utili per abitati dispersi: quasi tutte quelle esperienze, preziose nella loro ideazione, gloriose al momento della realizzazione, dimostrano dopo qualche anno la loro bassissima efficacia nell’innesco di processi autogeneratori di sviluppo e di radicamento di nuove forze insediative.
Ma è anche difficile promuovere con successo lo sviluppo di attività imprenditoriali di singoli operatori con strumenti top-down, come siamo abituati a fare con i programmi mirati: come si è detto prima abbiamo a che fare con una tipologia di soggetti nuova, carica di attese, eticamente motivata, ma quasi sempre poco strumentata e per certi versi ingenua, che in ogni caso difficilmente si adegua a percorsi standard già tracciati.
L’unica strategia potenzialmente applicabile a questo tipo di “nuovi coloni” è quella che si cerca di attivare per le start-up di processi innovativi: assicurare una promozione iniziale a fronte di una bozza di progetto del proponente e del suo impegno duraturo, ma soprattutto garantire un accompagnamento sistematico, competente e operativo, sul campo (è il caso di dirlo), per alcuni anni.
Occorre guardare, come esempi e buone pratiche, alle nu- merose esperienze di governance dei processi territoriali che han- no da tempo sperimentato paesi che hanno il problema delle vere periferie, come la Francia o la Gran Bretagna. Di fatto le regole di pianificazione sono state sostituite da agevolazioni e facilitazioni, sgravi fiscali e aiuti riferiti per lo più alle imprese e (in misura molto inferiore) alle infrastrutture e al patrimonio immobiliare. E per le imprese, ritenute interessanti sulla base di progetti credibili e monitorati nei loro sviluppi e nelle difficoltà che si incontrano, si agevola non solo l’avviamento, ma anche la manutenzione e tutti gli aspetti di formazione delle competenze e di ammortamento de- gli investimenti progressivi.
Secondo noi il criterio di fondo, per selezionare i progetti da agevolare, è il contributo al bene comune. È un criterio che troppo spesso associamo a strategie collettive, ma che si deve poter applicare in ogni caso, singolo o collettivo, di azioni PER la collettività.
È fondamentale selezionare progetti positivi rispetto alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale, disponibilità a raccontare ad altri la propria esperienza, interesse a rendere circolare l’economia, ma anche la disponibilità a partecipare a una nuova cultura operativa e imprenditoriale che coniughi valorizzazione della natura, superamento della divisione tra lavoro e tempo libero, ricerca del piacere non consumistico. Sono requisiti di progettualità che non si possono chiedere a chi ha patito freddo e fame da generazioni abitando in modo tradizionale la montagna, e che invece più facilmente animano chi viene, deluso dalla città, a far sinergia con i valori impliciti e duraturi della montagna, che resistono oltre l’abbandono. Infatti bisogna tener conto che le idee, il know-how, l’educazione ai rapporti con la città comunque rimangono a disposizione dei nuovi abitanti, come una cassetta degli attrezzi fondamentale.
Per aiutare chi cerca di progettare il proprio futuro a partire dalla scelta radicale del nuovo modo di abitare, occorre una strategia pubblica che lavori sul piano della cultura più che delle opere, che assuma il paradigma urbano non tanto a partire dai servizi alla persona quanto dai servizi per la imprenditorialità. Sono strategie che costano molto in termini di “tempo politico” (presenza sul territorio di agenzie competenti, alleanza con i sindaci dei piccoli comuni, comunicazione delle iniziative etc.) e risorse umane di qualità (soprattutto per l’accompagnamento e la cura delle specificità di ogni progetto), ma probabilmente costano molto meno di ogni strategia di lavori pubblici che sinora ha catturato la gran parte delle risorse per la montagna.
Quando ogni valle avesse due o tre esempi di nuovi abitanti, che riescono a radicare le proprie attività innovative, è quasi certa l’attivazione dei neuroni-specchio sociali che moltiplicano le buone pratiche in infinite varianti locali e rigenerano il territorio con una diffusione risolutiva.
Sarà allora il caso di una lezione di sviluppo dalla periferia al centro, per cui un territorio, proprio per le sue stesse caratteristiche viene scelto per essere abitato con comportamenti etici e sobri e induce trasformazioni sostenibili e adeguate ai tempi: un modello di scelte per le nuove generazioni, un modo sano di abitare il futuro. E scopriremo che necessariamente deve muovere dall’abbandono del modello precedente.
Paolo Castelnovi