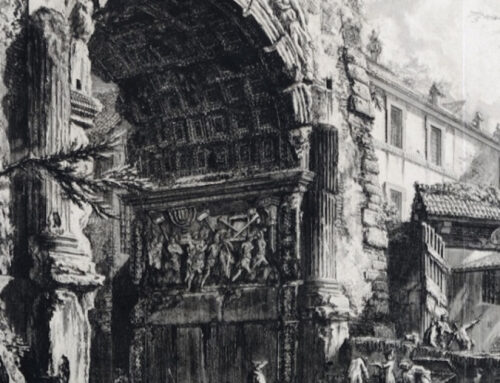Il piano paesaggistico piemontese è il tentativo più maturo di mettere a punto un paradigma operativo per valorizzare il paesaggio, utilizzando al meglio i piani urbanistici.
Ma il tentativo mostra i limiti profondi della macchina regolativa di governo del territorio, pur prodotta dalla migliore legislazione urbanistica regionale, e del paesaggio, pur con le migliori intenzioni del Codice.
La storia delle scelte di metodo del Piano piemontese evidenzia, oltre ai limiti, una prospettiva interessante, che è rimasta sottotraccia, ma che potrebbe motivare nuovi accordi per il paesaggio.
1. Il paesaggio nel piano contribuisce alla perdita di grip delle regole universali
Per raccontare l’impostazione sperimentale del Piano paesaggistico piemontese partiamo da lontano, perché il PPR cerca di affrontare alcuni temi irrisolti negli ultimi 70 anni nella storia italiana di gestione del territorio.
Per una legge ciclica che solo sospettiamo, vista la sua ricorrenza, molti meccanismi di funzionamento della società perdono efficacia e credibilità, proprio mentre il loro assetto istituzionale sembra consolidarsi e diventare pratica ordinaria. Ora è il turno delle riforme di una cinquantina d’anni (10 più 10 meno): la scuola, la sanità, il decentramento regionale sono in crisi strutturale. Anche la cultura delle regole urbanistiche, coeva a quelle riforme nelle sue leggi fondamentali, ormai sistematicamente applicata, sta volgendo al tramonto.
È un processo di sclerosi che si è svolto sottotraccia da oltre vent’anni, che dobbiamo rileggere per capire le ragioni dell’attuale situazione di stallo, quando da una parte non ci si può più affidare alla norma urbanistica per qualificare lo spazio pubblico ma dall’altra non si hanno altri strumenti efficaci per convogliare le singole energie progettuali al bene comune della città e del territorio.
La sconsiderata separazione tra urbanistica e progettazione, consumatasi fin dentro il corso di studi, ha favorito la formazione di una doppia professionalità: quella dell’applicazione sistematica delle regole per attuare i piani e quella del loro aggiramento per dare spazio al progetto. Come per giocare a guardie e ladri, per ciascuno dei due ruoli sono maturate etiche, ossessioni e furbizie mirate contro l’altro ma compartecipanti in una sorta di sacra rappresentazione, un rito al quale ormai ci stiamo abituando: l’urbanista predica una normalità neutra, ordinata, ottocentesca; il progettista invoca il segno, l’emergenza, la sregola come espediente della contemporaneità per farsi notare.
In questa dialettica esasperata, legittimata dal contrasto “alto” tra il progetto e la regola, ha trovato spazio la peggiore sciatteria e il disprezzo di quel bene comune che l’urbanistica in teoria cerca di garantire: la qualità funzionale e identitaria della città in costruzione. Si verifica, caso per caso, l’incapacità della norma a indirizzare alla qualità il disegno urbano quando si costruisce e a limitarne il degrado quando lo si gestisce.
D’altra parte si deve tener conto che la legge obbliga tutti i comuni ad approvare il piano regolatore, in cui si applicano norme standardizzate e parametriche a situazioni molto diversificate e caratterizzate. Ciò dipende dalla “necessità” di univocità della norma: un mito tecnico e addirittura morale del nostro tempo, mentre semmai sarebbe più corretto per il bene comune richiedere un medesimo livello di qualità delle prestazioni di interesse generale, ottenendolo “naturalmente” con modalità diversificate in base alle diverse situazioni.
L’incapacità dell’urbanistica a tener conto delle specificità di ogni luogo è stata tamponata con quella sorta di deroga che si è inventata per le zone A (dopo lunghe battaglie culturali e politiche), salvando i centri storici da scempi perpetrati in nome proprio delle regole uniformi di costruzione della città. Ma non è accaduto lo stesso nei confronti della città che si espande verso la campagna.
D’altra parte, negli ultimi 30 anni alcune qualità del territorio aperto sono state difese dalla cultura ambientalista, che ha portato al rispetto di valori sino ad allora sconosciuti (nel dopoguerra il PRG cingeva le città di “zone bianche”, hic sunt leones, le terre non urbane, considerate unicamente in quanto riserve a disposizione dei futuri piani di fabbricazione). La cultura ambientalista ci ha fatto forti di norme di rispetto e attenzione, importanti ma del tutto a-progettuali, e a-locali. Lo strumento più utilizzato per gestire la relazione ambientale dei nuovi interventi, la “valutazione d’impatto”, teoricamente esamina gli effetti positivi e negativi delle trasformazioni, ma di fatto considera (per lo più in modo inutile ed edulcorato) solo gli effetti negativi dei progetti e dei piani. Ogni intervento viene misurato con indici standardizzati di incidenza sull’ambiente ed è considerato necessariamente dannoso. Nella procedura di valutazione il soggetto pubblico assume le vesti di badante di un malato cronico senza speranza, il territorio, per il quale si cercano di attenuare le peggiori conseguenze, cercando di limitare l’incidenza delle azioni proposte, a prescindere.
Ma da una ventina d’anni, quando l’urbanistica è un fortino assediato che resiste invocando la qualità etica delle norme uguali per tutti, si fa avanti una cultura del paesaggio che sdogana la soggettività, esalta la qualità percepita e le specificità locali, introduce tra i compiti della mano pubblica anche la promozione e la valorizzazione e non solo la conservazione. In pratica si propone di applicare all’intero territorio le attenzioni rivolte ai centri storici.
È un colpo fatale al mito dello standard che in nome dell’equità normativa azzera le differenze. Si deve rivedere il modo di applicare le attenzioni di interesse generale e si richiede una nuova “tecnica” per valorizzare il territorio conservandone l’identità e le caratteristiche locali.
Ecco: il piano paesaggistico piemontese, oltre dieci anni fa, muove da un contesto culturale, tecnico e politico di questo genere, che attende non solo uno strumento innovativo, ma un paradigma logico e un riferimento metodologico che argini le aporie dell’urbanistica e in generale della gestione del territorio.
Si pone però un caso di doppio vincolo quasi irresolubile: il paesaggio e la progettualità di interesse comune impongono attenzione alle caratteristiche particolari dei singoli luoghi, mentre il piano regionale agisce a una scala che non può tener conto della situazione specifica.
2. La risposta all’ubris normativa del Codice: regole per ambiti, regole per beni
Il Codice dei beni culturali, nel 2004, affronta il paesaggio muovendo da una evoluzione discontinua del concetto e delle sue definizioni operative. Da una parte è occorso metabolizzare la definizione storica, che considera alcuni pochi selezionati paesaggi come beni irripetibili e cerca di conservare qualità “viventi” applicando ingenuamente le provvisioni degli altri beni culturali, immobili. D’altra parte si è dovuto far fronte all’irruzione degli aspetti ambientali portati dalla legge Galasso, che sottopone ad attenzione oltre un terzo del territorio e poi alla Convenzione europea, che considera paesaggio ogni “singola parte” del territorio.
Va anche considerata la polemica specifica in cui si muove il Ministero dei Beni culturali, nei primi anni 2000, sottoposto a un’intensa critica per la soggettività nei controlli autorizzativi, e per la mancanza di criteri espliciti di riferimento e di argomentazione nelle valutazioni. La procedura incontrollabile dei controllori diventa insostenibile a fronte dell’aumentare vertiginoso ed eterogeneo dei casi da autorizzare.
Insomma una formalizzazione dei termini della procedura autorizzativa era politicamente richiesta.
Con il Codice si raccoglie la sfida e ci si sforza di coniugare l’attenzione ad hoc, allo specifico dei luoghi e dei beni, con una strumentazione regolativa normalizzante, per categorie, che è propria dei piani urbanistici.
È come raccogliere violette coi guantoni da boxe: la legge illuminista, uguale per tutti, non è compatibile con la considerazione olistica e progettuale che viene richiesta per valutare le mille situazioni in cui versa ciascun bene. Imporre attenzioni uniformi a tutto ciò che sta entro 150 metri dalle rive di un fiume appare immediatamente come una scelta rozza e da perfezionare, a cui non si può sempre sfuggire con la mannaia della negazione assoluta di ogni intervento.
Ma comunque nel Codice si sceglie di normare tutto, declinando con differenti ordini di prescrizioni le attenzioni ad oggetti di diversa complessità e dimensione e scaricandone l’onere tecnico sui piani regionali.
Ad essi si richiede di individuare gli ambiti di paesaggio come dimensione adatta per distinguere le diverse caratteristiche del territorio, e si ordina di predisporre specifiche normative d’uso a quella scala: un’invenzione senza precedenti, sia perché l’uso non è mai stato oggetto specifico di norma, sia perché la dimensione territoriale degli ambiti sfugge a norme efficaci sul piano del vincolo giuridico.
D’altra parte si utilizza l’occasione dei Piani regionali per ottenere anche una schedatura per ciascuno dei beni vincolati che possa contenere “prescrizioni intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi”, e lo stesso si richiede per le aree di interesse paesaggistico della legge Galasso, anche se si sa che esse coprono oltre il 40% del territorio e non possono essere normate specificamente, a meno di non essere i funzionari della Mappa dell’Impero in scala 1:1, di borgesiana memoria.
Nella redazione del Piano paesaggistico piemontese, nel 2007, ci si è trovati a sperimentare la (allora) nuova procedura individuata dal Codice, provando a districarsi nella congerie di versanti normativi richiesti.
Alla fine si fanno convivere diversi strumenti regolativi:
– una specifica molto precisa per ogni bene paesaggistico vincolato, la cosiddetta “vestizione dei vincoli”, che risponde al requisito di esplicitare i criteri di attenzione da seguire in ogni intervento su quei luoghi specifici, al costo di uno sforzo descrittivo ponderosissimo ma purtroppo necessariamente statico (e quindi inadeguato man mano che il tempo passa);
– una generica indicazione degli aspetti di insieme di cui tener conto negli ambiti di paesaggio (grandi mediamente 18/20 comuni) e nelle “unità di paesaggio” che li compongono, di dimensioni molto minori, che individuano contesti sottoposti a omogenei processi trasformativi, con indirizzi di attenzione e il rinvio di verifica dell’efficacia normativa ai piani d’area vasta o locali;
– una normativa per “componenti” (della struttura regionale del paesaggio), categoria del Piano piemontese che comprende anche i beni paesistico ambientali del Codice derivanti dalla Legge Galasso: fasce territoriali da precisare nei loro confini e regole di attenzione da declinare in modo prescrittivo nei piani locali, per ciascun tipo di bene.
È un quadro normativo complesso, che fa fronte all’insieme delle indicazioni del Codice, ma che di fatto dribbla il doppio vincolo omogeneità generale/specificità locale, rimandando alle Province e ai Comuni l’onere della declinazione locale delle regole per gli ambiti e della precisazione delle parti del territorio a cui applicarle per le componenti.
3. L’interpretazione e il riconoscimento delle relazioni identitarie e delle strategie locali
Per aiutare gli enti locali a superare le difficoltà e i limiti del versante normativo imposto dal Codice, nel Piano piemontese si affronta il tema del paesaggio con un’impostazione multitasking. Roberto Gambino, coordinatore scientifico del Piano, propone una tripartizione paradigmatica, dopo averla sperimentata in altri piani d’area vasta. In tale impostazione la funzione regolativa non è il vertice a cui tutto il Piano è inteso, ma è accompagnata, pari grado, dalla funzione strategica e da quella conoscitiva.
Il ruolo della funzione strategica assegna al piano regionale il compito che sta alla base dei piani europei, spesso avarissimi di regole e invece centrati sul coordinamento e la promozione di programmi strategici di azione locale e di buone pratiche. È un’apertura alla programmazione e all’intesa politica tra i vari settori, che negli anni potrebbe dare splendidi frutti, anche se per ora ciascun ufficio regionale continua a programmare per proprio conto.
Ma il compito innovativo è assegnato alla funzione conoscitiva: dal ruolo ancillare e di servizio previo, a cui è condannata nel resto dell’urbanistica e della pianificazione, ad un ruolo di proposta interpretativa, che tenta di dare strumenti sistematici e in progress a comuni e province, per superare i problemi della specificità locale, imprendibile a scala regionale, e della rigidità delle regole generali, spesso inutili o dannose a scala locale.
La proposta del piano è di collaborazione interistituzionale. Con un’azione culturale, di riconoscimento del proprio patrimonio secondo il modello interpretativo proposto dal piano regionale, comuni e province dovrebbero poter articolare, in modo condiviso e credibile politicamente, le regole che nel piano definiscono in modo generale e schematico le modalità di salvaguardia e di valorizzazione del paesaggio.
A comuni e province è proposto, nell’ambito del previsto adeguamento dei propri strumenti di governo del territorio, di completare l’indagine e l’interpretazione dei valori presenti secondo il nuovo modello predisposto per il piano regionale, che tenta di facilitare la progettualità ad hoc, ove rispettosa del paesaggio locale e delle relazioni sistemiche d’area vasta, per la prima volta definite e in parte individuate.
Il quadro di indagine proposto è indirizzato a declinare i valori del territorio in modo da farli riconoscere alle diverse scale e a facilitare l’attuazione locale del piano attraverso regole e strategie ad hoc, in particolare evidenziando filoni interpretativi inediti ma fondamentali per il paesaggio:
il ruolo delle relazioni locali,
per cui al centro dell’attenzione si pongono le relazioni (di omogeneità o di complementarità) tra diversi elementi presenti, stimolando a riconoscere il valore di ogni emergenza (un castello, una cascata, un grattacielo,) o di ogni tessuto (un versante a vigneto, una stazione di villeggiatura, un sistema di nuclei storici di crinale,) non in sé ma come prodotto di un effetto di posizione, di situazione ambientale, di processo storico o di assetto costruito che portano a valorizzare non solo l’oggetto in questione ma soprattutto le relazioni con il contesto locale o temporale. Gli elenchi di edifici e luoghi tradizionalmente utilizzati per delineare le caratterizzazioni d’ambito vengono sostituiti da indicazioni di sistema (naturale e/o storico) che rendono comprensibili più facilmente le regole relazionali da seguire;
il ruolo delle reti sovralocali,
per cui si tracciano le connessioni fondamentali delle reti ambientali, storiche e funzionali che, a livello sovralocale, disegnano i grandi tratti distintivi del paesaggio regionale (i corridoi ecologici, le infrastrutture storiche, le grandi relazioni visive, ..), e si richiede che la valorizzazione di tali nessi, rilevanti ad una scala così grande che spesso non sono percepiti a livello locale, venga invece assunta alla base delle scelte localizzative delle trasformazioni territoriali locali;
l’interpretazione strutturale e l’articolazione in componenti,
per cui si abbozza uno schema di relazioni fondamentali del paesaggio regionale (la struttura) per rendere possibile la distinzione degli aspetti specifici per cui una sua parte (una componente) va tutelata e valorizzata. Un fiume non interessa tanto come corpo idrico ma per il segno curvilineo che lo rende riconoscibile, per la continuità della fascia vegetale attorno, per il ruolo di corridoio ecologico che svolge. Perciò interessa molto non rettificarlo, non pelarne le rive, non interromperlo tombandolo o ponendo uno sbarramento insormontabile. Capendo il ruolo strutturale delle componenti, caso per caso, si distinguono e si rendono comprensibili le attenzioni da porre, e, senza eccedere in generici divieti, si consente di definire le più opportune condizioni di compensazione e di attenuazione dei casi di impatto;
il ruolo delle dinamiche trasformative,
per cui si articola il territorio riconoscendone lo stato dei processi trasformativi in corso, spesso del tutto indipendente dai valori relazionali e strutturali evidenziati con il resto dell’indagine. Così si fa entrare nella gestione del paesaggio la dimensione temporale, riconoscendo l’esistenza di processi di produzione continua di paesaggi, condivisi dalle popolazioni anche se ben poco identitari, ben diversi da quelli cristallizzati nel piano. Quindi si identificano i luoghi come unità base del paesaggio, da queli in cui i processi trasformativi sono accelerati e stanno producendo assetti completamente nuovi, periferie in cui il cambiamento continuo delle forme è una parte importante della percezione del paesaggio, a tutti i gradi intermedi sino a quelli stabili, dove anche il più piccolo cambiamento è percepito come alterazione grave. Capendo le dinamiche in corso è possibile individuare gli interventi necessari a stabilizzare i processi, a ridurre il “rumore” generato dal cambiamento continuo, e quindi a riportare l’attenzione e il senso identitario sugli aspetti strutturali del territorio.
In questi termini l’ipotesi operativa che sta alla base del PPR è che il quadro conoscitivo e il suo metodo, adottato come motore di indagine e di interpretazione locale possa diventare il viatico per declinare le regole generali sul territorio. La macchina regionale dovrebbe favorire gli sforzi di ogni ente locale per riconoscere le qualità del proprio territorio, secondo le impostazioni strutturali e relazionali del PPR. Su quella base dovrebbero essere provate buone pratiche e facilitate procedure per disegnare i nuovi PRG, come già la Regione aveva tentato con gli Indirizzi di qualità paesaggistica degli insediamenti, rimasti un esercizio accademico anche perché non muniti di connessioni operative con le procedure ordinarie di pianificazione.
Ma il processo deve diffondersi, non può restare un compito d’ufficio, un dovere burocratico cui ottemperare per poter variare il solito vecchio PRG. Occorre chiamare a dare una mano quelli, e sono tanti, che comunque al paesaggio, alle relazioni storiche e ambientali, alle caratteristiche locali stanno dedicando le loro imprese, il loro tempo libero, la loro azione politica. Con loro il riconoscimento diventa non un lavoro scolastico e tecnico, ma un processo operoso, carico di progetti, favorendo anche i singoli che usano bene il proprio territorio. Insomma, per il riconoscimento operoso delle relazioni paesistiche caratterizzanti occorre mettere a frutto il paesaggio attivo, come ho provato a delineare nell’articolo pubblicato sullo scorso numero di questa rivista.