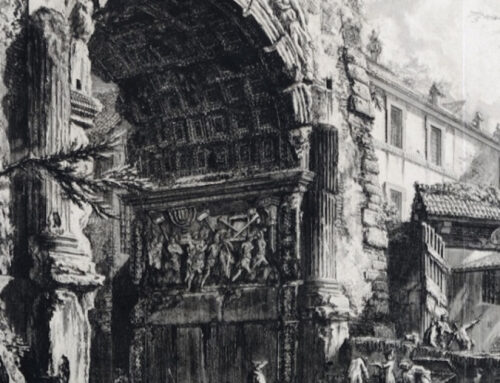La crisi del mondo rurale, della sia sostenibilità e della sua sobrietà porta a nuovi abitanti delle zone meno accessibili e alla prospettiva di un nuovo modo di abitare, una stretta via inesplorata tra il rischio di isolamento e quello di definitiva insostenibilità
Le spiagge erano punteggiate di barche rovesciate, che d’inverno erano ritinteggiate di bianco o celeste da certi tipi rugosi e taciturni; in montagna tre o quattro domeniche l’anno tutta la valle si dedicava a una corvée di pulizia e ripristino di sentieri e mulattiere, con una giornata di lavoro febbrile ma in un clima di festa e di incontro che non di rado portava figli un paio di stagioni dopo.
Il territorio vuole manutenzione e curarsi della manutenzione è l’essenza primaria del senso di heimat, di appartenenza a un territorio. È uno dei tre pilastri fondanti la cultura materiale dell’evo rurale che l’Europa ha attraversato nell’ultimo millennio, con la sostenibilità implicita nel modello produttivo e con la sobrietà implicita nel modello dei consumi,.
Ora quel sistema, in cui sono cresciute anche le città medioevali e sino al 1800, crolla. È un crollo largamente annunciato nelle sue dinamiche strutturali (economiche, demografiche, organizzative), ma poco esplorato dal punto di vista dei comportamenti culturali e degli esiti territoriali. Coperti da questa ignavia non ci vergogniamo a stupirci dei danni degli abbandoni, dell’insostenibilità, del consumismo, che invece sono esito di una dinamica evidente e sotto gli occhi di tutti da almeno 50 anni.
Per l’abbandono gridiamo ancora allo scandalo alla vista dei villaggi vuoti e in rovina, dei coltivi e dei frutteti incolti, delle linee ferroviarie inerbite, delle fabbriche dismesse. Fingiamo di non esserci accorti che quei luoghi, mancavano da anni di una comunità, di un soggetto sociale vivace che se ne sentisse proprietario culturalmente, che integrasse nel proprio comportamento normale, senza sforzi eroici, il minimo vitale di manutenzione del territorio. E fingiamo di non vedere la parallela vicenda che accade alle periferie, dove non si riesce a consolidare un nucleo abitante che faccia proprio quel lembo di città, lasciato orfano di gente che lo curi e nato già perso al sentire comune, fuori dagli affetti primari. Anch’esso condannato all’abbandono sin dalla posa della prima pietra. Le case in cemento armato dureranno più o meno come i muretti a secco, poi il loro degrado le farà sembrare estranee alla città, e sarà impossibile capire se sia il degrado a chiamare la marginalità degli abitanti o viceversa sia la condizione di dropout a impedire il radicamento e la cura per sé dei luoghi che si abitano. E non rimarrà che azzerare tutto, demolire i muri, disperdere ogni possibile memoria, tornare alla materia prima del suolo per riproporre nuovi spazi a nuovi arrivati, senza mai essere sicuri di riuscire a stabilire il contatto e la temperatura che consente di non fare impazzire quella maionese tra uomini e spazi che fa la città.
Son vicende che sappiamo, o almeno sentiamo, ma fingiamo di non sapere, con la “falsa coscienza” che ancora ci fa scandalizzare a fronte dell’insostenibilità del nostro modello di consumi, quel modello che fingiamo di non vedere trasformato radicalmente nelle ultime due generazioni e accelerato verso un binario morto e mortale. Sapere ma non agire di conseguenza non è un vezzo radical-chic, ma un male oscuro che pervade profondamente la nostra cultura, dalle competenza tecniche prive di indirizzi etici all’emergere di bisogni e di “diritti” non equilibrati da adeguate “prese in carico” responsabili.
Così si sbriciolano apparati disciplinari che credevamo fondamentali, come quelli degli urbanisti, dedicati a una tecnica di governo dei cambiamenti territoriali che, anche se ci fossero ancora sindaci che la vogliono applicare, risulterebbe del tutto inefficace confronto alle attuali dinamiche epocali. Ma non va meglio agli economisti e agli amministratori pubblici, privi di riferimenti a strategie paganti sul breve periodo e inetti a sostenere politiche strutturali e culturali, (forse) paganti sul medio-lungo periodo.
Abbiamo avuto tutti almeno 30 anni per adeguare le nostre tecniche alle nuove dinamiche in corso e abbiamo invece messo a punto sistemi apparentemente più efficaci per governare le vecchie situazioni. I piani regolatori operativi e i premi di cubatura in urbanistica ormai valgono come riempire di coccodrilli i fossati di cinta quando i cannoni sbriciolano ogni muro.
Forse il problema sembra affrontabile perché pare ancora episodico. Come tutte le patologie endogene l’abbandono ha cominciato con l’erodere le parti più deboli: dalle fabbriche della prima industria a quelle fasulle dei finanziamenti europei, dagli insediamenti d’emergenza (dove emergenti sono le masse crescenti di chi chiede città senza saperla usare) ai versanti terrazzati. Ogni sindaco pensa di essere incappato in una vicenda particolare, e si batte per trovare la soluzione speciale per il proprio caso: fioccano i quartieri demoliti, i soldi spillati a una fondazione bancaria per allestire musei autoriferiti, centri multi funzionali deserti, contenimenti di frane lungo strade che portano a rovine abbandonate da tutto salvo che dagli scaricatori di rifiuti, per non parlare dell’accanimento terapeutico per le fabbriche decotte, in nome dei posti di lavoro (in decottura anch’essi).
Ma se alziamo lo sguardo all’area vasta, e guardiamo le medie valli di montagna, i litorali lontano dai centri maggiori, le distese di zone industriali mai decollate, diventa chiaro che non si possono pensare centinaia di soluzioni speciali, ciascuna con il suo investimento a perdere, il suo quartiere di sfollati, il suo museo sempre chiuso, la sua insostenibilità gestionale.
È innegabile che fuori dalle città l’abbandono è un processo epocale di dimensioni addirittura continentali. In Italia non ha più senso fare riferimento al valore di scambio per l’immobiliare rurale, con gli alloggi in vendita a mille euro, con l’incubo dell’IMU delle case dei padri contadini a turbare i, magri bilanci dei figli cittadini. D’altra parte non possiamo che constatare la fine del valore d’uso dei luoghi abbandonati, l’estinzione della domanda, di chi è interessato ad avere a disposizione quello strumento per abitare e produrre ancora in quel modo millenario.
Finora ogni progetto aveva cercato di rattoppare la macchina riproduttiva delle condizioni tradizionali; ora dobbiamo attestare che l’abbandono territoriale segna la fine di una proprietà culturale dei luoghi, quella che derivava da quel modo di abitare fatto di lavoro manuale sistematico, di continua manutenzione, di ritmi stagionali, di estrema sobrietà nei consumi e nei rapporti sociali.
È ormai chiaro che non c’è più alcuna possibilità di restaurare la continuità del mondo rurale dell’ultimo millennio. È chiaro che il futuro dei territori come i nostri sarà organizzato e gerarchizzato secondo valori e comportamenti diversi da quelli a cui siamo abituati. E viene in mente la lucida etica del progetto che Gambino avanzava già oltre 20 anni fa: «conservare è innovare».
I nuovi montanari
Come la nave abbandonata anche dal suo capitano diventa relitto a disposizione di chiunque se ne impossessi, così un luogo abbandonato anche dall’ultimo coltivatore è di chi lo riabita.
Se guardiamo cosa è successo lungo le coste, con l’avvento del turismo del sole che ha sradicato i modi e i luoghi dell’abitare rivierasco, capiamo l’incommensurabilità dei due modelli, con quello attuale vincente che ha ridotto a comparse da riserva indiana pescatori e barcaioli, che erano i protagonisti del modello consolidato per secoli e prevalente fino a 50 anni fa. E pensando a quella dinamica e allo sfascio ecosistemico, paesaggistico, morale che ne è derivato, ci pare che si sia sprecata un’occasione irripetibile, quella di valorizzare un unicum planetario, come sarebbero le nostre coste senza l’osceno realizzato nelle ultime due o tre generazioni.
Ora tocca alla montagna, non importa se appenninica o alpina, tocca a migliaia di insediamenti sopra i 600 metri, fuori dal centinaio di mete turistiche e dagli itinerari delle grandi strade di passo. Ora quella montagna è spopolata. Pochi e spesso temporanei gli attuali abitanti, figli e nipoti dell’ultima generazione di indigeni indipendenti, per lo più incapaci a mantenere tra loro un minimo di comunità locale reale e non solo di rappresentanza. Accanto a questi sono crescenti i forestieri che per scelta (per lo più gli europei) o per necessità (per lo più gli altri) non stanno in città.
A prima vista si potrebbero chiamare mountain users, diversi dai montanari quanto i city users son diversi dagli abitanti di città. Infatti c’è qualche radicale differenza di comportamento e di cultura dei luoghi: i nuovi arrivi sono quasi sempre di gente che è vissuta in ambiente urbano, che ha assaporato lo status del cittadino, di chi ha facile accesso ai servizi, è immerso in un, mare di opportunità, conosce superficialmente molti luoghi e molte persone, comunica prima di pensare, ha un rapporto raro e sporadico con la natura.
Eppure, se trascuriamo chi lo fa per necessità, quei cittadini hanno scelto l’habitat montano proprio perché sanno dare prestazioni inverse a quelle di città: l’accesso ai servizi è faticoso, il ventaglio delle possibili attività è molto modesto, sia per il lavoro che per il tempo libero (per lo più ricalcano le attività svolte secolarmente, ora con meno fatica), le frequentazioni di persone sono limitate (ancora più di quelle delle passate generazioni, quando i villaggi erano ben popolati), le comunicazioni sono ridotte e saltuarie (anche i cellulari spesso non hanno campo), e d’altra parte il rapporto con la natura è sistematico e continuo, ineludibile (anche data la generale modestia degli spazi al chiuso).
Insomma, coloro che, per nostalgia o senso di impresa, vanno oggi a vivere in montagna, fanno consapevolmente la scelta di un modello di vita culturalmente alternativo a quello urbano a cui sono abituati, forse proprio perché delusi da qualche competenza disciplinare che doveva consentire di progettare il futuro e invece…. Sono scelte che si traducono in comportamenti nuovi, difficili da distinguere tra quelli indotti da mode passeggere e quelli che si stanno radicando in una nuova struttura socioculturale.
In generale si riscontrano alcuni aspetti costanti: se da una parte si cerca di mantenere un kit minimo di urbanità a cui si è abituati, d’altra parte si esige che rimangano intatte quelle diversità alternative per cui si è deciso di salire ad abitare in quota con un senso di liberazione, dopo generazioni che invece scendevano a valle col magone nel cure. Il nuovo montanaro apprezza la natura e il paesaggio in modo “colto”, molto più esplicitamente e con attenzione dell’abitante storico; ha un modello di vita sobrio, spesso per scelta o per rendere più sostenibile la sua scelta di vita; ha un modello di lavoro o almeno di tempo libero con consistenti quote di attività fisiche all’aria aperta.
Fin qui si tratta di un identikit facilmente constatabile, che tiene insieme quasi tutto l’eterogeneo accrocchio dei nuovi montanari., ma si verifica anche una situazione disgregante: chi sceglie la montagna per difendersi dalla società dei social e della comunicazione ossessiva e obbligatoria ha certamente un progetto di vita, ma spesso stretto in una chiusura autistica che porta alle scelte solitarie, all’individualismo sociale. Insomma la montagna desiderata è pensata nell’immaginario dei nuovi abitanti più come un eremo che come un cenobio.
Con questo atteggiamento è forse la dimensione del villaggio quella che più si è persa con la fine delle comunità storiche. Era una comunità modesta, di poche decine o centinaia di persone, che è sempre stata stretta ai più giovani, ma che ha reso potente il progetto implicito dell’insediamento rurale, perché capace di lavori titanici come i terrazzamenti, le canalizzazioni, gli spietramenti e i disboscamenti per aver pascoli, sfalci e seminativi. Era quella comunità di fatica e regole di sopravvivenza che ancora durava nel coutumier tradizionale (il prontuario dei comportamenti consolidati che sostituiva la legge ufficiale, di città) e che dava alla riunione dei capofamiglia un ruolo strategico per le imprese comuni di fronte alle avversità collettive.
Oggi chi abita la montagna sembra preferire “la vita solitaria”, o più probabilmente soddisfa le proprie esigenze di relazioni sociali partecipando a reti aterritoriali, tra persone anche molto distanti, attraverso i social o incontrate direttamente in modo saltuario e individuale, non condiviso con i vicini. È chiaro che, con questo nuovo approccio, l’insediamento montano in cui si abita viene vissuto più come un condominio piuttosto che un villaggio: genera problemi di gestione dell’esistente piuttosto che spingere a progettare imprese collettive per garantire un futuro migliore a quel luogo e alle stirpi che lo abiteranno.
Sono gli effetti che riscontriamo un paio di lustri dopo interventi, pur sempre preziosi, di riabilitazione di interi nuclei in abbandono, o di programmi di reintroduzione di pratiche rurali che si erano andate perdendo, o di organizzazione ad albergo diffuso di abitati sparsi in vallate tagliate fuori dal turismo invernale. Si tratta quasi sempre di progetti sostenuti da una forte capacità di mobilitazione e senso imprenditoriale di un soggetto promotore e da un sostanzioso contributo pubblico, che talvolta superano mille difficoltà nella fase di creazione dell’infrastruttura o della sede fisica della nuova attrezzatura e che poi vanno perdendo energia e sostenibilità quando si passa alla fase gestionale e alla imprenditorialità distribuita tra i fruitori dell’intervento: i nuovi abitanti sinora non ne sanno fare tesoro ed è in agguato il rischio di un secondo abbandono in meno di un secolo.
Una rivoluzione per i progetti territoriali
Emerge da questo racconto un aspetto sinora trascurato, ma fondamentale per chi studia strategie di valorizzazione territoriale. Si può sintetizzare brutalmente così:
l’insediamento montano può disporre in prospettiva di nuove risorse umane che lo abitano riconoscendone i valori primari, ma che dispongono di una strumentazione progettuale e organizzativa probabilmente inadeguata ad affrontare i problemi di un territorio così impegnativo, mancando spesso la capacità di intervento collettivo e di lungo periodo.
Ora, se questi sono i caratteri della tipologia socioculturale e psicologica dei nuovi abitanti, con questi dobbiamo affrontare il problema: nel breve periodo non possiamo contare su cambiamenti diffusi e strutturali di un trend generazionale che si sta appena consolidando e che non ha alternative se non peggiori: l’abbandono totale o la devastazione consumistica.
Dunque ogni programma che si prefigga una valorizzazione sostenibile dell’insediamento montano non può prescindere dalle caratteristiche di questa nuova tipologia di abitanti, pena la perdita dell’investimento, delle energie di tutti i soggetti, dell’impegno dei migliori progettisti e dei denari pubblici. In una situazione come questa, quali sono le strategie da mettere a punto?
Si deve ovviamente scartare la forzatura a comportarsi “come” in un villaggio tradizionale, che, come abbiamo visto, era organico a un sistema di vita e di scelte chiuso localmente, ma spinto ad azioni collettive e di lungo periodo, mentre qui abbiamo a che fare con soggetti aperti al mondo, ma che tendono a non aderire convintamente ad azioni locali organizzate.
D’altra parte si sta dimostrando necessaria, ma non sufficiente la strategia della diffusione degli standard di servizio urbani, centrale nel Programma Aree Interne. Infatti gli interventi previsti nel Programma Aree interne soddisfano (forse) la richiesta di accessibilità a dotazioni minime di servizi, ma (probabilmente) poco riescono ad incidere sulla particolarità specifica del vivere in montagna.
La vita di montagna è desiderata dai nuovi abitanti, ma questi in molti casi non riescono a sostenerla nel tempo, non tanto per la mancanza di servizi per loro, ma per la mancanza di progettualità e di competenza riguardo i lavori che loro possono svolgere, riguardo le produzioni o i servizi che loro possono fornire ai cittadini di pianura.
Infatti i nuovi montanari tendono a trascurare una risorsa implicita nella loro stessa storia biografica: la loro conoscenza del sistema città, dei gusti e dei modi dei cittadini. È d’altra parte evidente che una prospettiva decente di vita nei contesti montani si può raggiungere solo con una nuova relazione con la pianura, che è il naturale complemento necessario per ogni integrazione economicamente sostenibile.
Dunque, se non si vuole che la montagna diventi, come il litorale, un archetipo dei luoghi di abitazione di cittadini non attivi (perché ricchi, o in vacanza, o pensionati), occorre facilitare iniziative produttive di nuova generazione per i nuovi abitanti, promuovendo quelle che valorizzano in modo sostenibile le risorse proprie della montagna, mettendole a disposizione dei cittadini di pianura, ma curando che ciò possa realizzarsi anche da parte del singolo operatore, non necessariamente integrato in una comunità di intenti con gli altri abitanti.
È una prospettiva di notevole difficoltà, che chiede di superare la fiducia nelle opere di interesse generale, sinora considerate infrastrutture di base generatrici automatiche di progettualità e sviluppo diffuso.
Quindi non fidiamoci più “soltanto” di recuperare interi nuclei abbandonati, o di completare sistemi di strade forestali che danno accesso a ogni pascolo, o di costruire servizi scolastici o per il tempo libero teoricamente utili per abitati dispersi: quasi tutte quelle esperienze, preziose nella loro ideazione, gloriose al momento della realizzazione, dimostrano dopo qualche anno la loro bassissima efficacia nell’innesco di processi autogeneratori di sviluppo e di radicamento di nuove forze insediative.
Ma è anche difficile promuovere con successo lo sviluppo di attività imprenditoriali di singoli operatori con strumenti top-down, come siamo abituati a fare con i programmi mirati: come si è detto prima abbiamo a che fare con una tipologia di soggetti nuova, carica di attese, eticamente motivata, ma quasi sempre poco strumentata e per certi versi ingenua, che in ogni caso difficilmente si adegua a percorsi standard già tracciati.
L’unica strategia potenzialmente applicabile a questo tipo di “nuovi coloni” è quella che si cerca di attivare per le start-up di processi innovativi: assicurare una promozione iniziale a fronte di una bozza di progetto del proponente e del suo impegno duraturo, ma soprattutto garantire un accompagnamento sistematico, competente e operativo, sul campo (è il caso di dirlo), per alcuni anni.
Occorre guardare, come esempi e buone pratiche, alle nu- merose esperienze di governance dei processi territoriali che han- no da tempo sperimentato paesi che hanno il problema delle vere periferie, come la Francia o la Gran Bretagna. Di fatto le regole di pianificazione sono state sostituite da agevolazioni e facilitazioni, sgravi fiscali e aiuti riferiti per lo più alle imprese e (in misura molto inferiore) alle infrastrutture e al patrimonio immobiliare. E per le imprese, ritenute interessanti sulla base di progetti credibili e monitorati nei loro sviluppi e nelle difficoltà che si incontrano, si agevola non solo l’avviamento, ma anche la manutenzione e tutti gli aspetti di formazione delle competenze e di ammortamento de- gli investimenti progressivi.
Secondo noi il criterio di fondo, per selezionare i progetti da agevolare, è il contributo al bene comune. È un criterio che troppo spesso associamo a strategie collettive, ma che si deve poter applicare in ogni caso, singolo o collettivo, di azioni PER la collettività.
È fondamentale selezionare progetti positivi rispetto alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale, disponibilità a raccontare ad altri la propria esperienza, interesse a rendere circolare l’economia, ma anche la disponibilità a partecipare a una nuova cultura operativa e imprenditoriale che coniughi valorizzazione della natura, superamento della divisione tra lavoro e tempo libero, ricerca del piacere non consumistico. Sono requisiti di progettualità che non si possono chiedere a chi ha patito freddo e fame da generazioni abitando in modo tradizionale la montagna, e che invece più facilmente animano chi viene, deluso dalla città, a far sinergia con i valori impliciti e duraturi della montagna, che resistono oltre l’abbandono. Infatti bisogna tener conto che le idee, il know-how, l’educazione ai rapporti con la città comunque rimangono a disposizione dei nuovi abitanti, come una cassetta degli attrezzi fondamentale.
Per aiutare chi cerca di progettare il proprio futuro a partire dalla scelta radicale del nuovo modo di abitare, occorre una strategia pubblica che lavori sul piano della cultura più che delle opere, che assuma il paradigma urbano non tanto a partire dai servizi alla persona quanto dai servizi per la imprenditorialità. Sono strategie che costano molto in termini di “tempo politico” (presenza sul territorio di agenzie competenti, alleanza con i sindaci dei piccoli comuni, comunicazione delle iniziative etc.) e risorse umane di qualità (soprattutto per l’accompagnamento e la cura delle specificità di ogni progetto), ma probabilmente costano molto meno di ogni strategia di lavori pubblici che sinora ha catturato la gran parte delle risorse per la montagna.
Quando ogni valle avesse due o tre esempi di nuovi abitanti, che riescono a radicare le proprie attività innovative, è quasi certa l’attivazione dei neuroni-specchio sociali che moltiplicano le buone pratiche in infinite varianti locali e rigenerano il territorio con una diffusione risolutiva.
Sarà allora il caso di una lezione di sviluppo dalla periferia al centro, per cui un territorio, proprio per le sue stesse caratteristiche viene scelto per essere abitato con comportamenti etici e sobri e induce trasformazioni sostenibili e adeguate ai tempi: un modello di scelte per le nuove generazioni, un modo sano di abitare il futuro. E scopriremo che necessariamente deve muovere dall’abbandono del modello precedente.