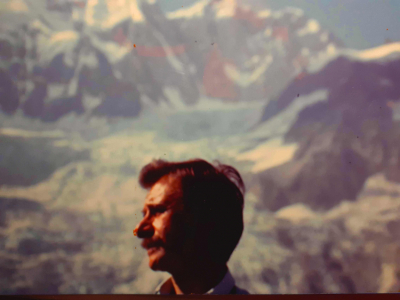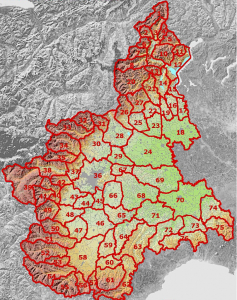Indice
Per una semiotica del paesaggio narrativo-estetico
Se scegliessimo di interpretare il paesaggio attraverso i codici delle discipline geografiche, non avremmo alcun bisogno di transitare attraverso la semiotica: basterebbe conoscere quei codici e addestrarsi al loro corretto uso. Ma se ci ponessimo il problema di capire come sia possibile che l’informazione percettiva del mondo si trasformi in testo narrativo a valenza estetica, se fossimo cioè interessati a capire come sia possibile che un paesaggio si carichi di quell’effetto di senso che in modo molto approssimativo indichiamo con la parola “bellezza”, allora non troveremmo, al momento, alcun codice altrettanto ben confezionato e pronto per l’uso. La struttura e il funzionamento di questo complesso e aleatorio codice comportano un’indagine su quella facoltà strana che è la semiosi narrativo-estetica: la semiotica potremmo non nominarla mai, ma dobbiamo comunque sapere che il lavoro da compiere è di tipo semiotico. Come possiamo, dunque, impostare uno studio semiotico del paesaggio in modo tale che ci faccia capire il suo funzionamento estetico?
Quella della semiotica è un’ottica ostica, perché contrasta con la nostra abituale percezione del mondo, o meglio, con la sensazione che noi abbiamo di essa: là dove noi vediamo oggetti, cose, là dove percepiamo odori, suoni, la semiotica vede l’operare della semiosi. Noi percepiamo le cose e al tempo stesso nutriamo nei confronti della nostra percezione una sorta di fiducia cieca sul fatto che essa ci riveli la natura stessa delle cose. Tutte le persone dotate di facoltà percettive normali percepiscono le cose allo stesso modo; dunque le cose sono come noi le percepiamo, la percezione è oggettiva, perché ci offre le cose del mondo così come esse sono. Cosa c’è dunque di più oggettivo del “paesaggio percettivo”, del “paesaggio visivo”? Quando parliamo di percezione, comunemente pensiamo all’informazione che ci proviene dallo stimolo percettivo, per cui la nostra percezione visiva non sarebbe molto dissimile da quella di una macchina fotografica. La semiotica mette in crisi questa nostra “fede percettiva” (Merleau-Ponty 1964). Per la semiotica l’informazione dello stimolo è solo la materia prima su cui opera la semiosi percettiva, ed essa opera attraverso un lavoro di selezione che coglie solo l’informazione significante tralasciando quella non significante, dove la prima è solo quella che corrisponde ai significati che noi siamo abituati ad assegnare alle cose: noi ‘percepiamo’ solo ciò che risponde alle nostre attese di significazione. Percepire vuol dire significare e la capacità di significare dipende dal senso che alberga nella semiosfera della nostra Enciclopedia (Lotman 1985). L’informazione dello stimolo che non riesce a farsi significante non entra nella nostra semiosfera e si perde nel nulla. Il paesaggio che vediamo è solo quello che siamo in grado di raccontare: quanti paesaggi abbiamo perduto perché non li abbiamo osservati per raccontarli?
Come diceva Merleau-Ponty, “è vero che il mondo è ciò che noi vediamo, ed è altresì vero che nondimeno dobbiamo imparare a vederlo” (1964, 32), e poiché la visione è semiosi e questa conduce a significati che mutano al mutare della nostra Enciclopedia, possiamo affermare che non smettiamo mai di imparare a vederlo.
Spesso si sente dire che il giudizio estetico è soggettivo (il che sarebbe già di per sé un difetto), peccato però che la soggettività operi ben prima che il giudizio estetico possa essere profferito; essa rende ‘difettoso’ l’atto stesso della percezione, poiché non vi è nulla di più soggettivo dello sguardo e dell’ascolto (Barthes 1977).
Alla luce di queste considerazioni possiamo, da subito sgombrare il campo da un paesaggio inesistente, che alberga nella pesaggistica contemporanea: quel “paesaggio visivo o percettivo” che è figlio della “fede percettiva”. Che cos’è il “paesaggio visivo”? È ciò che noi vediamo. E che cosa vediamo? Ciò che ci offre la nostra visione... Se vogliamo uscire da questo circolo vizioso, dobbiamo cominciare a ‘nominare’ le cose che vediamo, ma nominare è appunto assegnare significati ad una porzione dello stimolo percettivo: noi vediamo solo ciò che siamo in grado di trasformare in senso. La percezione la sentiamo così intimamente fusa con la semiosi che non abbiamo più la capacità di distinguere tra ‘percezione come stimolazione’ (ciò che avviene sulla retina come sulla pellicola) e ‘percezione come significazione’ (ciò che ci consente di parlare di quello che vediamo), per cui il significato ci appare come qualcosa di connaturato con il mondo, mentre è solo il senso che noi gli diamo e della cui provvisorietà abbiamo ampiamente parlato.
Non concordo sulla fecondità di definizioni che sono frutto di un inganno dell’abitudine; le nozioni di “paesaggio visivo” e di “paesaggio percettivo” dovrebbero essere espulse dal lessico della paesaggistica, perché il non senso non può essere fecondo; può solo essere la sterile premessa su cui fondare un autoinganno, a meno che l’analisi sul paesaggio visivo venga portata fino al punto di prendere piena coscienza di quel confine che divide il visibile dall’invisibile; ma questo ci riporta appunto ad un’indagine sulla semiosi percettiva, sul suo funzionamento, sulle strutture che la reggono e sui suoi possibili approdi semantici.
Per inciso possiamo osservare come il tema sia di grande attualità: non è un caso che, dopo “Il trattato di semiotica generale” dove la percezione era solo marginalmente trattata, Umberto Eco abbia sentito il bisogno di scrivere “Kant e l’ornitorinco”, in gran parte dedicato ad un’indagine sulla semiosi percettiva e su come essa trasformi lo stimolo in segno. Ma potremmo riferirci alle ricerche nel campo delle scienze cognitive o dell’intelligenza artificiale. Per rimanere alla semiotica, si potrebbe indicare il filone greimasiano della ‘semiotica generativa’ là dove fa i conti con il momento sorgente del senso, dove il linguaggio si scinde dalla sensorialità, dove gli effetti di senso, che coinvolgono gli strati profondi del “timico”, si trasformano in significati comunicabili attraverso quella sintassi di superficie che è propria del linguaggio (Greimas 1970).
Non è qui possibile sviluppare, pur nelle sue linee generali, quella che potremmo definire una grammatica del paesaggio narrativo-estetico, e mi trovo per ciò costretto a rinviare ad altri miei lavori (Socco 1996, 1998).
Vorrei però accennare ad un aspetto importante che una teoria semiotica del paesaggio narrativo-estetico deve affrontare: il formato base del testo paesaggistico. La semiotica, lo abbiamo visto, tende a ridurre ogni cosa a ‘sistema di segni’, e poiché il modello più evoluto di sistema di segni è il testo narrativo, la parola “testo” ha finito per diventare sinonimo di qualsivoglia sistema di segni, come può esserlo un dipinto, un componimento musicale o anche una porzione di mondo. Ovviamente una cosa è un testo narrativo, che è una struttura sequenziale di significanti sintatticamente congegnata per comunicare dei significati, e altra cosa è, ad esempio, un luogo fatto di cose disposte nello spazio senza una intenzionalità comunicativa. Per cui si pone il problema di una sua messa in formato in modo conforme a quanto avviene nella semiosi. In altri termini si tratta di capire come la semiosi strutturi l’informazione percettiva dello spazio in modo tale da poterla tradurre in un testo narrativo a valenza estetica. Su questo aspetto mi pare che la metafora che Turri ci propone del “paesaggio come teatro” sia ben di più di una metafora: sia cioè il modello della struttura testuale. Per il vero, nella concezione di Turri il “teatro” compare in un significato più ampio e ricco di quello in cui intendo utilizzarlo. Per Turri il paesaggio-teatro è il luogo dove noi siamo attori e spettatori della recita che è la nostra esistenza e, al tempo stesso, siamo i formatori della scena che ospita la recita. Io recupero questo modello in una accezione più ristretta di spazio scenico che costituisce il contesto ineliminabile di ogni oggetto e di ogni azione in quanto segni.
Questo concetto di ‘scena-contesto di un segno’ lo ritroviamo nella semiotica là dove fa i conti con la forma dell’Enciclopedia. Poiché i significati che noi attribuiamo al mondo sono tra loro relazionati da una struttura, il problema di ogni teoria semantica, cioè del sistema dei significati, è quello di individuare la forma di tale struttura.
Nelle teorie semantiche si tende a distinguere tra una struttura in forma di Dizionario e una in forma di Enciclopedia (Eco 1984). Il Dizionario riguarderebbe “l’insieme circoscritto delle conoscenze linguistiche costitutive del significato, mentre l’Enciclopedia rappresenterebbe l’insieme generale delle conoscenze sul mondo, di natura fattuale e potenzialmente aperto, se non illimitato” (Violi 1997, 87). In altri termini, il Dizionario comprende solo i significati denotativi correnti delle cose, indipendentemente dal contesto in cui compaiono; l’Enciclopedia registra tutti i significati ulteriori che sul significato denotativo possono essere caricati a seconda del contesto e della circostanza in cui le cose compaiono (Eco 1975, 1979; Fillmore 1985). In effetti, se non ammettessimo che le cose possano assumere connotazioni diverse a seconda dei contesti, non riusciremmo a spiegare le differenze di senso dei vari contesti e dei vari oggetti in ciascun contesto, finendo così per appiattire il senso del mondo in una sommatoria dei soliti significati denotativi delle cose singolarmente prese. La forma strutturale dell’Enciclopedia riesce dunque a dar conto del complesso di connotazioni di cui ogni cosa si può caricare, dei diversi significati e delle diverse sfumature di senso che ad esempio fanno sì che quella cosa che chiamiamo “acqua” diventi un universo sconfinato di senso a seconda dei paesaggi reali e possibili in cui compare e delle recite che la natura, con le sue variazioni climatiche, vi svolge e di quelle che vi svolge l’uomo con le proprie azioni. È nell’intricata struttura dei diversi possibili inserimenti contestuali e circostanziali della nostra Enciclopedia che ritroviamo l’universo possibile del senso.[1]
Se la ‘scena-contesto’ è il modello base attraverso cui la semiosi mette in formato i vari significanti per assegnarvi i vari possibili significati, allora essa è anche il modello che la semiosi adotta per la messa in formato di quella forma singolare di testo che è il luogo che ci contiene: la ‘scena-contesto’ è il modello dell’unità base del paesaggio narrativo (Socco 1998). Ha ragione Gambino quando richiama la nostra attenzione sul problema cruciale del giusto formato dell’unità di paesaggio e della sua complessità definitoria nel momento in cui usciamo dai singoli paesaggi geografici, ciascuno con le sue unità di paesaggio, e cerchiamo di entrare in quella forma olistica di paesaggio che condensa il senso pieno del paesaggio stesso (Gambino 1997). Ma questo modello è lo stesso che i semiologi hanno dovuto mettere a punto per spiegare come sia possibile che lo stesso segno (o oggetto) si possa caricare di significati diversi a seconda dei contesti (o luoghi) e di come i contesti siano portatori di significati complessivi (o globali, o olisticamente assunti), che non sono esprimibili come sommatoria dei significati dei singoli segni componenti (per quel noto iato che esiste tra il locale e il globale, tra l’elemento componente e il sistema complessivo).
Il testo paesaggistico dunque si presenta in forma di ‘scena-contesto’ colta in una certa circostanza recitativa. Questa ‘scena-contesto’ è costituita da una lista di oggetti e di attanti colti in una certa circostanza (cioè da un contenuto lessematico); ciascun oggetto è collocato in una determinata posizione della struttura topologica dello spazio e muta il proprio significato connotativo a seconda della posizione nella struttura stessa (la quale pertanto costituisce la struttura sintattica delle connessioni sintagmatiche); ciascun oggetto è portatore di una informazione plastica cromatico-eidetico-materica in relazione alla quale si carica di connotazioni espressive diverse (Greimas 1984) (ed è a questo livello che si pone un problema di morfologia del paesaggio). Come si vede vi sono le premesse per dare fondamento ad una grammatica del paesaggio narrativo nella sua articolazione lessematica, sintattica e morfologica. Rimane il problema di scoprire ciò che aumenta il grado di ambiguità del testo paesaggistico imprimendogli quel di più che è la sua valenza estetica; ma mi pare vi siano, almeno tentativamente, le premesse per poterlo fare.
[1] L’enciclopedia è “l’unico modello capace di render ragione, sia sul piano teorico, sia come ipotesi regolativa per processi concreti di interpretazione, della complessità della semiosi.” (Eco 1984, 255).