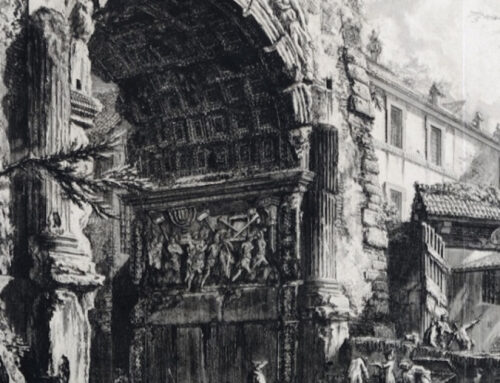Per chi ha visto (e denunciato) il corso quasi indisturbato dell’abbandono della montagna negli ultimi 70 anni, è chiaro che la situazione attuale è ormai un’altra storia, con nuovi attori e un nuovo senso della vita.
È chiaro perché ci ricordiamo dei montanari che non ci sono più, quelli che sono in piedi alle cinque e correggono il primo caffè con due dita di grappa, quelli con il passo sempre uguale in salita o in discesa, dopo un’ora o dopo dieci di cammino, che danno del voi al coniuge, che non sono mai entrati in un ospedale.
Quelli volevano fare quello che facevano (forse avrebbero preferito un po’ meno di fatica…), non avevano altro progetto che mantenere le qualità del loro spazio di lavoro e di vita (e scusate se è poco…). Ovviamente si trattava di un progetto implicito, a cui partecipava l’intera comunità ma quasi non consapevole, che però permeava da molte generazioni e coerentemente tutti gli atti quotidiani e gli eventi ricorrenti, a partire dal modo testardo di coltivare e di allevare sino agli incontri della festa e alle relazioni con i forestieri.
Era l’ultima generazione di una società abbastanza completa in sé, gelosa della propria autonomia, priva di invidie per lo status dei cittadini che venivano in visita, con una vita d’altura consapevole di una alterità irriducibile ma non conflittuale con la città in basso.
Ora la montagna è abitata, poco e saltuariamente, dai figli e dai nipoti di quella ultima generazione di indigeni indipendenti e da qualche forestiero che per scelta (gli europei) o per necessità (gli altri) non sta in città. Si tratta quasi sempre di gente che è vissuta in ambiente urbano, che ha assaporato lo status del cittadino, di chi ha facile accesso ai servizi, è immerso in un mare di opportunità, conosce superficialmente molti luoghi e molte persone, comunica prima di pensare, ha un rapporto raro e sporadico con la natura.
Eppure quei cittadini hanno scelto l’habitat montano che sanno richiedere comportamenti inversi a quelli di città: l’accesso ai servizi è faticoso, il ventaglio delle possibili attività è molto modesto, sia per il lavoro che per il tempo libero (per lo più ricalcano le attività svolte secolarmente, ora con meno fatica), le frequentazioni di persone sono limitate (ancora più di quelle delle passate generazioni, quando i villaggi erano ben popolati), le comunicazioni sono ridotte e saltuarie (anche i cellulari spesso non hanno campo), il rapporto con la natura è sistematico e continuo, ineludibile (anche data la generale modestia degli spazi al chiuso).
Insomma, coloro che, per nostalgia o senso di impresa, vanno oggi a vivere in montagna, fanno consapevolmente la scelta di un modello di vita culturalmente alternativo a quello urbano a cui siamo abituati.
Sono scelte che si traducono in comportamenti nuovi, difficili da distinguere tra quelli indotti da mode passeggere e quelli che si stanno radicando in una nuova struttura socioculturale.
In generale si riscontrano alcuni aspetti costanti: se da una parte si cerca di mantenere un kit minimo di urbanità a cui si è abituati, d’altra parte si esige che rimangano intatte quelle diversità alternative per cui si è deciso di salire ad abitare in quota, con un senso di liberazione, dopo generazioni che invece scendevano a valle, col magone nel cuore.
Il nuovo montanaro apprezza la natura e il paesaggio in modo “colto”, molto più esplicitamente e con attenzione dell’abitante storico; ha un modello di vita sobrio, spesso per scelta o per rendere più sostenibile la sua scelta di vita; ha un modello di lavoro e di tempo libero con consistenti quote di attività fisiche all’aria aperta. Fin qui si tratta di un identikit facilmente constatabile, che tiene insieme quasi tutto l’eterogeneo accrocchio dei nuovi montanari.
Ma si verifica anche una situazione disgregante: chi sceglie la montagna per difendersi dalla società dei social e della comunicazione ossessiva e obbligatoria ha certamente un progetto di vita, ma spesso stretto in una chiusura autistica che porta alle scelte solitarie, all’individualismo sociale. Insomma la montagna desiderata è pensata nell’immaginario dei nuovi abitanti più come un eremo che come un cenobio.
Con questo punto di vista è forse la dimensione del villaggio quella che più si è persa con la fine delle comunità storiche. Era una comunità modesta, di poche decine o centinaia di persone, che è sempre stata stretta ai più giovani ma che ha reso potente il progetto implicito dell’insediamento rurale, perché capace di lavori titanici dei terrazzamenti, delle canalizzazioni, degli spietramenti e dei disboscamenti per aver pascoli, sfalci e seminativi. Era quella che ancora durava nel coutumier tradizionale (che sostituiva la legge ufficiale, di città) e che dava alla riunione dei capofamiglia un ruolo strategico per le imprese comuni di fronte alle avversità collettive.
Oggi chi abita la montagna sembra preferire “la vita solitaria” leopardiana, o più probabilmente soddisfa le proprie esigenze di relazioni sociali partecipando a reti aterritoriali, tra persone anche molto distanti, incontrate direttamente in modo saltuario e individuale, non condiviso con i vicini.
E’ chiaro che, con questo approccio, l’insediamento montano in cui si abita viene vissuto più come un condominio piuttosto che un villaggio: genera problemi di gestione dell’esistente piuttosto che spingere a progettare imprese collettive per garantire un futuro migliore a quel luogo e alle stirpi che lo abiteranno.
Di fatto è ciò che riscontriamo storicamente: questi sono i risultati operativi di interventi, pur sempre preziosi, di riabilitazione di interi nuclei in abbandono, o di programmi di reintroduzione di pratiche rurali che si erano andate perdendo, o di organizzazione ad albergo diffuso di abitati sparsi in vallate tagliate fuori dal turismo invernale.
Si tratta quasi sempre di progetti sostenuti da un sostanzioso contributo pubblico e/o da una forte capacità di mobilitazione e senso imprenditoriale di un soggetto promotore, che hanno successo nella fase di creazione dell’infrastruttura o della sede fisica della nuova attrezzatura e che poi vanno perdendo energia e sostenibilità quando si passa alla fase gestionale e alla imprenditorialità distribuita tra i fruitori dell’intervento: i nuovi abitanti di cui si è tracciato il profilo sinora non ne sanno fare tesoro.
Questa lunga premessa per mettere a fuoco un aspetto sinora trascurato, ma fondamentale per chi studia strategie di valorizzazione territoriale della montagna.
Si può sintetizzare brutalmente così: l’insediamento montano può disporre in prospettiva di nuove risorse umane che lo abitano riconoscendone il valore, ma la loro strumentazione progettuale e organizzativa per affrontare i problemi di un territorio così impegnativo è oggi probabilmente inadeguata, mancando spesso la capacità di intervento collettivo e di lungo periodo.
Ora, se questa è la tipologia socioculturale e psicologica dei nuovi abitanti, con questa dobbiamo affrontare il problema: non possiamo contare su cambiamenti diffusi e strutturali nel breve periodo.
Dunque ogni programma che si prefigga una valorizzazione sostenibile dell’insediamento montano non può prescindere dalle caratteristiche di questa nuova tipologia di abitanti, pena la perdita dell’investimento, delle energie di tutti i soggetti, dell’impegno dei migliori progettisti e denari pubblici.
Quali le strade da percorrere per affrontare il problema?
Credo si debba scartare la forzatura a comportarsi “come” in un villaggio tradizionale, che, come abbiamo visto, era organico a un sistema di vita e di scelte chiuso localmente ma spinto ad azioni collettive e di lungo periodo, mentre qui abbiamo a che fare con soggetti aperti al mondo ma che tendono a non aderire convintamente ad azioni collettive di grande portata.
D’altra parte si sta dimostrando necessaria ma non sufficiente la strategia della diffusione degli standard di servizio urbani, centrale nel Programma Aree Interne. Infatti gli interventi previsti per le Aree interne soddisfano (forse) la richiesta di accessibilità a dotazioni minime di servizi, ma (probabilmente) poco riescono ad incidere sulla particolarità specifica del vivere in montagna.
La vita di montagna è desiderata dai nuovi abitanti, ma questi in molti casi non riescono a sostenerla nel tempo, non tanto per la mancanza di servizi per loro, ma per la mancanza di progettualità e di competenza riguardo i lavori che loro possono svolgere, riguardo le produzioni o i servizi che loro possono fornire ai cittadini di pianura.
Infatti i nuovi montanari tendono a trascurare una risorsa implicita nella loro stessa storia: la loro conoscenza del sistema città, dei gusti e dei modi dei cittadini. E’ d’altra parte evidente che solo con una nuova relazione con la pianura, che è il naturale sbocco di mercato della montagna si può raggiungere una prospettiva decente di vita in quei contesti.
Dunque, se non si vuole che la montagna diventi, come il mare, un archetipo dei luoghi di abitazione di cittadini non attivi (perché ricchi, o in vacanza, o pensionati), occorre facilitare iniziative produttive di nuova generazione per i nuovi abitanti, promuovendo quelle che valorizzano in modo sostenibile le risorse proprie della montagna mettendole a disposizione dei cittadini di pianura, ma curando che ciò possa realizzarsi anche da parte del singolo operatore, non necessariamente integrato in una comunità di intenti con gli altri abitanti.
È una prospettiva di notevole difficoltà, che chiede di superare la fiducia nelle opere di interesse generale, sinora considerate infrastrutture di base generatrici automatiche di progettualità e sviluppo diffuso.
Quindi non fidiamoci più “soltanto” di recuperare interi nuclei abbandonati, o di completare sistemi di strade forestali che danno accesso a ogni pascolo, o di costruire servizi scolastici o per il tempo libero teoricamente utili per abitati dispersi: quasi tutte quelle esperienze, preziose nella loro ideazione, gloriose al momento della realizzazione, dimostrano dopo qualche anno la loro bassissima efficacia nell’innesco di processi autogeneratori di sviluppo e di radicamento di nuove forze insediative.
Ma è anche difficile promuovere con successo lo sviluppo di attività imprenditoriali di singoli operatori con strumenti top-down, come siamo abituati a fare con i programmi mirati: come si è detto prima abbiamo a che fare con una tipologia di soggetti nuova, carica di attese, eticamente motivata, ma quasi sempre poco strumentata e per certi versi ingenua, che in ogni caso difficilmente si adegua a percorsi standard già tracciati.
L’unica strategia potenzialmente applicabile a questo tipo di “nuovi coloni” è quella che si cerca di attivare per le start-up di processi innovativi: assicurare una promozione iniziale a fronte di una bozza di progetto del proponente e del suo impegno duraturo, ma soprattutto garantire un accompagnamento sistematico, competente e operativo, sul campo (è il caso di dirlo), per alcuni anni.
E’ una strategia pubblica che costa molto in termini di “tempo politico” (presenza sul territorio di agenzie competenti, alleanza con i sindaci dei piccoli comuni, comunicazione delle iniziative etc.) e risorse umane di qualità (soprattutto per l’accompagnamento), ma probabilmente costa molto meno di ogni strategia di lavori pubblici che sinora ha catturato la gran parte delle risorse per la montagna.
Quando ogni valle avesse due o tre esempi di nuovi abitanti che riescono a radicare le proprie attività, è quasi certa l’attivazione dei neuroni-specchio sociali che moltiplicano le buone pratiche in infinite varianti locali e rigenerano il territorio con una diffusione risolutiva.
Sarà allora il caso di una lezione di sviluppo dalla periferia al centro, per cui un territorio, proprio per le sue stesse caratteristiche viene scelto per essere abitato con comportamenti etici e sobri e induce trasformazioni sostenibili e adeguate ai tempi: un modello di scelte per le nuove generazioni, un modo sano di abitare il futuro.