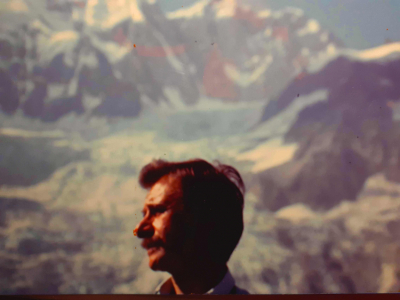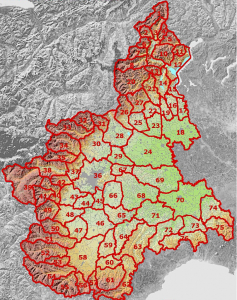Indice
Paesaggi terapeutici per rimediare il mal d’abitare
‘Abitare, e' sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra le cose che dicono il nostro vissuto, tra volti che non c'e' bisogno di riconoscere perche' nel loro sguardo ci sono le tracce dell'ultimo congedo.’
Umberto Galimberti, 1994.
‘Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili, intangibili, mai toccati e quasi intoccabili, immutabili, radicati; luoghi che sarebbero punti di riferimento e di partenza, delle fonti:
il mio paese natale, la culla della mia famiglia, la casa dove sarei nato, l’albero che avrei visto crescere (che mio padre avrebbe piantato il giorno della mia nascita), la soffitta della mia infanzia gremita di ricordi intatti...
Tali luoghi non esistono, ed è perchè non esistono che lo spazio diventa problematico, cessa di essere evidenza, cessa di essere incorporato, cessa di essere appropriato. Lo spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo.’
Georges Perec, 1973.
Sia Perec che Galimberti parlano di casa, quella conosciuta per prima, quella che Bachelard già negli anni ’50 pone al centro della sua “poetica dello spazio”. Parlano di una mancanza, che è forse l’aporia originale, il nostro fondamentale malessere di moderni e di sradicati.
L’urbanità, la mobilità, la globalizzazione hanno arato col vomere profondo quel terreno consolidato su cui erano cresciuti i riferimenti di un’intera civiltà ferma, che aveva dissodato montagne e deserti pur di stabilirsi, di porre radici, di esorcizzare la morte pensando che figli e nipoti vedranno la stessa terra che hanno visto i padri.
Contro il malessere della nostalgia esistenziale di casa, il fondamentale strumento terapeutico è il permanere di paesaggi conosciuti, il far si che Ulisse riconosca la sua Itaca.
Va notato che nel poema Ulisse non riconosce subito le rive della sua petrosa isola, e non è riconosciuto da chi stava lì. Perchè era uscito dal paesaggio, non era cambiato con loro. Manca la sintesi olistica e vitale, che non ha bisogno di comunicazione esplicita e codificata perchè la comunicazione avviene per vie interne ed implicite. Quindi, mancando il senso non codificato, c’è bisogno di segni, è necessaria Athena che gli dica
‘Ecco il porto di Forchis, del vecchio marino
ecco in capo del porto l’olivo frondoso
e qui vicino l’antro amabile, oscuro [...],
si questo è lo speco vasto, a volta, dove tu spesso
facevi alle ninfe ecatombi gradite (xiii, 345-348)’
e c’è bisogno che il porto, l’ulivo e il vasto speco siano stati lì ad aspettarlo.
Nell’Odissea le cose avevano aspettato, gli uomini no, e la loro morte è l’unico restauro possibile del paesaggio umano che Ulisse si aspettava da tanto tempo: mitica terapia d’urto.
Che cosa sarebbe successo se il paesaggio delle cose non avesse aspettato? Quale sarebbe stata la terapia per il “tradimento”? Ulisse, davanti al porto rifatto, all’ulivo tagliato, allo speco occluso, li avrebbe fatti ricostruire o sarebbe risalito sulla prima nave, diventando il primo eroe moderno, perso il paesaggio natio? Forse dall’Odissea sarebbe saltato subito nella Divina Commedia, non come peccatore di superbia, per la sua irrequietezza esistenziale, ma come vittima archetipica di un esilio dal paesaggio, così frequente nel moderno, ma allora tanto più tragico quanto più atteso e poi deluso.
In ogni caso il primo paesaggio terapeutico è quello che dura, che rimane riconoscibile: quello che ha una “sostenibilità sentimentale”.
Naturalmente la terapeutica durata del paesaggio non è carattere della pietra, non è riferita alle cose ma alle relazioni che progressivamente si intrecciano e man mano si stabiliscono con le cose, e che durano perché co-evolvono, assorbendo i cambiamenti delle stagioni vitali dell’una e dell’altra parte, dell’uomo e dell’ambiente.
Ma nel mito dell’eroe che ha costruito il proprio contesto, che ha fatto palazzo a partire dal letto nunziale e paesaggio a partire da una rada sicura, un ulivo a segnarla e una grotta amica agli dei locali, c’è anche un’altra fonte essenziale del benessere dell’abitare: del paesaggio ci si appropria.
Credo che questa “appropriazione” corrisponda al processo di “costruzione” di cui parla Heidegger, ponendolo in parallelo all’abitare, e che tanto noi architetti abbiamo strattonato a favore della fisica attività dell’erigere muri e metter tetti.
Il fisico costruire è una parte, e neppure la più importante, di questa appropriazione, che inoltre comprende un più vasto e profondo lavoro di costruzione culturale e psicologico, con il progressivo consolidamento di riconoscimenti e di simpatie.
Lungo l’Odissea l’eroe approda a una dozzina di spiagge simili alla petrosa Itaca, è ospite per mesi e anni in terre amiche e genti che lo vorrebbero trattenere, ma non si appropria di alcun luogo, come non si sposa ad alcuna donna. Nel mito si capisce che realisticamente il processo di appropriazione di persone e di terre è un lavoro complesso, poco ripetibile, che stabilisce lentamente e faticosamente relazioni sistemiche di lunga durata. E’ per questa fatica di costruzione, che si fa una volta sola, stabilendo il proprio regno d’isola e di moglie, che ben conosce e di cui vuole riguadagnare il prodotto, che Ulisse guarda al cambiamento come al tradimento.
Penso che uno dei malesseri del nostro moderno abitare sia il pervasivo senso di non avere patria, d’esser ospiti in paesaggi d’altri, e che questo malessere sia fortemente aggravato da un senso di impotenza, dato da una perdita di competenza a “far nostro” il paesaggio, a riconoscere olivi che segnano la rotta per il porto, nicchie dove raccogliersi in dialogo con i geni locali, a far letti e tetti per le nostre progenie. Come Ulisse peregriniamo per il mondo ma diversamente da Ulisse, soffriamo di una deprivazione: non abbiamo ferma l’idea di avere già una nostra propria patria, perché non l’abbiamo costruita, non abbiamo partecipato a stabilirne le essenziali relazioni paesistiche. Per tutta l’Odissea Ulisse esprime altre risorse, è uomo moderno che inventa e se la cava sempre, ma è eroe proprio per la dimensione quasi etica, direttrice in ogni situazione, dell’essere comunque re di un’isola, di padroneggiare un paesaggio da cui parte e a cui ritorna, che gli occupa la memoria e gli assegna comunque un’identità.
La potenza latente in tutta la saga dell’errare sta nel sapere cosa significa stare, avere una patria: è una competenza culturale che fonda la nostra civiltà: sapere come si fa ad abitare, averne sempre presenti i punti cardinali..
Nel nostro tempo questa competenza basica si affievolisce, soffriamo una violenta scomposizione sociale tra indigeni asserragliati in città inospitali e apolidi che le assediano, dove tutti comunque patiscono la sempre minore capacità a stabilire fruttuose relazioni paesistiche e la mancanza di luoghi di pacificazione.
Gli antichi investivano gran parte delle risorse comuni per consolidare la koinè tra gli uomini utilizzando in modo sostanziale anche il paesaggio: la testimonianza più alta è forse il teatro greco, scavato nel fianco del versante che guarda il mare, che raccoglie l’intera comunità, la suscita in riti di catarsi collettiva tenendola immersa in un paesaggio coinvolgente e raccolto ma anche sconfinato e potentemente espanso.
Per noi dunque, che viviamo un’epoca incapace di investire energie vitali su nuovi paesaggi (e su nuove koinè) , è massimamente terapeutico il paesaggio dove ancora si riconoscono queste competenze che derivano dall’abilità e dalla fatica depositata per farsi amico il genius loci. Sono luoghi e comunità dove crediamo di poter reimparare alcuni trucchi del mestiere di abitare:
- le parti da rispettare nel loro stato, a prescindere (come diceva Totò), perché essenziali per la caratterizzazione duratura degli interi luoghi. Sono le tanto amate cornici naturali, di mare, di bosco o di monte, i panorami che consentono di percepire continuamente l’antichissimo fascino dell’abitare sul bordo dell’inabitabile, che non dovrebbero essere appannaggio di pochi privilegiati, ma, come per il teatro greco, un bene collettivo fruito ordinariamente,
- le modifiche minime per addomesticare la natura con le cure e le regole per mantenere amichevole il rapporto nonostante il nostro intervento invasivo. La prima regola del giardiniere paradisiaco è proprio quella del massimo contenimento delle modifiche, che devono essere minime. Non solo per un’economia delle risorse e della fatica, come ci hanno insegnato gli antichi, ma per una sobrietà del costruire, una misura che sta implicita nella cifra di amicizia che vogliamo mantenere con la natura stessa: durano a lungo i rapporti in cui ciascuno sa stare al suo posto. Si possono trovare le tracce di queste culture della sobrietà nelle località di montagna non travolte dal turismo o dall’abbandono,
- l’avvedutezza della localizzazione; capacità di scelta ormai desueta, la cui mancanza è fonte di gran parte dei malesseri del moderno abitare senza amicizia per i luoghi. La perfetta morfogenesi dei paesaggi “umani”, innescata dalle localizzazioni antiche, oggi ci stupisce perchè fingiamo di non sapere la complessità di questo atto fondativo dell’abitare che da sempre richiede l’aiuto degli dei o della natura. Richiede un atto di umiltà e una richiesta di aiuto oltre il normale sapere: è un atto da sempre connesso al rapporto con il sovrumano, ma i cinesi tradizionali, più pratici di noi, che simboleggiamo tutto e consacriamo i nostri atti con semplici liturgie senza riscontri reali, ricorrono concretamente ad animali selvatici, che inseguono sinché questi non scelgono dove dormire, per individuare attraverso il loro potente istinto il sito di migliore fondazione dei nuovi insediamenti. Si possono trovare le tracce della “ordinaria” saggezza localizzativa divenuta modello insediativo in paesaggi ormai profondamente antropizzati, come le colline italiane, di Langa, di Montefeltro o di Chianti,
- le sagge pratiche di “omeopatia paesistica”, dove piccole dosi di sostanze simili ai veleni squilibranti aiutano a metabolizzare i cambiamenti ad essi dovuti. Sono i luoghi dove si è affrontato il nuovo evitando però ogni intervento sovvertitore dell’ordine precedente, tenendone i segni sotto l’egida del paesaggio più consolidato. Si possono trovare le tracce di queste pratiche, attraenti per la loro attenta relazione con le regole del contesto, nei centri storici rivitalizzati o negli sviluppi turistici di un secolo fa, in alcuni siti di villeggiatura montana,
- la funzione di segno esplicito, comprensibile entro un facile linguaggio naturale, che devono avere i manufatti, non in sé, ma secondo il ruolo che si vuole svolgano nel paesaggio, a partire dalla localizzazione. Distinguersi come segnali o viceversa star inseriti nel mucchio, senza emergere; avvicinare o viceversa allontanare, tener separato il dentro dal fuori (senza bisogno di recinti e steccati, buoni solo per gli animali): sono caratteri di appropriatezza segnica che decretano il ruolo e la effettiva godibilità dei monumenti, o semplicemente dei manufatti inseriti nel contesto, al di là delle foto sulle riviste e della firma dell’architetto.
Non si tratta quindi solo di avere a che fare con un paesaggio duraturo, ma di saper mantenere buoni rapporti con i luoghi nella durata, cioè di partecipare attivamente a quel processo di cambiamenti coevolutivi che le comunità insediate hanno insieme al loro paesaggio, nella costruzione del necessario per il proprio sviluppo e le proprie imprese. Nel nostro tempo, come abbiamo visto, questo equilibrio risulta difficile da ottenere: sembriamo incapaci di un’appropriazione amichevole e sostenibile dei rapporti con il territorio.
Il difficile coordinamento dei tempi e dei modi propri dei luoghi con quelli delle imprese di chi li frequenta è una delle fonti di maggiore contraddizione dell’abitare moderno.
La modernità è infatti incapace di darsi strategie di equilibrio con il contesto, e concepisce tale rapporto come inevitabilmente dialettico e oppositivo: il metro di valutazione delle relazioni tra sviluppo e paesaggio sono gli impatti.
Il paesaggio contemporaneo non presenta i segni di quello che sembrerebbe l’ovvio: una società che progredisce, nel vero senso del termine, non può che migliorare la valorizzazione delle proprie risorse, e non diminuirne l’efficacia per il proprio benessere. Invece i migliori paesaggi non sono, per noi moderni, quelli ricchi di segni della modernità, ma al contrario ci aiutano i paesaggi di segno più antico, dove il tempo conferma una pacificazione ormai consolidata. Nell’inseguire quei paesaggi di remota impronta, che ci aiutano a star bene, è come se ci fossimo arresi e dicessimo: non ci sappiamo fare, dobbiamo farci aiutare, ricorrendo ad una rendita da sfruttare, all’utilizzo delle fatiche pregresse degli avi che benevolmente danno i loro frutti di equilibrio duraturo.
Viceversa nel territorio che non reca i segni di un paesaggio pacificato, che mantiene aperto il contrasto tra sviluppo e identità, è diffuso un malessere profondo. Ne soffrono gli ospiti del gigantesco ambito di periferia, non città e non campagna, che copre ormai le nostre regioni metropolitane. Sono milioni che stanno in posti che non hanno costruito nè voluto, che non ne ricevono piacere nè socialità.
Ciascuno in queste condizioni ricorre a rimedi individuali, e questi peggiorano strutturalmente il malessere collettivo: da queste plaghe ci si allontana appena possibile, si riempiono le strade di auto e si vuotano i marciapiedi, si sosta solo in siti chiusi o si vivono vite notturne, perchè ormai deprivati di un senso del paesaggio da soddisfare: non è più al paesaggio che si affida la propria identità collettiva.
Un’interpretazione punitiva e colpevolizzante di questo stato di malessere indica il desiderio di sviluppo dell’uomo come peccato in sè, come fonte del contrasto inevitabile con il paesaggio duraturo (con la Natura, come sbrigativamente dicono gli ambientalisti).
Ma la storia della nostra civiltà induce a ritenere possibile una via di sviluppo che sia anche valorizzazione del paesaggio: se cerchiamo nelle nostre terre le tracce di un equilibrio gestito per secoli da uomini meno potenti e meno colti dei nostri contemporanei è perchè, a maggior ragione, possiamo pensare di poterlo ritrovare anche nel nostro tempo.
Sicuramente manchiamo di un buon diagnostico, che specifichi le condizioni odierne del nostro male, ma sappiamo che cosa avevano curato gli antichi, sappiamo almeno che i loro paesaggi sono stati luogo di convergenza positiva delle esigenze di sviluppo e di quelle di identità.
Sappiamo ad esempio che i paesaggi che “curano” questo malessere sono paesaggi vivi, sociali, formicolanti di attività e di costruzioni, che coinvolgono l’intorno, immaginati piuttosto nel Buon governo di Lorenzetti che non nei metafisici porticati di De Chirico. Sono relazioni positive che collettivamente si intrattengono con i luoghi, aiutate:
- da un comune e consolidato modello di percezione, che aiuta ad osservare le regole implicite per la loro efficace manutenzione,
- da una competenza dei costruttori ad accrescere e non a ridurre il valore del paesaggio in cui intervengono.
Sono paesaggi tessuti su territori, per intenderci, dove non ci si pone il problema se sia legittimo comprimere la libertà progettuale dettando regolamenti con norme per costruire bene; dove è chiaro a tutti che i crinali che si chiamano Bellosguardo non sono solo punti panoramici pregiati ma sono così chiamati anche per essere panorami ammirati; dove il normale prodotto del e per il lavoro è ritenuto valido solo se serve a star bene anche nel periodo di riposo, come si ottiene dai campi ben coltivati e dalle città ben costruite, dove l’architetto è felice di abitare nella casa che progetta.
Se ritroviamo tracce di questi comportamenti da Paradiso perduto solo nelle comunità statiche, che meno hanno subito le prepotenze della modernità, ciò non significa una scelta passatista, rivolta a Shangri-là irriproducibili, in estinzione nel nostro tempo.
Al contrario crediamo che sia possibile un modello moderno dell’abitare salutare, che si affermi come è avvenuto per la cura del corpo. Per il corpo, dopo secoli di incapacità a riscattarsi dal malessere, la cultura delle nuove generazioni, uscita dalla fame atavica e dalle carenze materiali, tende a dare importanza agli equilibri metabolici. Come per i cultori di comportamenti salutistici, così i nuovi comportamenti paesistici sono appropriati, sobri, rispettosi dei luoghi. Oggi solo alcuni li scelgono ma a breve vi saremo tutti costretti, volenti o nolenti, dalla riduzione delle risorse e dalla insostenibilità energetica e ambientale del nostro modo cicalante. E’ comunque importante dare senso a questi comportamenti non come una penitenza di digiuno ma come un modello terapeutico, lenitivo di malesseri profondi e introduttivo ad un più facile e meno faticoso rapporto tra ciascun abitante della terra e il contesto della propria vita.