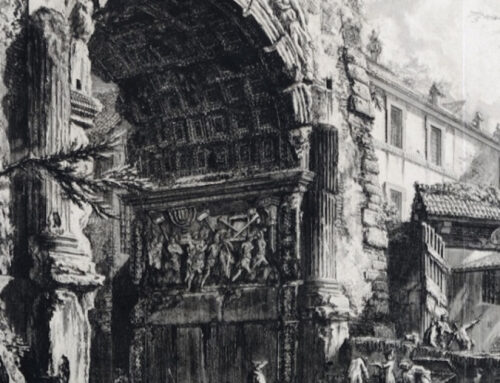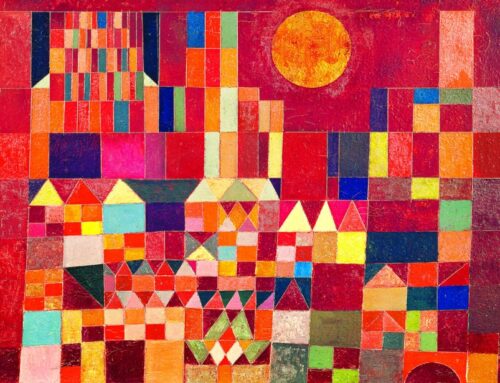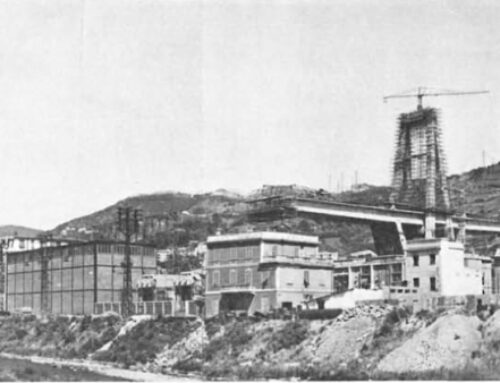I sistemi rurali interessano a chi governa il territorio per una pluralità di funzioni, che nel tempo assumono peso ed importanza diverse. Nelle regioni alpine all’importanza delle produzioni alimentari, fondamentali per un’economia di sussistenza, si è andata sostituendo l’importanza del sistema rurale per il ruolo di presidio, la manutenzione del suolo e gli equilibri dell’ecosistema e, successivamente, per il ruolo nella produzione e manutenzione del paesaggio, che assume un peso crescente nelle economie regionali montane, sempre più connesse al turismo. Solo recentemente i piani e i programmi per il governo del territorio hanno assegnato assi strategici di azioni e di attenzioni al paesaggio complessivo e in particolare a quello connesso alle pratiche rurali. Nel caso del recente PUP trentino emerge chiaramente il ruolo strutturale assegnato all’agricoltura proprio per connotare la diversità paesistica, attributo fondamentale per un territorio che si colloca sul mercato turistico come prodotto “multitasking”, da fruire con una pluralità di attenzioni (ai panorami, al gusto enogastronomico, agli itinerari variati, alla villeggiatura stanziale in contesti tradizionali). La diversità tra agricoltura di fondovalle, che disegna nuovi assetti paesistici connessi alla modernità e specializzazione delle modalità di coltivazione, e quella montana, che mantiene paesaggi tradizionali, può non indebolire ma anzi arricchire il senso complessivo del paesaggio trentino. Gli aspetti evolutivi e la pluralità degli ambiti paesistici possono migliorare il senso identitario e consentono di affrontare meglio di altre regioni le problematiche del consumo di suolo, degli impatti infrastrutturali e del rischio idrogeologico, proprio per l’attenzione e il ruolo assegnato ormai storicamente alle politiche agroforestali, facendole prevalere in molti casi a fronte di interessi di breve respiro e di trasformazioni con ricadute negative sull’assetto generale.
1. Le regole della fatica nell’agricoltura tradizionale in montagna
Le pratiche rurali impongono una considerazione del tempo diversa da quella che negli ultimi anni sta diventando dominante nelle nostre procedure decisionali, pubbliche e private. L’ossessione della velocità dalla mobilità e dalle comunicazioni ha contagiato i processi economici e amministrativi: nessuna azienda industriale fa piani a 5 o 10 anni, i mutui ventennali prendono l’aspetto di trappole che fanno paura sia alle banche che ai contraenti, i sindaci prendono decisioni solo se certamente spendibili elettoralmente nell’arco del loro mandato. D’altra parte la memoria storica dei fatti si perde nell’arco di pochi mesi (chi sa quando e perchè è cominciata la crisi? chi si ricorda ciò che si è detto e fatto per la crisi nell’arco dei primi due anni?). La cultura del continuo presente, senza considerazione per gli eventi passati e senza forza per strategie di medio lungo periodo futuro, è probabilmente l’effetto più difficile da affrontare delle trasformazioni socioeconomiche in corso.
Al contrario la cultura rurale, almeno in buona parte, continua a fondarsi su strategie lente e di lunga portata, su progetti che prendono riferimento come unità di misura temporale l’arco di vita degli alberi e la naturale stabilità dei mercati primari, legati all’alimentazione e alla costruzione delle case. Il fondamentale tempo lungo del sistema rurale ha consentito programmi potenti fatti propri da intere generazioni, capaci di strutturare interi territori, come è testimoniato dal ruolo che tuttora svolgono gli usi civici (l’esempio più conosciuto è la Magnifica comunità della Val di Fiemme). Per sottolineare l’importanza di questa diversità storica della cultura rurale, due notazioni sulla locuzione “usi civici”:
– si parla di usi e non di beni, cioè c’è un implicito riconoscimento del lavoro: il bene comune non è la proprietà della terra, ma l’uso che della terra si è fatto, che ora produce perché è stata curata: perchè c’è il lavoro di generazioni che l’ha resa utile. Questo aspetto di diritto fondato su una capacità d’uso e non su un’astratta proprietà è da tenere come bussola per orientarsi in dibattiti come quello che si agita oggi sull’acqua, in cui si distingue speciosamente l’uso dal bene….
– si definiscono civici, con una apparente contraddizione, visto che sono attività tipicamente rurali, frutto del lavoro contadino. Ma si deve tener conto che l’etimo di civico non si riferisce ad una parte derivata dalla (recente) separazione tra città e campagna, ma deriva da civitas, civiltà: quel patto che unisce i singoli non in legami di sangue ma in accordi di cultura e pratiche comuni. L’aggettivazione civico connessa ad un uso connota una gestione del lavoro produttivo codificata, regolata, oggetto di decisioni imprenditoriali controllate dalla comunità.
Il mondo rurale si dota di civitas con gli usi comuni, fa patti e definisce regole dello stesso tipo di quelle che sono state alla base della formazione delle città medioevali, fondate sul Comune, aggettivo sostantivato che usiamo ancora oggi, senza rendercene conto, per identificare l’unica istituzione territoriale che nessuno mette in discussione. La città medioevale è fondata su un patto di usi civici, che formano il Comune. Degli usi civici, che hanno tanta parte dell’identità storica italiana, oggi residuano quelli delle comunità rurali, come relitti galleggianti lungo un flusso di valori del tutto nuovo. Sono ancora intatti, non trasformati, soprattutto in montagna, dove l’opportunità di organizzarsi insieme di fronte all’avventura della produzione agricola è stato più forte e duratura: sono le gestioni dei pascoli in quota, dei boschi, delle acque canalizzate che derivano dai ghiacciai (quelle che a valle sono gestite dai consorzi, enti autonomi, staccati dalle comunità).
Dunque gli usi civici sono l’icona “magnifica” della cura della montagna che è implicita nelle pratiche rurali, quelle che hanno nel proprio DNA la sostenibilità dell’uso della risorsa, che curano l’equilibrio tra processi naturali e loro derivati utili per la comunità (presente e futura) e in questa cura rallentano o accelerano cicli, sfruttano microclimi, mantengono condizioni senza mai stravolgere i processi.
Questa attenzione storicamente si attua non perchè il contadino sia buono o ecologo, ma per un sano principio di economia dettato dalla fatica, che è massima in montagna. Quando hai compiuto l’impresa di terrazzare, scavare un canale per irrigare, e far fruttare un campo su un versante semiarido, cerchi di far rendere per molti anni quell’immane fatica collettiva; quando costruisci un ricovero per il bestiame al pascolo in quota, lo fai in modo che sia protetto dalla valanga e che lo si ritrovi utilizzabile le prossime estati. La fatica è un’ottima consigliera del fare e del mantenere (letteralmente: conservare con l’azione manuale), induce un rispetto implicito per il frutto del lavoro, proprio e di chi ci ha preceduto, e quindi per i criteri base dell’economia reale, cioè (etimologicamente) delle leggi che regolano la vita. Non solo, ma la fatica ha indotto a perseguire, nell’agricoltura tradizionale, regole il più possibile aderenti alle leggi cicliche della natura, che, adottate e indirizzate a fini produttivi, permettono sfruttamenti con il minimo di lavoro, come nel judo si fa cadere l’avversario accelerando appena un po’ il suo stesso slancio.
Da questa “economica” pratica dell’agricoltura tradizionale emerge una regola che non dovremmo mai dimenticare, nelle scelte di gestione complessiva del territorio: il grosso della fatica deve essere concentrato sull’impianto, sull’impresa iniziale che richiede investimenti straordinari e competenze eccezionali, con uno sforzo particolare dedicato però a minimizzare e rendere sostenibili i costi della gestione successiva. La drastica riduzione del tasso di fatica nelle opere rurali, per altro benemerito frutto delle tecnologie moderne, riduce però il senso implicito di sostenibilità e di accordo con la natura nella conduzione agricola; d’altra parte il dominio crescente dell’ideologia progressista, che ci spinge ad ottenere sempre di più dalle nostre attività, rompe l’adesione al tempo ciclico delle stagioni, alla ripetizione delle condizioni, e quindi demolisce l’utilizzo regolativo della memoria. L’agricoltura diventa una tecnica separata dalla regola insediativa su cui è fondato il sistema rurale, che invece è fatto di radicamento, di adesione alle condizioni locali, di accordi integenerazionali per assicurarsi i frutti di progetti su tempi lunghissimi, in cui i padri lavorano per i figli dei figli e le madri generano il più possibile per assicurar chances per il futuro dell’impresa famigliare e della comunità.
Non sembra servire più, nel lavoro rurale attuale, chiedersi perché i nostri nonni svolgevano una certa pratica in un certo periodo, oppure perché astenersi dal costruire in certi luoghi, oppure attendere il compimento di cicli vitali di piante ed animali prima di sfruttarli.
Risultato: i costi (sia monetari che ambientali: dell’energia, dei consumi idrici e chimici, della distribuzione e della conservazione dei prodotti) sono fuori controllo; la sostenibilità non è più un ingrediente implicito nel processo produttivo, ma solo un fastidioso criterio di rispetto di regole amministrative (vale per l’ambiente, ma anche per l’economia, essendo il reddito ormai largamente assegnato ai contributi comunitari). E tutto ciò a fronte di una ideologia della produttività, che ormai divora se stessa. Infatti le quantità prodotte non sono più correlate con il reddito: la produzione dell’azienda agricola alimentare, decuplicata rispetto a 50 anni fa, non mantiene più chi in azienda lavora, che ha bisogno del sostegno pubblico, ormai assistenziale.
2. La multifunzionalità come primo passo per un nuovo ruolo dell’agricoltura
L’apparente paradosso sopra tratteggiato, per cui nei tempi della crisi un intero settore produttivo viene sostenuto dalla mano pubblica senza prospettive di futura autonomia, si spiega solo con una strategia territoriale e di lungo periodo, non dichiarata ma profondamente coerente con il nuovo quadro generale di governo europeo: si scopre e si potenzia un ruolo dell’agricoltura, non solo e non tanto per la produzione alimentare, quanto per altre produzioni e servizi, a partire dal mantenere il territorio in efficienza.
Tuttavia il braccio operativo della strategia agricola europea, la PAC, non modifica radicalmente la struttura organizzativa delle direttive, che continuano ad essere incardinate solo su incentivi alle aziende agricole, senza coinvolgimento dei soggetti pubblici se non nella parte organizzativa e di controllo. La novità di questa nuova strategia si manifesta timidamente, con misure (alcune tra le tante) volte a favorire la multifunzionalità delle aziende e la disponibilità ad investire per la qualificazione ambientale delle loro modalità produttive. L’accento, nelle misure dei PSR e nei “lanci” pubblicistici, punta prevalentemente sugli aspetti economici della multifunzionalità: le prospettive di integrazione di reddito, la risposta alla richiesta delle nuove generazioni di lavoro non solo contadino ma esteso alla ricettività e alla fornitura di servizi, l’adeguamento progressivo ad una domanda di prestazioni non più solo legata a quantità ma anche a qualità e sostenibilità. Gli incentivi alla multifunzionalità delle aziende sono solo un primo segnale, che emerge nel mare magnum delle direttive PAC. L’obiettivo strategico di tenere insieme la sicurezza, la fruibilità, l’identità del territorio al tempo in cui i processi urbanizzativi non sono in grado di produrre altro che impronte insostenibili, rischi catastrofici, scempi dell’immagine paesistica, è ancora mescolato e contradditorio rispetto a quello sinora proclamato di massimizzazione e di specializzazione regionale delle produzioni alimentari. Ma nel momento in cui fosse dichiarata la priorità di una linea che promuove la più complessiva e strutturale funzionalità globale dell’agricoltura (come sembra stia per avvenire con il nuovo programma 2013-2020), si deve riorganizzare completamente il quadro dei valori in gioco.
Si deve arrivare ad azioni strategiche coordinate, nelle quali l’azienda agricola è incentivata non tanto a produrre di più, quanto invece a produrre migliorando al contempo le condizioni ambientali e paesistiche del contesto. Se si confermano gli indirizzi annunciati, nella fase iniziale si dovrebbe promuovere il nuovo ruolo dell’agricoltura in particolare nelle tipologie di ambiti territoriali che maggiormente risentono della crisi: nell’hinterland delle città, per contrastare l’incidenza dell’”impronta” ambientale urbana; in montagna e in generale nei contesti in via di abbandono, per contrastare il rischio per la sicurezza idrogeologica e il degrado paesistico.
E’ evidente che i nuovi indirizzi daranno luogo a linee d’azione che non possono essere confinate strettamente nelle politiche agricole strictu sensu, e che richiedono una complessa interazione tra incentivi per diversi settori produttivi: i servizi ambientali e di loisirs (in particolare nell’ambito periurbano), il turismo e i beni culturali (in particolare per i territori dotati di risorse paesistiche ma decentrati e poco industrializzati), e, in generale, la sicurezza idrogeologica.
Dunque necessariamente, con questi indirizzi, volge al termine il lungo periodo dell’isolazionismo della politica agricola europea, attuata in Italia in separatezza totale rispetto alle strategie di qualificazione ambientale e paesistica e di sviluppo locale, diversamente dalle modalità di attuazione adottate dai francesi o dai tedeschi. In Italia questo periodo trentennale ha prodotto gravi effetti indesiderati nella macchina gestionale: la sedimentazione di procedure per la concessione di incentivi senza verifica degli effetti, un allentamento del ruolo dirigente e di monitoraggio nei funzionari, una cultura aziendale priva di sperimentazioni e di attenzione alle innovazioni, e soprattutto una separazione, nella gestione della cosa pubblica, di tutto ciò che riguarda l’agricoltura, finanziata e amministrata da uffici praticamente indipendenti dalle strategie più complessive di governo del territorio.
Insomma sembra finalmente terminare, per l’agricoltura italiana, una stagione che sta dando risultati opposti a quelli, più remoti ma più esaltanti, degli usi civici, almeno per quanto riguarda lo sforzo comune di gestione della res publica. La prossima fase sarà cruciale per favorire la sperimentazione di procedure, pratiche e monitoraggi che rimettano al centro il ruolo e la responsabilità nella gestione del territorio che gli operatori in agricoltura, sia pubblici che privati, possono assumere, per la qualificazione dei rapporti con la natura, con il paesaggio, con lo sviluppo locale e il turismo.
Sarà importante aiutare i funzionari dei servizi per l’agricoltura, a gestire i fondi europei attraverso progetti integrati tra le proprie competenze e le altre di interesse territoriale. Sarà un processo lungo e complesso ma fondamentale, che si può attivare se si promuove, accanto alla multifunzionalità aziendale, l’intersettorialità nella programmazione e l’utilizzo multi-tasking degli incentivi per lo sviluppo locale.
3. Le potenzialità dell’agricoltura per il governo del territorio e lo sviluppo locale
D’altra parte l’agricoltura è strutturalmente connaturata alla cura del territorio, purché non diventi oggetto esclusivamente di processi di standardizzazione che rendono l’attività produttiva estranea alle specificità locali, come in una fabbrica. In quella dimensione, se incontrollata, l’agricoltura può generare impronte negative sul territorio addirittura peggiori di quelle dell’industria, perché diffuse e più difficilmente controllabili negli impatti, nella chimizzazione omogeneizzante dei prodotti e del suolo, nel consumo di risorse primarie, come l’acqua o lo strato fertile. Al contrario è insostituibile il ruolo dell’agricoltura che mette a frutto l’attenzione alle particolarità dei luoghi, in cui l’adeguamento alle condizioni ambientali è scelto e non più imposto dal criterio di minimizzazione della fatica. Si tratta di un processo basilare di valorizzazione paesistica, che oggi trova sponda nella crescente domanda di produzioni microregionali, anche di nicchia, nell’apprezzamento dei paesaggi tradizionali e delle identità locali. A rendere più facile il riconoscimento delle identità locali danno un contributo sostanziale sia le modalità di coltivazione che danno forma e riconoscibilità ai paesaggi agrari, (in sè o di contesto ai nuclei storici, beni culturali e alle emergenze naturalistiche) le produzioni enogastronomiche, caratterizzando nell’insieme brani territoriali spesso trascurati e inserendoli nel mercato fiorente del tempo libero, del loisirs e del gusto. Dunque l’agricoltura ha avuto ed ha un ruolo strutturale nello sviluppo locale di ambiti, a centinaia in Italia, molto articolati per storia e geografia, dove tradizionalmente la diversità paesistica è stata croce e delizia delle identità locali, spesso così frazionate da essere ai margini dei processi di crescita degli ultimi due secoli, ma oggi deposito immenso di risorse e di attrattività per il nuovo turismo culturale. Certo si tratta di processi lenti ad attivarsi, bisognosi di incentivi nella fase di avvio, quando mancano gli operatori innovativi e gli ambiti locali non hanno ancora raggiunto la visibilità e la notorietà che portano a flussi significativi di fruitori. Si tratta di dinamiche socioculturali che si svolgono con modalità simili, in buona parte, sia nell’hinterland periurbano delle grandi città sia nelle aree più periferiche delle province montane: in entrambi i casi esiste una domanda potenziale vastissima, e una base di risorse naturalistiche, paesistiche e culturali che è trascurata non solo per la banalizzazione dei processi urbanizzativi e per l’abbandono delle aree marginali (anche ai bordi delle città), ma anche per la standardizzazione dell’agricoltura, l’estraneità delle produzioni ai fruitori dei luoghi, l’oblio delle tradizionali culture dell’ospitalità e dell’integrazione che hanno caratterizzato il mondo rurale sino a 50 anni fa. Per questo gap da colmare, e per le potenzialità operative che strutturalmente hanno a disposizione, le aziende agricole sono oggi l’unico soggetto diffuso che possa contribuire ad una gestione qualitativa del territorio economicamente in modo sostenibile (cioè non a totale carico della mano pubblica, che non avrà fondi sufficienti, almeno nel prossimo decennio).
Ma, per cogliere le opportunità che possono emergere per lo sviluppo locale sfruttando la nuova domanda potenziale, non basta una generica disponibilità degli operatori agricoli ad impegnarsi nei settori della qualificazione ambientale e paesistica come nuova frontiera della multifunzionalità: occorre un soggetto di coordinamento intersettoriale che possa calibrare gli aspetti specifici, i luoghi, le modalità dove applicare queste energie e questi investimenti, in modo che risultino efficaci per i processi di valorizzazione, entrino in sinergia con le altre azioni di governo del territorio (le infrastrutture, la tutela ambientale, i servizi per il turismo e il tempo libero, ad esempio). Dunque occorrono due strumentazioni e soggetti complementari per avviare l’asse strategico della qualificazione territoriale attraverso l’agricoltura:
• incentivi a buone pratiche gestionali, che possono derivare da una buona applicazione della PAC ed essere affidati in larga misura alle aziende agricole che mostrano la capacità di attivarsi per gli obiettivi di qualificazione paesistica sopra tratteggiati, e di durare nel tempo in quella prospettiva, fino a smuovere l’inerzia iniziale di territori “addormentati”;
• piani strategici e di programmi integrati, assunti da enti territoriali animati da un quadro di obiettivi strategici condiviso dagli operatori, con capacità di gestione nel tempo della attuazione dei piani, di monitoraggio dei loro effetti, di adeguamento alle nuove esigenze o opportunità che vanno emergendo. Se è pensabile una applicazione innovativa della PAC nei prossimi PSR, che tenga conto del nuovo ruolo territoriale assegnato all’agricoltura, per il versante dei piani territoriali siamo in gravi difficoltà. La pianificazione territoriale soffre in Italia una situazione di contraddizione paralizzante: ci si è preoccupati di regolare ogni intervento trasformativo ma non si è mai curata l’effettiva gestione dei processi d’uso e di degrado ordinario. Oggi, in una crisi che riduce all’osso gli interventi ma aumenta gli usi impropri e il degrado, ci si trova consegnati ad un complesso disciplinare normativo pletorico e inefficace, come le grida seicentesche di manzoniana memoria, e per contro ad una poverissima strumentazione programmatoria, di incentivo e promozione della razionalità gestionale, l’unica in grado di contrastare il degrado: i rari casi di qualche efficienza sono settoriali ma privi di coordinamento e poco integrati per l’applicazione alla complessità del territorio.
La carenza di strumentazione emerge palesemente dove e quando i motori economici di sviluppo si imballano o entrano in crisi, per cui non bastano più le regole a frenare la pressione trasformatrice spontanea, come accade di fronte ai processi di abbandono, o nelle città in crisi, dove bisognerebbe disporre di incentivi per promuovere razionalizzazioni ed esperimenti innovativi per indicare le vie virtuose di sviluppo locale e le buone pratiche gestionali.
Solo recentemente alcuni piani territoriali (e il PUP trentino tra questi) hanno inserito qualche modalità per l’attuazione degli indirizzi secondo assi strategici e qualche attenzione ai processi gestionali, ma sempre in modo troppo timido rispetto ai due nodi principali: la programmazione di settore e i piani urbanistici locali. Il nodo della programmazione di settore è paradossale: più un ufficio di settore è efficiente e maggiore è l’autonomia acquisita nel tempo, tanto da dover difendere, “contro” gli altri servizi, le prestazioni del “proprio”, raggiunte con equilibri gestionali e di ripartizione dei fondi in una spietata lotta concorrenziale dentro lo stesso ente. Questo accade sistematicamente nelle amministrazioni più grandi e complesse, e a cascata si ripercuote verso le periferie. Quindi è minima la disponibilità reale (non quella a parole) dei servizi più efficienti a porsi in sinergia e collaborazione in programmi integrati territoriali, dove le competenze di ciascuno dovrebbero confluire in strategie complessive dell’amministrazione.
D’altra parte teoricamente il piano locale è il luogo della pianificazione dedicato alle interazioni tra le varie competenze di settore, che, funzionalmente divise alla scala d’area vasta, si devono necessariamente integrare nei siti dove per prossimità ed interferenza le varie funzioni possono risultare sinergiche o al contrario contrastanti. Come sappiamo i piani locali non rispondono a questo ruolo, ma si occupano solo marginalmente del coordinamento funzionale e dello sviluppo locale, disciplinando di fatto solo gli interventi edilizi e i processi urbanizzativi del costruito, trascurando quasi del tutto gli spazi aperti, in particolare quelli destinati all’agricoltura. Il piano locale finisce per essere uno dei tanti piani di settore, dedicato solo alle procedure urbanistiche e non all’attuazione coordinata del piano territoriale.
Per le situazioni sopra tratteggiate proprio chi si occupa di pianificazione negli ambiti periurbani o della montagna riconosce per primo l’urgenza di inserire le attività agricole tra gli strumenti di gestione complessiva del territorio, data l’importanza delle aree libere e dei paesaggi agrari in quei contesti. Ma questa necessità si scontra con una carenza degli strumenti a disposizione in Italia: solo in pochissime regioni o province i piani d’area vasta hanno inserito qualche indicazione sulle “vocazioni” del territorio destinato all’agricoltura, indirizzando così l’applicazione delle misure dei PSR; solo pochissimi piani regionali hanno individuato una dimensione intermedia, intercomunale, in cui porre operativamente le tematiche dello sviluppo locale, degli equilibri città-campagna, della sostenibilità dell’impronta urbana nell’ambiente e nel paesaggio.
Ben diversamente in altri paesi europei. In Francia ad esempio, i comuni aggregati in accordi di programma hanno redatto Plan de Pays: programmi strategici orientati allo sviluppo locale con particolare riguardo agli aspetti del paesaggio agrario, che costituiscono titolo prioritario per i finanziamenti statali o comunitari purché rappresentino un punto di convergenza concordato delle programmazioni dei diversi settori che si interessano di territorio: infrastrutture, turismo, agricoltura, tutela ambientale, costruzione urbanizzativa, distribuzione dei servizi, valorizzazione dei beni culturali etc.
Per quanto riguarda la strumentazione gestionale operativa, in Francia i comuni associati su base volontaria redigono i Gerplan, piani condivisi di gestione delle aree non urbanizzate, complementari ai piani urbanistici, che indicano le migliori localizzazioni e i termini per le qualificazioni paesistiche, per la mitigazione degli impatti dei bordi urbani e industriali o delle infrastrutture, per la bonifica di suoli esausti o maltrattati, per le parti da tutelare per la rete ambientale. Nei Gerplan le azioni disciplinari sono molto inferiori a quelle di promozione, concordando con gli operatori e i proprietari la localizzazione degli incentivi, delle perequazioni e dei progetti integrati che coinvolgono le attività agricole. Insomma, se si capisce l’importanza dell’agricoltura per la gestione del territorio, si devono attivare due processi di riforma dell’amministrazione pubblica, alla scala territoriale e a quella locale, rendendola capace di pianificazione integrata alla scala intermedia (ad esempio quella delle Comunità di valle, utilizzata come riferimento per l’attuazione del PUP), dove il ruolo dell’agricoltura si attesti fra le altre attività gestionali per il bene comune, poste al centro del piano, ben al di là dell’urbanistica e delle normative per costruire.
4. L’agricoltura per la diversità paesistica in montagna: il caso del PUP trentino
Da quanto detto in precedenza risulta evidente la necessità di invertire gli obiettivi della programmazione in agricoltura: dalla promozione di produzioni standardizzate all’incentivo per i contributi del settore alla diversità paesistica e produttiva. E’ necessaria ora una fase sperimentale, del tutto innovativa anche dal punto di vista tecnico e procedurale, per porre in pratica indirizzi per la qualificazione ambientale e paesistica diversificata, con monitoraggi e controlli, che consentano di evitare sprechi ed abusi e di misurare l’efficacia degli investimenti. Sarà il compito del nuovo PSR, ma la sperimentazione deve anche trovare riscontro nella pianificazione territoriale.
In Trentino l’occasione dei Piani di comunità di valle è assolutamente tempestiva in questa prospettiva: la legge e il PUP prevedono che una aggregazione di comuni (geograficamente e paesisticamente ben assortita) si doti di un piano strategico integrato, che dialoga con i diversi settori dell’amministrazione provinciale, ponendo sul banco le specificità del proprio territorio, le fragilità ambientali, le identità paesistiche, le prospettive di sviluppo locale sostenibile.
Nei Piani di comunità la diversità territoriale e paesistica è strutturalmente al centro dell’attenzione, e questo nuovo orizzonte è fondamentale per esplorare, a partire dal PUP, nella capacità dei vari settori operativi dell’amministrazione provinciale a fornire indicazioni e indirizzi “dedicati”. In particolare ci si può giovare di un apparato tecnico-amministrativo per la gestione delle produzioni rurali (agricoltura e foreste, comprendendo ovviamente l’allevamento) che in Trentino, forse sul solco della tradizione degli usi civici, ha mostrato una particolare attenzione per le grandi questioni territoriali che distinguono i vari ambiti provinciali. In particolare sarà utile approfondire localmente le dinamiche e le relazioni (interne ed esterne) dei due grandi sistemi rurali riconosciuti come caratterizzanti: quelli di montagna (forestale e di allevamento) e quelli dei fondovalle specializzati (legnose da frutto e da vite).
Il tema delle produzioni rurali montane è affrontato dalla Provincia di Trento con un approccio integrato che dovrebbe essere preso ad esempio per l’intero arco alpino: la tutela ambientale e la produttività del bosco sono da sempre parte di un’unica strategia di gestione che assicura la sicurezza del territorio, la qualità delle acque ma anche la capacità produttiva per l’edilizia e la produzione energetica. Non solo, ma il Settore Foreste si fa carico delle problematiche gestionali dei pascoli in quota e quindi partecipa con un ruolo importante alle strategie della filiera dell’allevamento. La ricerca di equilibri ecologico-produttivi della montagna è quindi al centro delle attenzioni di un ufficio provinciale unificato, e questo ha facilitato molto la gestione delle problematiche ambientali e per la sicurezza, e ugualmente potrebbe facilitare la nuova prospettiva di valorizzazione paesistica, promossa dal PUP ma tutta da costruire operativamente.
E’ chiaro che 40 anni di strategie agroforestali coerenti e inserite nel quadro di riferimento dei PUP 1967 e 1987 partecipano a determinare esse stesse un paesaggio che ha mantenuto i caratteri della tradizione e della sostenibilità più di quanto sarebbe avvenuto spontaneamente, in presenza di interessi individuali o di piccoli gruppi, che avessero trascurato l’effetto di insieme. Ma ciò che si può chiedere oggi, a chi gestisce il sistema rurale montano, è una nuova frontiera del rapporto con le attrezzature turistiche, della formazione più spinta di un sistema ibrido rurale e turistico, che assuma senza pudori inutili gli aspetti della modernità e dell’innovazione, dove opportuni, mantenendo però i caratteri identitari delle singole valli ed evolvendo con una propria specificità il paesaggio montano di ciascun sito, senza cedere a soluzioni prefabbricate nelle costruzioni e nelle modalità di conduzione delle aziende.
In questa ricerca di equilibri dinamici può essere preziosa l’esperienza che si va accumulando sull’altro fronte: quello dell’agricoltura specializzata della frutta e della vite. In quei contesti l’innovazione e la ricerca hanno dominato negli ultimi decenni generando non solo un’alta qualità di prodotti ma un vero e proprio nuovo paesaggio produttivo, con le sue luci e le sue ombre, che andrà valutato seriamente anche dal punto di vista ambientale, fruitivo ed identitario e non solo produttivistico.
La gestione dell’agricoltura di fondovalle ha certo il merito di aver valorizzato le produzioni rurali al punto da competere con gli usi urbani, di fatto partecipando a disegnare il nuovo paesaggio periurbano del fondovalle Adige, premendo perchè fossero definiti in modo concluso i bordi delle aree urbanizzate e in qualche caso studiando opportuni criteri di inserimento paesistico delle nuove tipologie di edifici produttivi. Proprio questi esperimenti, che hanno raggiunto in qualche caso il livello di buona pratica esemplare, dimostrano la potenzialità dell’agricoltura a partecipare da protagonista all’attuazione dei piani territoriali, soprattutto per gli aspetti paesistici. Ma tutto può rimanere senza esito in assenza di una procedura intersettoriale e condivisa di valutazione degli obiettivi di medio-lungo periodo e degli effetti attesi da ogni incentivo o promozione di intervento, che metta insieme i requisiti paesistici, di fruibilità turistica, di qualità ambientale con quelli produttivi, di efficienza aziendale e di sostenibilità economica delle pratiche agrarie.