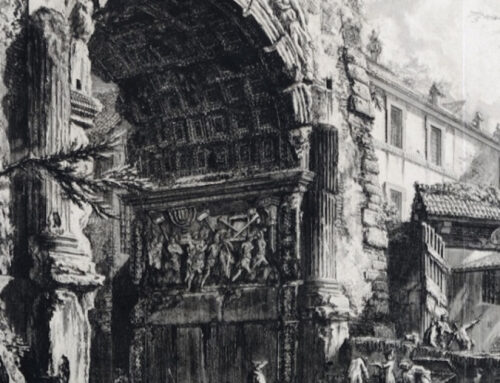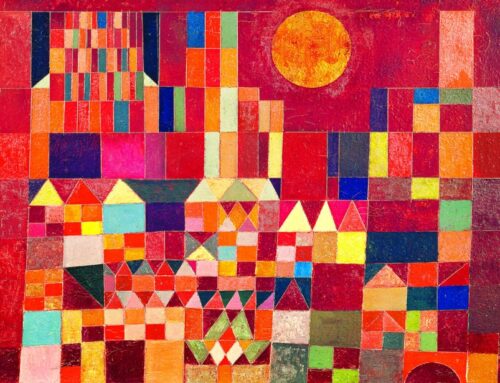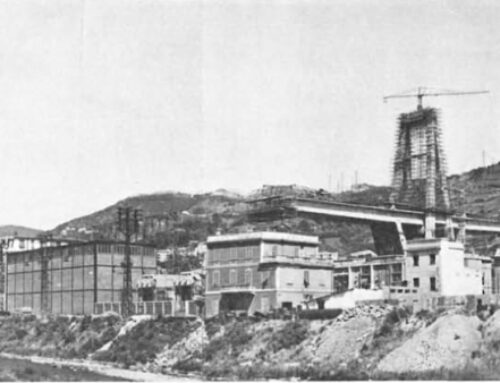Paolo Castelnovi, marzo 2013
Un progetto strategico per rianimare la politica
Come è stato possibile che si sia dato spazio ad un progetto di Italia postunitaria messo a punto da un gruppetto di intellettuali, nobili e borghesi di provincia, in cui si assegnava alla Cultura un compito politico fondamentale: costruire ex novo un senso inclusivo della cittadinanza e dell’identità nazionale? E soprattutto come è stato possibile che questo programma romantico e illuminista sia stato messo in pratica a tutto campo e con continuità per diversi decenni, con enormi investimenti di energia, organizzazione e risorse del giovane (e povero) stato laico, ottenendo consensi unanimi, da una parte con la scolarizzazione, dall’altra con la sensibilizzazione diffusa alla storia, alle arti e ai paesaggi?
E’ d’obbligo cercare risposte a queste domande oggi, di fronte ad agende programmatiche che prospettano, le migliori, con adeguate pratiche magiche e sacrifici rituali, la sopravvivenza: mangiare, dormire, guardare la tv. Oggi ci paiono marziani i nostri nonni che hanno strutturato in sistema operativo le loro strategie, assegnando in esse un ruolo principale alla Cultura, per generazioni, in un paese che allora aveva un Pil paragonabile al Terzo mondo di oggi.
Quella attuale è una condizione frutto di una depressione epocale: terminata la spinta ideale del grande progetto, che si era rinnovata nella fondazione repubblicana, prevalgono nel pubblico le pratiche gestionali di minima, che comportano naturalmente la destrutturazione, la frammentazione settoriale, e quindi la perdita del senso comune, dell’appartenenza a strategie di lungo periodo. La demolizione dell’originario progetto di Stato è prodotta dall’incuria e dall’accidia di due generazioni che non si sono più pensate come comunità progettante il bene comune. Ma il processo si è accelerato negli ultimi 10 anni, per la devastante retorica delle “riforme”, spesso consistenti in una maligna terapia: buttare l’acqua sporca rigorosamente con bambini annessi, attivando procedure abborracciate, parziali, senza gerarchia di valori di riferimento, “inconsapevoli” dei danni collaterali, ormai letali per la gestione d’insieme e per il senso positivo che si vorrebbe dare al termine “cambiamento”. E’ una deriva annunciata: spento l’entusiasmo nazionalista, spompato quello democratico, non abbiamo più scenari motivazionali. Ad essi ci siamo affidati per 4 o 5 generazioni come fossero un habitat naturale, dove han trovato spazio anche interessi settoriali o perversi, che sono stati naturalmente ordinati in uno schema generale (anche il fascismo ha prosperato in quel brodo di coltura). Quando si ritira il brodo di coltura, dove il nostro senso di res pubblica è cresciuto, emergono le rovine delle antiche strutture e le nuove catapecchie.
Così oggi la crisi riscuote dall’apatia, impone di rendersi conto sia dell’inadeguatezza ai tempi delle antiche architetture ideologiche sia della mortale debolezza delle recenti politiche di breve periodo. Diventa obbligatorio riaprire i termini di programmi, faticosi ma integrati, necessari per vincere attriti di avvio che credevamo superati. Dopo il brusco risveglio, siamo finalmente nelle condizioni psicologiche per mettere mano a una nuova strategia potente, che abbia una capacità di mobilitazione politica analoga alle illustri precedenti, e si imponga con alcuni punti innovativi ai primi posti delle agende post-Monti (e per l’Europa post-Merkel), che sono tanto intasate ai livelli funzionali, di azioni affannose per uscire dalle strette del trimestre, quanto sono vuote ai piani alti, come se si fosse perduta la chiave dell’ascensore panoramico, dove si guarda lontano. E la Cultura abita ai piani alti. La prima regola che dobbiamo imporci è di portare la Politica verso l’alto e non viceversa, di adeguare la Cultura ai ruoli da bag lady a cui viene collocata nella prassi delle attuali agende elettorali.
Nell’ultimo paio d’anni qualcuno, con uno sguardo da economista, si è accorto del buco nero provocato dalla latitanza della Cultura nei programmi politici, e si è impegnato in dichiarazioni e manifesti. In essi si ripropone la Cultura come attore protagonista capace di ridare profondità ed esprit de finesse ad una politica economica ossessionata dal doppio vincolo del bilancio bloccato e della mancanza di accumulazione per rinnovare le strategie di lungo periodo. In un paese che ha consumato le spinte innovatrici del sistema produttivo tradizionale, la Cultura sembra, ad uno sguardo un po’ lucido, il miglior agente per mettere a frutto le rendite di cui ancora disponiamo, il soggetto che può valorizzare in modo sostenibile il patrimonio immenso di beni comuni, materiali e immateriali, oggi per lo più maltrattati o almeno sottoutilizzati e comunque ideologicamente esclusi dai cicli vitali dell’economia.
Bisogna capire perché queste aperture rischiano, uscendo “a freddo”, di apparire come conigli usciti da cilindri, in mano a prestigiatori impegnati a distrarre dai veri problemi.
La diffidenza si spiega solo in parte con l’opposizione banale di chi non è capace di pensare alle risorse produttive non industriali. Ma d’altra parte è giustificata: chi conosce il plesso funzionale della Cultura è consapevole che la macchina culturale che lavora nella società è oggi ancora quella messa a punto nel tardo ‘800 e nella sua strumentalizzazione fascista. Quella macchina, vincente nella prima metà del ‘900, dopo mezzo secolo di disattenzione, ha perso la presa con i gangli vitali dei processi sociali: è come trovare nel granaio una vecchia Bugatti impolverata, splendida e che non si accende. E i pezzi di ricambio non si fanno più da 50 anni Fuor di metafora, non basta dirlo per rimettere la Cultura al centro delle strategie politiche: bisogna scontare un impegnativo progetto di recupero, di riconoscimento e riposizionamento delle risorse, sia vive che patrimoniali, di reimpianto delle strumentazioni adottandone di nuove se quelle vecchie sono ormai logorate dal cattivo utilizzo. Come in ogni recupero, si deve partire dalla valutazione del degrado. Ad uno sguardo comprensivo e non settoriale emergono platealmente gli effetti di sprechi strategici colossali. Ad esempio:
– lo scollamento tra gestione del patrimonio e istruzione: è ormai evidente lo scandalo della scuola (università compresa), ormai collocata tra i servizi sociali improduttivi, come la sanità o la sicurezza. Ma non serve misurare la distanza dagli standard europei nel settore dell’istruzione: bisogna rendersi conto della opportunità specificamente italiana per capire la dimensione della rovina. Si è perduta la chance, tutta italiana, di fare dell’istruzione l’accompagnamento permanente delle sensibilità e delle capacità d’innovazione della forma, la promozione sistematica di quel pensiero teorico e insieme operativo, artigianale, che abbiamo accumulato nei secoli e che ora chiamiamo creatività. La produzione di risorsa viva, che è il compito della scuola, non è più integrata con la risorsa patrimoniale, materiale o immateriale ma localizzata storicamente: anche per questo i prodotti, i giovani acculturati, diventano facilmente preda dei mercati globali, ridotti a generica forza lavoro intellettuale delocalizzabile;
– la gestione, capillarmente istituzionalizzata ma inefficace, del patrimonio materiale e immateriale: è ormai evidente una situazione sclerotizzata della mano pubblica, sempre più costosamente e inefficientemente impegnata a fermare e far la guardia più che a gestire i processi evolutivi, perdendo le sinergie possibili con competenze tradizionalmente diffuse nelle comunità. Senza mai chiarire i criteri valutativi e premiare le buone pratiche si è comunque tolta fiducia e non si è investito sul sapere locale, sul senso del paesaggio diffuso, che ben accompagnato potrebbe al contrario assicurare il prevalere di comportamenti rispettosi e attenti, come si verifica in molte regioni italiane ed europee. D’altra parte troppo poco si è investito nelle pratiche di mestiere, nella cultura della “bottega tecnica”, che ha per secoli sviluppato la capacità italiana di assorbire e rielaborare le innovazioni nelle produzioni ordinarie (dal canto al design, dalla scrittura alla cucina, dalla fisica pura ai muri a secco, dalle pratiche colturali alla filosofia della scienza).
Ma, nonostante la lunga malattia, i fondamentali ci sono ancora tutti, almeno per qualche anno. Non solo non è ancora del tutto perduta l’organicità eccezionale del patrimonio fisico, ma si può scommettere sulla possibilità di fondare sul patrimonio un importante segmento di lavoro produttivo, nonostante le mutazioni del clima culturale. Infatti per il patrimonio immateriale si può ancora contare, per un paio di lustri, sulla generazione di chi ha imparato senza particolare specializzazione a scrivere e cantare, a cucinare e pensare in astratto, a fare arredi e vestiti. E come lo ha imparato lo ha insegnato, o meglio lo avrebbe insegnato (e lo potrebbe insegnare) se il processo di acculturazione, quello di produzione e quello di gestione non si fossero così separati e irrigiditi. Quindi si può raccogliere la sfida di riattivare un processo storicamente virtuoso puntando principalmente su nuove modalità relazionali, promuovendo un’alleanza che rileghi il patrimonio italiano di sapere e di abitare sedimentato con la buona operatività ordinaria, con le pratiche economiche socialmente qualificate: l’impresa strategica, il lavoro competente, la ricerca diffusa, la formazione motivata, l’interazione multiculturale degli sguardi e delle pratiche. E’ importante lavorare sulle qualificazioni: non si tratta di patti strategici tra sapere e lavoro, tra capitale e innovazione, ma tra sapere indirizzato e dedicato e lavoro motivato e radicato, tra capitale sociale sito specifico e innovazione appropriata.
Queste relazioni rinnovate, quando sono felicemente rodate, nutrono (e si nutrono di) un clima di rispetto tra pubblico e privato, di una condivisione di scenario e di strategie di medio-lungo periodo, della fissazione di criteri certi per un equilibrio economico e di poteri, tra istituzioni e imprese, tra programmi organici e competenze locali, di monitoraggi e valutazioni in corso d’opera che consentano di mantenere rotte per viaggi di medio-lungo periodo, di selezionare e dare soddisfazione sia agli operatori che ai fruitori dei servizi.
Ma per ottenere una nicchia biologica dove queste relazioni possano prendere forza occorre ricomporre parti divise, vincere un’inerzia iniziale, e ciò può avvenire solo con un segno forte, una retorica politica che dia forma vigorosa a contenuti presenti ma ormai irriconoscibili e incapaci di riorganizzare le istituzioni, di introdurre pratiche valutative e di motivare entusiasmi e dedizione: una Strategia 2.0 per la Cultura italiana, da pensare potente proprio per la rinnovata unitarietà di arte, istruzione e pratiche diffuse.
La definizione formale di una Strategia per la Cultura è tanto più necessaria quanto più è auspicabile lo “scioglimento”, almeno parziale, del tema Cultura nelle politiche territoriali per lo sviluppo e la qualità della vita. Come il cacao, la Cultura al 100% è ostica per molti palati, ma opportunamente dosata produce le migliori delizie. Così è strategico l’apporto del sistema culturale sull’asfittico ricettario italiano per lo sviluppo locale, ma si deve ripensare a fondo, nell’organizzazione della Cultura in tutte le sue componenti, per riuscire ad innescare processi di valorizzazione effettivi: ad esempio preparando segmenti già organizzati di lavoro da applicare al patrimonio, o modelli operativi di produzioni “culturali” per il mercato del turismo e del benessere abitativo.
Ugualmente va declinata l’aggettivazione “culturale” delle “Industrie”, così cara alle strategie comunitarie: non solo il potenziamento delle attività organizzate dei media, del web o del divertimento, ma la valorizzazione del ruolo della componente culturale generale nelle competenze tecniche ed operative delle produzioni, nei settori d’eccellenza del “made in Italy”, dove appunto il riferimento culturale è un appeal di fondo, una sorta di stile facile a riprodursi in Italia quanto difficile fuori. E’ chiaro che sarà faticosa e disseminata di rovine eccellenti la conversione della Cultura, da protagonista assoluta e autoreferenziale di un microsettore sempre più eroso a strumento primario non solo per la qualità della vita ma anche per gran parte dei progetti nei settori strategici dello sviluppo del paese.
Sarà necessario, come sempre nelle più nobili imprese, assicurare una buona dose di umiltà per mettere la cultura al servizio delle altre strategie, per distinguere le parti utili a progetti più complessivi da quelle solo fini a se stesse. Non solo, ma si dovrà dimostrare la capacità di assumere quel ruolo strumentale senza particolari costi aggiuntivi nell’immediato rispetto a quanto già si intende spendere, complessivamente (cioè tra tutti i settori e i soggetti coinvolti) per gestire l’ordinario e promuovere lo sviluppo.
A questo proposito occorre inaugurare una stagione di strumentazioni tecniche ed operative per ovviare alla terribile incapacità di valutazione ponderata: i costi e i benefici degli investimenti, delle gestioni, delle ricadute di ogni strategia non sono in Italia oggetto di dibattito e neppure di indagine. Come ha mostrato la recente battaglia sulla “riforma” scolastica (o dei costi della “politica”), il tema dei costi, degli sprechi e delle rendite è oggetto di formulazioni retoriche, di costruzioni leggendarie ma non certo di una considerazione scientifica ed operativa, ma che tenga conto degli effetti indiretti, territoriali e di lungo periodo. Per la mano pubblica non esiste una cultura della valutazione che permetta di connettere le esperienze dirette con gli apparati statistici e contabili complessivi, e quindi di dare giudizi realistici sulle prestazioni effettive dei servizi e la loro gestione. E’ un’aporia che rischia di travolgere ogni strategia d’innovazione anche a proposito della Cultura e che farà naufragare tutte le rivendicazioni sacrosante dei vari manifesti, se si lascia campo libero alla contrapposizione ideologica tra Nemici degli Sprechi e Fautori del Diritto a…., fondata non su bilanci delle risorse e della loro produttività in termini prestazionali ma su dichiarazioni astratte.
Le priorità del programma strategico
Dunque la Cultura è stata assunta come oggetto di strategie primarie in tutte le fasi fondative del Paese: quella postunitaria (per amalgamare pezzi storicamente e geograficamente separati), quella fascista (per la rappresentazione di un’identità ideologica), quella repubblicana (per dare sostanza alla partecipazione collettiva allo sviluppo). In tutti i casi la Cultura è stata presentata come una macchina organicamente strutturata, ed ha assunto un ruolo riconosciuto come utile per le politiche del Paese. Oggi questo ruolo acquisito nello scenario politico si è perso, ma questa perdita non viene avvertita, immersa com’è nella più complessiva catastrofe del senso progettuale del futuro nell’opinione corrente e di ogni logica strategica di lungo periodo nei criteri adottati dai decisori. Oggi ci si accorge che la crisi è radicale, che bisogna riconquistare una credibilità per la speranza nel futuro e per le strategie politiche in generale, e nello smarrimento generale non si vede la risorsa sottoutilizzata a portata di mano: la Cultura. E questa cecità deriva in primo luogo dalla perdita di visibilità e di credibilità dei ruoli che la Cultura può svolgere, come struttura profonda del nostro sistema sociale, come macchina complessa che è già stata utilizzata altre volte. Bisogna ricollocare la Cultura nella valigetta degli attrezzi per le strategie sociali, discutere esplicitamente di criteri di utilità complessiva che, in qualsiasi programma strategico, devono guidare la scelta delle linee di azione e delle risorse necessarie per attivarle. E’ solo discutendo apertamente di utilità, rispondendo alla domanda: una volta fissato lo scopo, cosa mi serve per raggiungerlo?, che si stana la proposta culturale dall’autoreferenzialità, dalla dichiarazione moraleggiante della cultura come valore primario “a prescindere”. E’ solo discutendo delle strategie concrete per migliorare la qualità della vita e in esse del ruolo potenziale della Cultura che si può uscire dall’angolo in cui ci ha costretto il motto idiota la cultura non si mangia. Per ottenere una condivisione politica e un riconoscimento dei ruoli di servizio e di strumentalità per strategie complesse, bisogna agire anche sul versante comunicativo. Ad esempio nello scrivere i manifesti (malattia epidemica di stagione) dovremmo avere cura di distinguere la dichiarazione di proprietà “ontologiche” della Cultura, che ripete quasi sempre quanto definito in Costituzione, dalla proposta di azioni e strategie; dovremmo evitare lo sgradevole effetto di rivendicazione, del ricatto moralistico che richiede come “atto dovuto” una serie di sforzi complessi, del tutto disattesi negli ultimi 50 anni; dovremmo dare ordine di urgenza e di importanza alle sequenze di richieste, evidenziando le utilità che azioni pubbliche conseguenti a ciascuna di esse e la loro concatenazione operativa, compresa la sostenibilità economica. Se non lo facciamo, i nostri manifesti ottengono risultati comunicativi opposti al nostro primo obiettivo, che è attestare la funzione nodale della Cultura in un quadro di strategie politiche. E non basta dichiarare la volontà di un gruppo di intellettuali, bisogna dare una dimostrazione di fattibilità operativa, attraverso interventi esemplari. Per la Cultura bisogna innescare un processo di riabilitazione politica dello stesso ordine di quello che Slow food sta generando per l’agricoltura e l’universo rurale.
Non è facile, soprattutto perché oggi la Cultura non esiste nell’opinione comune e nelle pratiche gestionali degli ultimi 30 anni: è stata disintegrata in pezzi diversi e incomunicanti: la scuola, i beni culturali, le arti, le industrie di comunicazione, a loro volta fatti a pezzi (ciascun ordine scolastico, ciascuna arte, ciascun tipo di editoria etc.). Si deve recuperare la separatezza che è stata coltivata addirittura per le singole categorie di attività culturali (dalla danza alle biblioteche, dall’arte contemporanea al paesaggio), che ormai sono percepite sia da dentro che da fuori come settori isolati, che vengono messi in relazione (o piuttosto “in fila”) solo nei quadri generali di bilancio delle risorse. Ovviamente, presi uno per uno e non valutati nei loro effetti indotti ed integrati, i diversi settori di attività culturali sono inseriti nei capitoli di bilancio riguardanti le “spese improduttive” (le prime ad essere tagliate nelle spending review che oggi furoreggiano, almeno a parole).
Quindi l’azione più urgente è una potente e radicale strategia di integrazione tra gli aspetti del settore culturale e tra questi e gli altri settori di gestione e governo del sistema economico e sociale, per disporre di un teatro operativo in cui dimostrare la produttività e l’utilità sociale della Cultura messa a frutto nel suo insieme, come strumento complesso.
Questa linea di azione va accreditata ora, in piena crisi, per mostrare quanto di più si può fare a parità di risorse economiche e operative, se si integrano su nuovi programmi enti di settore, soggetti decisori, competenze ed energie. In molti casi non si tratta di introdurre innovazioni metodologiche sostanziali, ma di valorizzare e di dare finalmente priorità a processi operativi e gestionali di integrazione che spesso sono previsti nei progetti ma quasi mai sono attivati compiutamente, arenandosi nella gestione ordinaria a fronte di resistenze settoriali, di inefficienze degli aspetti di rete e di infrastruttura, di indisponibilità dei decisori e dei gestori al confronto e alla collaborazione.
Ma è proprio la potenzialità di superare questo storico handicap italiano che consente di pensare ad uno sviluppo rigoglioso dei programmi capaci di rendere sostenibili e strutturati i processi di integrazione. Infatti la rotta da seguire è la stessa se guardiamo a un orizzonte meno immediato e a obiettivi più radicali, dato che nella Cultura giace, sinora sottoutilizzata, l’unica vera riserva di energie e di risorse di cui il paese dispone, e la sua integrazione nei processi socioeconomici è l’unico programma di valorizzazione economica strutturale che sia a portata di mano in questa difficile situazione di contesto globale.
Il processo di integrazione che si prospetta è imponente e occuperà almeno un paio di lustri, ma è importante decifrare immediatamente le tipologie di situazioni concrete, individuare l’articolazione delle situazioni che si incontreranno, per poterle aggredire, studiando per ciascuna distinte linee di azione strategica. Si tratta di mettere a punto “stili” operativi e consolidare buone pratiche con esperimenti, patti cooperativi, modalità procedurali e percorsi da seguire diversificati, tenendo conto delle difficoltà da superare e della storia più o meno collaborativa di ciascun settore rispetto agli altri da coinvolgere. Si possono schematizzare tre situazioni-tipo:
A. relazioni intersettoriali macro, tra Cultura e altri settori di attività o di governo della res pubblica, abitualmente praticati in altri paesi europei e posti ordinariamente alla base dei programmi comunitari, ma in Italia non ancora riconosciuti come ambito di riferimento per pratiche e procedure sistematiche. Il ritardo è enorme e necessariamente si dovrà procedere per specifiche sperimentazioni. I tavoli più urgenti da mettere a punto sono quelli riguardanti le integrazioni intersettoriali, implicite nella programmazione comunitaria 2014/2020, che devono presentarsi come buone pratiche consolidate e fruttuose da utilizzare sistematicamente nei progetti concorrenti ai bandi dei prossimi anni.
E’ ormai chiara a tutti l’importanza di alcune relazioni strutturali, tra:
– patrimonio culturale e territorio, per inserire pienamente le risorse culturali (materiali e immateriali) nella programmazione dello sviluppo locale, facendo diventare pratica consolidata e sviluppare competenze riconosciute quanto sino ad oggi si è provato con esperimenti locali, di modesta rilevanza, per il turismo o il marketing territoriale. E’ il tema di integrazione di gran lunga più importante e potenzialmente fruttuoso, per l’emergere dell’interesse per il paesaggio, che sintetizza tutti gli aspetti che legano naturalmente cultura e luoghi, per la spontanea formazione di comunità di interessi no-profit legati all’identità dell’abitare, per la crisi che attraversa il governo del territorio (dagli enti intermedi come le province e le comunità montane alla pianificazione, tradita e sottovalutata). Occorre a livello centrale un riconoscimento dell’importanza strategica di questa integrazione ad esempio intervenendo sul Piano d’azione per la coesione, fondamentale per le relazioni dei progetti locali con la programmazione comunitaria, in cui il ruolo della Cultura per la qualificazione urbana e territoriale è sottotraccia ma non è mai esplicitato né è dotato di un’incisiva strumentazione operativa per collaborare con gli altri servizi e strumenti di sviluppo locale (vedi per questo i documenti di Milella). Occorre anche un servizio diffuso che metta in rete le esperienze disperse che si stanno svolgendo, spesso con molta buona volontà ma in modo isolato e poco sostenibile, e ne tragga esempi di buone pratiche, consenta confronti con esperienze di altri paesi europei. Attraverso questa rete si deve far circolare uno strumentario di innovazioni procedurali, normative e contrattuali, oltre che soluzioni progettuali, figure professionali e accordi pubblico-privato di nuova generazione per integrare operativamente gli aspetti culturali diffusi e i beni del patrimonio storico e paesistico con le altre risorse territoriali (in questa direzione è orientato il sito landscapefor.eu).
– attività culturali e produttività economiche, per ottenere una versione italiana adeguata alla strategia europea di valorizzazione degli aspetti industriali dei settori design, editoria multimediale, televideo, entertainment, considerati nel loro insieme come “la Cultura”. Certamente la risorsa di competenze e di capacità creative disponibile in Italia è eccezionale ma è piuttosto artigianale che industriale. D’altra parte nel mercato dell’alta qualità (il più adatto a dimensioni produttive modeste come le italiane) la componente formale e creativa, opportunamente coltivata e accompagnata, è materia prima fondamentale e inesauribile. La storia di settori come l’arredo o la moda mostrano le straordinarie potenzialità dell’invenzione e della sensibilità artistica plasmate su basi artigianali e applicate a produzioni industriali. Occorre a livello centrale una strategia forte, che destini a questa integrazione feconda una buona fetta delle risorse predisposte per le start-up innovative e per la riqualificazione produttiva di attività esistenti, non tentando di inseguire le industrie dei media, ma piuttosto indirizzando le capacità creative ed artistiche selezionate a qualificare attività con alta qualità di prodotto e tecnologia, anche ma non solo per i media. Occorre anche un’azione diffusa che formi le competenze necessarie per queste attività professionali, da una parte spingendo la scuola ad innovare profondamente nei modi e nei contenuti i percorsi formativi di ogni genere, inserendo la valorizzazione delle sensibilità formali in qualsiasi tipo di studio, oltre ad inventare nuovi percorsi di studio e di esperienza, le nuove “botteghe”, per dare spazio alla formazione professionalizzante di eccellenza. D’altra parte occorre stanare le ambizioni artistiche che animano gli innumerevoli partecipanti ad associazioni e club, selezionare duramente in modo da poter agevolare quelle che meritano e soprattutto sono disponibili a cimentarsi con un ruolo produttivo, in cui arte e artigianato siano potentemente intrecciati e predisposti al rapporto con le necessità produttive dell’industria.
– cultura diffusa e servizi per le qualità della vita, per migliorare l’efficacia delle prestazioni e contenere i costi in settori di governo della cosa pubblica che necessitano di urgenti ristrutturazioni, come la gestione della città e dei processi di inclusione sociale o i servizi per la salute e per l’assistenza. Si tratta di servizi impostati secondo criteri illuministici, in cui i cittadini sono solo utenti passivi, ai quali non è richiesta partecipazione, e che oggi sono ormai insostenibili per i costi crescenti delle gestioni separate e della distanza tra operatori (spesso non controllati nelle loro prestazioni) e fruitori (sempre meno responsabilizzati e sempre più rivendicativi). Se in Italia si è spenta (deliberatamente) una cultura della cooperazione pubblico-privato che ha dato frutti straordinari nel secolo a cavallo del 1900, una nuova generazione di esempi virtuosi di collaborazione, per lo più importati dall’Europa, mostra la potenziale sostenibilità e qualità dei servizi partecipati, come avviene in modo ormai diffuso nella gestione dei rifiuti o nel controllo e manutenzione dello spazio pubblico. Gli aspetti culturali ed identitari sono stati in Italia la risorsa fondamentale per avviare e mettere a regime processi di cooperazione nella gestione dei beni e dei servizi sentiti come comuni, ad esempio alla scala dei Comuni, delle Parrocchie, delle sezioni di partito, ma da 40 anni nessuna strategia è avviata per dare spazio a sperimentazioni e iniziative in questa direzione. Occorre al livello centrale sancire il ruolo strategico della relazione pubblico-privato per la gestione della cosa pubblica e promuoverla a partire dalle reti di presidi culturali: scuole, biblioteche, musei, imponendo una radicale innovazione nella loro gestione e trasformandoli in sedi dell’iniziativa locale in diretta connessione con le politiche comunali (si pensi ai Foyers ruraux in Francia o alle Public Library nei paesi anglosassoni). Per garantire la valorizzazione del termine “comune” (dei beni, dei servizi, degli enti stessi) ed evitare derive di appropriazione elitaria degli spazi di cooperazione pubblico-privato, la norma e la pratica devono assicurare che in ogni progetto siano rispettati requisiti fondamentali di inclusione e di accessibilità: per questi aspetti il modello di Libera è molto interessante. Occorre a livello diffuso promuovere e dare spazio ad una stagione di sperimentazione e ricerca che approfondisca il ruolo della Cultura nella salute e nella felicità delle relazioni intergenerazionali, sociali e identitarie, dell’uso degli spazi (urbani, rurali, naturali) e dei rapporti con il tempo (libero, occupato, consumato): ciò che è stato denominato welfare “culturally-driven”. E’ uno spazio politico già oggi formicolante di iniziative, quasi ovunque di breve respiro e molto frammentate, ma che potrebbero essere amalgamate e rese potenti da una “infrastruttura” culturale che ne legga le radici comuni: utilizzare gratuitamente il sapere di ciascuno per migliorare la qualità della vita degli altri. Il nuovo contenitore ideologico “Smart City” consente di ambientare nella tecnologia più avanzata le prove sinora svolte quasi in clandestinità e rigorosamente nello spazio assistenziale del volontariato, e quindi di aprire una nuova fase, organica e visibile, di queste attività potenzialmente importantissime per ogni strategia di integrazione effettiva.
B. relazioni intersettoriali innovative per il sistema istituzionale, ad oggi del tutto prive di “Genio pontieri”, cioè di competenze e procedure dedicate alla gestione di tavoli di lavoro intersettoriali comuni. Ad esempio
i. scuola/ gestione del patrimonio,
ii. gestione delle periferie e del territorio rurale/ produzioni artistiche,
iii. imprese produttive/ gestione del paesaggio.
E’ su queste relazioni innovative che si può contare per ritrovare equilibri di bilancio altrimenti impossibili. Si tratta di utilizzare “a scavalco” competenze e risorse patrimoniali, alzando complessivamente le prestazioni di ciascuno dei settori collaboranti e a parità di costi.
Sono risultati che possono essere perseguiti se, ad esempio: per i, si abilitano le scuole (dalle materne all’università) a compiti di gestione e valorizzazione del patrimonio diffuso, coinvolgendo in primo luogo il maltrattato corpo insegnante e gli studenti e le loro famiglie. In questo modo si ottiene una capillare distribuzione delle funzioni di controllo e gestione, un avvicinamento alle comunità locali del senso del patrimonio, ponendo la Scuola come soggetto intermedio tra Stato e Comuni, che garantisce per il primo la sostenibilità gestionale nella tutela, per i secondi una maggiore adesione, nell’uso del patrimonio, alle necessità e alle condizioni locali. Sono azioni che implementano direttamente l’efficacia dei compiti didattici della scuola e la consapevolezza del ruolo della cultura nella vita e nell’identità locale. Operativamente si possono utilizzare gli accordi del tipo “gestion partagée” francese e si convenzionano le scuole (che possono diventare il collettore e il coordinatore delle iniziative di volontariato locale e del III settore) con i fondi sinora (cioè prima dei vari tagli) utilizzati per le attività di controllo e autorizzazione ordinaria, riservando alle Soprintendenze i compiti di coordinamento e formazione degli insegnanti (fondamentali nella prima fase), di intervento nei casi gravi, di gestione degli investimenti. Accreditando a livello nazionale un’iniziativa del genere è facile prevedere un’opzione prioritaria delle Fondazioni e degli altri soggetti finanziatori del III settore nel finanziamento, a progetto, dei costi aggiuntivi nella fase di start up del sistema.
per ii, si utilizzano le produzioni artistiche (sia visual che performing) per la qualificazione territoriale, aprendo una stagione intensiva di attività e iniziative per assegnare valori di centralità riconosciuta a luoghi sinora trascurati e “difficili” (le periferie e la città diffusa delle aree metropolitane, le zone di decollo agrituristico, gli insediamenti con declino produttivo,…). La linea di azione strategica è già stata provata in Europa nei programmi Urban e Periferie delle scorse tornate di fondi comunitari, con esiti controversi e ad alta dissipazione, ma oggi si dovrebbero impostare con differenti requisiti:
– integrazione sistematica della linea di azione “arte-territorio” entro programmi di riqualificazione territoriale o di rigenerazione urbana, con formazione di soggetti gestori ad hoc, su base volontaristica e minimo costo,
– selezione sistematica dei “produttori d’arte”, individuati (e retribuiti) verificando un impegno ad un contributo permanente (di almeno 5 anni) secondo un programma che ne integra le prestazioni ed è a sua volta fortemente integrato a quello urbano o territoriale. In questo senso possono essere utilizzate le esperienze organizzative e progettuali che si stanno sviluppando nelle città candidate a Capitali della cultura europea, sempre tenendo conto del diverso contesto di applicazione (non tanto valorizzare luoghi già molto importanti, quanto rendere identitari “non-luoghi” o “luoghi perduti”).
per iii, si verifica sperimentalmente l’utilità del paesaggio come risorsa qualificante le attività produttive (non solo per il turismo ma anche per l’agricoltura e le produzioni industriali). E’ una linea strategica che fatica ad affermarsi perché incide su una relazione storicamente trascurata: sinora l’attività produttiva è stata pensata indipendentemente dai luoghi ed ha semmai raccolto la diffidenza dei soggetti di controllo: basti pensare all’obbligo di valutazione d’impatto, in cui si dà per scontato che ogni nuova attività nuoce in qualche misura al contesto.
Al contrario le (poche) imprese produttive che riconoscono al paesaggio il ruolo di mediatore culturale e di strumento identitario e partecipativo (come definito nella Convenzione europea), stanno considerando la convenienza ad intervenire per migliorare il senso del paesaggio dei luoghi di produzione, non solo per migliorare la qualità fruitiva del territorio, ma per l’accreditamento “culturale” dei prodotti e per il valore aggiunto (alla qualità della vita) del lavoro radicato in luoghi identitari. Sino ad ora la valutazione di convenienza a migliorare il senso del paesaggio ha fatto breccia quasi esclusivamente presso i produttori agricoli che si rendono conto di essere essi stessi produttori del paesaggio in cui lavorano, come insegna la grande strategia di Slow food. Ma ad essi si stanno avvicinando altri tipi di produttori: ad esempio i cavatori, e in prospettiva tutti quelli che hanno rapporti diretti con le materie prime derivanti direttamente dal territorio, per le quali lentamente l’attenzione si sta spostando dalle cose alle persone, e ci si rende conto che tra le materie prime stanno le competenze, le progettualità, il senso di comunità dei lavoratori radicati sul territorio. La sperimentazione di progetti ed investimenti sul senso del paesaggio passa per la consapevolezza del ruolo che ciascuna impresa svolge sul territorio, per cui va favorita ogni iniziativa di documentazione della storia aziendale, di contaminazione tra archivi e memorie “interne” e la storia del territorio, di riconoscimento dei processi di interazione tra competenze locali e capacità produttive: un tema che gli storici del territorio e del paesaggio stanno solo ora cominciando ad esplorare.
C. relazioni tra settori interni al tema Cultura.
La separatezza, tra i numerosi segmenti in cui si articola la produzione e la gestione dei servizi culturali, mina alle fondamenta la credibilità complessiva e la potenza della Cultura come categoria d’azione strategica. In molti casi, invece che lavorare per integrare obiettivi ed operatività ci si consuma ancora a discutere sulle false antitesi tra le solite categorie oggettuali (le coppie: ambiente/cultura, architettura/paesaggio, performing arts/beni storici …) e/o di procedura, (le coppie: conservazione-valorizzazione, territorializzazione-messa in rete, comunicazione-formazione, sperimentazione-partecipazione,…). E’ necessario un investimento concettuale, di filosofia generale della cultura, capace però di tradursi in politiche per mobilitare energie e procedure e promuovere azioni di integrazione interna, “di retroguardia” rispetto a quelle tratteggiate per i rapporti intersettoriali, ma fondamentali per poter sperimentare la forza operativa della Cultura nel suo insieme. Per riuscire a superare le querelles è comunque necessario uscire dal dibattito delle idee e dimostrare sperimentalmente l’efficacia operativa, la credibilità politica e la sostenibilità delle azioni che sfruttano l’integrazione tra segmenti di produzione o di servizio culturale. Anzi bisogna dare spazio agli interventi che sono basati proprio sull’energia di coppia generabile dalle false antitesi: ad esempio gli interventi che valorizzano contestualmente performing arts e beni storici (ad esempio nelle reti di residenze teatrali o di festival localizzati in siti d’eccellenza), o quelli che qualificano reciprocamente aspetti ambientali e aspetti culturali (ad esempio nella gestione di aree protette). Ma non si può pretendere che la forza per ristrutturare in modo organico e sinergico un settore frammentato derivi solo da energie interne: se ci fossero sarebbero già emerse. Quindi si deve anche in questo caso sviluppare una strategia di provocazioni esterne, provenienti da altri settori: ad esempio è opportuno che i programmi di qualificazione territoriale, rigenerazione urbana e sviluppo locale introducano, del settore cultura, solo linee di azione integrate, in cui sia obbligatorio proporre azioni sinergiche e almeno “di coppia”, (secondo le false antitesi sopra elencate). Anche nelle strategie di integrazione rispetto ai servizi e ai settori produttivi deve diventare privilegiato il progetto che presenta settori culturali integrati, documentando quanto nell’integrazione si migliorano le prestazioni attese, o si contengono i costi, o si ottengono ricadute positive sul territorio o sul funzionamento complessivo dei servizi. Ferme restando le specifiche modalità propositive delle sperimentazioni da avviare a seconda delle situazioni-tipo in cui ci si muove, in ogni caso non basta sdoganare il ruolo politico dei processi di integrazione nella gestione della cosa pubblica. Infatti linee di azione strategica per valorizzare il ruolo “utile” della Cultura come quelle appena tratteggiate possono essere attivate solo se intervengono gli input politici e amministrativi per nuovi criteri di priorità nelle agende dei decisori, facendo prevalere almeno due metodologie di integrazione, per la quali siamo in terribile ritardo e abbiamo prassi amministrative ancora disseminate di ostacoli e resistenze:
– la sussidiarietà tra progetti locali, sempre più spesso integrati, e strategie centrali, sinora rigorosamente di settore, sia a livello regionale che ministeriale. In generale gli enti di settore regionali o statali devono essere obbligati ad organizzarsi per appoggiare strutturalmente i Comuni (che a loro volta devono essere obbligati ad aggregarsi in ragione della dimensione dei progetti e dei temi gestionali). Infatti i Comuni sono l’unica istituzione costituzionalmente organizzata per integrare i settori di attività pubblica e gestirli nel loro insieme per soddisfare nelle sue infinite sfaccettature la comunità abitante (non a caso i sindaci sono le uniche figure politiche che hanno ancora credito presso i cittadini). Anche per i temi legati alla Cultura i Comuni sono le istituzioni che più facilmente possono aprire immediatamente ad esperimenti di integrazione intersettoriale e di dialogo con il III settore, ma non sono organizzati per affrontare gli aspetti di rete e le dimensioni territoriali d’area vasta, vitali per i programmi di sviluppo locale, di valorizzazione del paesaggio, di sostenibilità dei progetti sulle arti sopra tratteggiati. Per essi è necessaria la capacità di coordinamento assegnata costituzionalmente a Province e Regioni, che tuttavia non possono più essere suddivise in una pluralità di soggetti interlocutori, ma devono contribuire ai progetti integrati in modo, appunto, integrato tra le diverse direzioni operative, partecipando obbligatoriamente ad esempio a formare uffici di coordinamento partecipanti al progetto con una voce unica.
– la coprogettazione e cogestione tra enti e privati, in particolare i soggetti no-profit, sinora non dotate di affidabili procedure che ne assicurino la capacità operativa, la promozione del NPW (No profit work), la condivisione delle responsabilità e dei compiti, assegnando ai soggetti privati il massimo di gestione e riservando alla mano pubblica i compiti di infrastruttura generale (rete informativa, valutazione, verifica di performance etc.) e di investimento (manutenzione straordinaria del patrimonio, start up professionali etc.). Per i temi legati alla Cultura i rapporti tra soggetti pubblici e privati faticano ad aprire immediatamente ad esperimenti cogestione con il III settore, perché mancano normative che garantiscano le parti rispetto a responsabilità e a controlli, che riconoscano nelle convenzioni bilaterali i costi da sostenere e la titolarità degli affidamenti in modo trasparente (e congruo con le normative europee) ma fiduciario ed esterno alle procedure di appalto, che introducano il monitoraggio come pratica collaborativa e non solo di controllo.
Uno stile per comunicare
Non a caso si parla di ri-forme, poiché gli elementi distintivi di un progetto sono anche formali, di linguaggio. Per un programma strategico conta sia la chiarezza sui contenuti (l’importanza, la fattibilità, l’opportunità) che la loro appetibilità comunicativa. L’esposizione di una nuova strategia è infatti occasione per delineare il riferimento a criteri e gerarchie di valore diversi dai precedenti, nel senso concettuale prima ancora che politico o tecnico. Proprio per consentire un’applicazione vasta e l’innesco di una discussione aperta è importante lavorare sull’aspetto retorico della proposta, i termini e lo stile che si utilizzano, le regolarità, il metodo e il controllo logico che s’impone nei diversi passaggi. Nel caso di uno scenario strategico per la Cultura la nostra proposta potrà distinguersi per alcuni requisiti formali molto importanti, che ne possono costituire lo stile e la cifra riconoscibile per:
a. L’attenzione, posta nella descrizione di ogni linea di azione, a documentare contestualmente gli aspetti inerenti diversi livelli di elaborazione e le loro relazioni operative:
– politiche,
– programmi,
– progetti,
– procedure gestionali
Questa forma di esposizione risponde a un requisito di trasparenza politico-tecnica della proposta, per cui chi è interessato agli aspetti di strategia generale è rassicurato per la fattibilità e la sostenibilità dalle indicazioni progettuali e procedurali, e viceversa chi è operativo ed interessato alle pratiche è illuminato rispetto ai riferimenti più complessivi dei soggetti coinvolti e delle linee di azione che, in contemporanea, la strategia prevede di avviare per una politica complessiva di buon governo dei beni comuni.
b. La retorica di presentazione, che delinea gli assi strategici come organismi che traggono energia da coppie di forze già esistenti ma non messe in relazione dinamica, da segmenti operativi oggi separati o che addirittura si presumono antagonisti (cultura/mercato, pubblico/privato, tutela patrimonio/utilizzo etc.). Ciascun asse strategico ha un campo di azione intersettoriale, interessa almeno una coppia antinomica di atteggiamenti e competenze e coinvolge in ogni caso diversi soggetti (pubblici e privati) in cui ciascuno è posto in posizione di servizio all’altro. Questa forma di esposizione risponde a un postulato “etico” della proposta, per il quale l’integrazione fruttuosa può avvenire solo se ciascun segmento operativo si pone in termini di utilità relativa alle esigenze degli altri segmenti partecipanti al progetto.
c. La compresenza, in ogni linea strategica, di azioni di rete e di progetti locali, secondo il paradigma delle politiche glocal che comporta un’attenzione contemporanea ed appropriata sia al sistema delle relazioni aperte (nel nostro caso almeno europee) sia a quello delle integrazioni date da rapporti di prossimità e di coinvolgimento nelle gestioni territoriali.