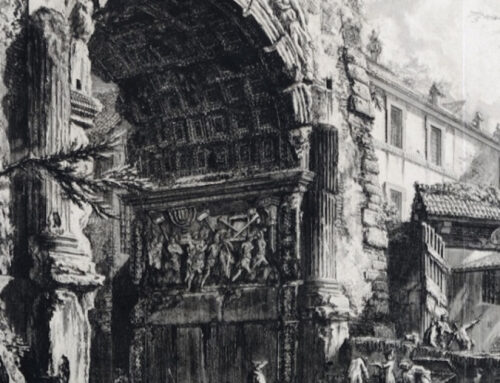Il paesaggio culturale, il paesaggio cognitivamente perfetto della Geo-grafia, il paesaggio narrativo a valenza estetica, la sfida dell’ineffabile, per una semiotica del paesaggio narrativo-estetico, il paesaggio mitico, la polisemia come valore.
Il paesaggio culturale
Nel trattare di “polisemia del paesaggio” prenderò spunto dalla nozione di paesaggio culturale, che, come noto, è stata resa di particolare attualità dalle recenti politiche dell’Unione Europea mirate proprio alla tutela e alla valorizzazione dei “paesaggi culturali”. Tra polisemia e cultura del paesaggio esiste infatti una stretta relazione, poiché l’ampiezza e l’eterogeneità dell’orizzonte polisemico del paesaggio dipendono appunto dalla cultura che di esso abbiamo.
Per il vero, nei documenti dell’Unione Europea che ho avuto modo di consultare (Conseil de l’Europe 1997), non esiste una definizione precisa di ‘paesaggio culturale’, anche se la si può indirettamente evincere dalla lettura dei documenti stessi. Dall’opposizione che in essi si fa tra ‘paesaggio naturale’ e ‘paesaggio culturale’ si può infatti dedurre che questo sarebbe il paesaggio formato dai segni impressi dall’uomo; paesaggio, dunque, inteso come espressione materiale della cultura della società che lo ha abitato e che lo abita; paesaggio che cesserebbe là dove quei segni, non essendo leggibili, lasciano il posto solo più ai segni della natura intatta, cioè appunto, al ‘paesaggio naturale’. In questa accezione il paesaggio culturale è riconducibile al concetto antropologico di “cultura materiale di una civiltà” (Cantoni 1963) o a quello storico di “documento-monumento” (Le Goff 1978) o di “memoria artificiale” (Leroi-Gourhan 1964-65).
È appena il caso di osservare che, se pure c’è stato un momento della storia in cui la cultura si è più energicamente dissociata dalla natura, nel mondo d’oggi, dove non vi è più luogo che non porti una qualche traccia delle azioni umane (non foss’altro per l’inquinamento globale che riguarda ormai ogni più remoto angolo dell’ecosfera), il confine tra natura e cultura è irrintracciabile. Forse in nessun’altra epoca la natura dove ancora abbiamo agito più debolmente è stata così carica di significato e di valore, divenendo, a tutti gli effetti, un imponente ‘fenomeno culturale’. È tuttavia evidente come qui la parola ‘culturale’ appaia in un significato diverso da quello precedente, non più come ‘cultura materiale’ in senso antropologico, ma come cultura in senso semiotico, secondo cui tutto il paesaggio, indipendentemente dal fatto che sia stato o che sia abitato è ‘segno’, è fenomeno di significazione e dunque cultura: il paesaggio si fa cultura nel momento stesso in cui lo si carica di significati. Se di paesaggio possiamo parlare è perché abbiamo trasformato la percezione di una porzione di mondo in un complesso di significati; e che cos’è la nostra cultura se non il complesso dei significati che attribuiamo al mondo?
Evidentemente le due definizioni non sono alternative, poiché quella semiotica comprende al suo interno quella antropologico-culturale: essa è più estensiva in quanto considera tutti i significati che la nostra cultura attribuisce ai possibili significanti del paesaggio e non solo i significati di quei segni che sono stati impressi dall’uomo sulla faccia della Terra.
Dovendo trattare di ‘polisemia’ del paesaggio, la definizione semiotica consente dunque di affrontare il tema nella sua massima estensione: quali sono i significati che la nostra cultura carica su quelle porzioni significanti di mondo che chiamiamo paesaggi?
Il paesaggio cognitivamente perfetto della Geo-grafia
“Il problema di ogni scienza è quello di far combaciare i mari del Sud, il loro blu immenso e frastagliato, con l’azzurra carta geografica dei Mari del Sud.” (Claudio Magris)
Credo che chiunque tenti di dare una risposta al quesito in ultimo posto non possa evitare di provare una sorta di vertigine dell’innumerevole. In effetti i significati che possiamo attribuire ad una porzione di mondo sono davvero innumerevoli: in primo luogo perché il complesso dell’informazione percettiva del mondo è infinitamente segmentabile e ogni segmentazione si fa luogo generativo di significati; in secondo luogo perché il complesso dei significati che attribuiamo al mondo, cioè quella che i semiologi chiamano la nostra Enciclopedia, è connesso da un reticolo che consente di passare da un significato ad un qualsiasi altro all’interno di un sistema di concatenamenti praticamente illimitato: “la conoscenza del mondo, o enciclopedica, è nella sua totalità, irrapresentabile (…), perché se si “apre” il significato fino ad includere tutte le conoscenze relative a un dato termine, la rappresentazione tende ad esplodere e divenire immaneggiabile.” (Violi 1997, 87). Nella trasformazione del mondo delle cose in un mondo di senso abbiamo il duplice problema di espandere il senso fino a dominare l’infinita segmentabilità dell’universo e al tempo stesso di mantenere il senso nei limiti della dominabilità.
In questo lavoro di espansione a fissione controllata dell’universo del senso la conoscenza scientifica svolge, nella cultura contemporanea, un ruolo imprescindibile: nessun dialogo sul senso del mondo sarà più possibile se non saprà fare i conti con il possibile della scienza, e ciò vale anche per il paesaggio: oggi noi qui non potremmo neppure cominciare un dialogo sul senso del paesaggio se non avessimo quella base culturale comune che ci deriva dalla Geo-grafia. Dunque è di lì che dobbiamo partire alla ricerca del senso del paesaggio.
Non è mia intenzione tentare una panoramica dello stato dell’arte delle varie geo-grafie, in primo luogo perché non ne sarei in grado, secondariamente perché è altro il problema su cui mi preme portare l’attenzione. Brevemente però vorrei osservare che la conoscenza scientifica in campo ambientale sta vivendo una stagione di vera e propria esplosione: un po’ a tutti i livelli si conducono ricerche, si costituiscono banche dati (la più moderna forma di memoria artificiale), si elaborano teorie, metodi e tecniche sempre più sofisticati e probabilmente questo è solo l’inizio di un’epoca che sa di non poter fare a meno di una conoscenza scientifica sempre più perfezionata dei processi che governano lo stato dell’ecosfera e di una tecnologia in grado di intervenire efficacemente su tali processi. Peraltro, quanto più rapido è lo sviluppo delle conoscenze tanto più rapido è il loro processo di obsolescenza: la nostra natura semiotica ci condanna al senso e alla sua provvisorietà.
Probabilmente il paradigma della complessità, che anche per la sua relativa novità ci affascina più di altri, è destinato ad avere riflessi, a provocare qualche ristrutturazione anche all’interno dell’universo semantico delle geo-grafie e, a seguito di queste ristrutturazioni, certi contenuti potranno essere messi in crisi e sostituiti da altri ritenuti più aderenti a quello che ci pare essere il senso del mondo. D’altra parte è proprio questo il processo di metamorfosi della conoscenza e mai come oggi questo processo si va accelerando.
Ecco dunque una parte fondamentale del senso del mondo e di ciò che provvisoriamente possiamo chiamare “paesaggio” e, visto che la ricerca scientifica è anche quella che conduce alla forma di conoscenza più perfetta, potremmo dire che il paesaggio scientifico delle geo-grafie è sinonimo di paesaggio cognitivamente perfetto; dando per scontato che, non essendo alla nostra portata la perfezione eterna, la perfezione che possiamo permetterci è solo quella effimera che riesce ad assaporare il successo di una stagione.
Il paesaggio geografico è dunque affetto da una polisemia in continua espansione a causa della crescente segmentazione e specializzazione del sapere, la quale richiede che l’unità del sapere venga ritrovata a nuovi livelli e alla luce di nuovi paradigmi; essa è, per ciò stesso, anche una forma di polisemia contraddistinta da un crescente grado di provvisorietà.
Vi è però un dato di fondo che accomuna le varie geografie e che ritroviamo nei loro atlanti, cioè nelle rappresentazioni che esse ci forniscono dei loro paesaggi. Quest’idea centrale è che “il tutto è connesso al tutto” e che “ogni cosa è parte di un sistema di sistemi”. Poi quale debba essere il modello di “sistema” è anch’esso definito solo provvisoriamente, così come è in continua discussione il modo di applicare questo modello a ciascuno degli aspetti del mondo, al modo in cui segmentarlo e pertinentizzarlo per farlo diventare sistema. Ma vi è pur sempre questa convinzione di fondo che accomuna le varie discipline scientifiche, per cui la realtà è un sistema di sistemi di cui il soggetto conoscente è parte integrante. Che poi questo modello sia una proprietà ontologica dell’Essere o sia semplicemente il modo più efficace per organizzare il senso che attribuiamo all’Essere è questione che possiamo lasciare agli appassionati di metafisica.
Detto questo, essendo noi animali sociali (come molti altri) dobbiamo accordarci sulle configurazioni del sistema e sulle sue leggi e ciò richiede negoziazione: pare cioè che la scoperta del sistema non possa avvenire se non come scoperta della comunità e se non sotto forma di cultura socialmente approvata e condivisa.
Vi è poi un altro aspetto che accomuna le varie discipline geo-grafiche: ciascuna di esse si occupa di un ben delimitato segmento dell’Universo Semantico Globale, sul quale esercita una sorta di dominio cognitivo e del cui arricchimento è responsabile. Condividere l’idea che l’universo sia un sistema di sistemi e occuparsi di un ben delimitato sistema aperto al resto dell’universo paiono costituire requisiti indispensabili per essere ammessi nel Consesso delle Discipline Geo-grafiche.
Di questo paesaggio polidisciplinare non possiamo fare a meno, sempre che non si voglia ripiombare in una cultura che non ci appartiene più e che può interessarci solo per capire ciò che siamo stati e da dove veniamo. Di questo paesaggio non possiamo fare a meno se vogliamo con successo modificare il paesaggio esistente in un paesaggio possibile e desiderabile: non vi è progetto di cambiamento che possa prescindere dal significato del paesaggio geo-grafico, perché esso è il significato che è stato costruito nel modo più efficiente per guidare l’azione pratica del nostro rapporto con il mondo.
Sorge però un interrogativo: il paesaggio geo-grafico esaurisce il senso possibile del paesaggio? O al di là del senso del paesaggio geografico ne esiste uno ulteriore, che non troviamo scritto e rappresentato nei suoi atlanti? Il problema è di capire che cosa si tralascia nel momento in cui ci si limita al senso cognitivamente perfetto delle geo-grafie, che guardano al mondo delle cose come ad un complesso sistema di sistemi.
Il paesaggio narrativo a valenza estetica
“Il paesaggio è qualcosa di simile all’archeologia: una stratificazione di segni in cui lentamente affondi, per lasciare emergere storie”(Claudio Magris)
Non v’è alcun dubbio che il paesaggio sia suscettibile di essere caricato di un senso ulteriore al di là di quello delle geo-grafie. È sufficiente che ci poniamo di fronte ad una porzione di superficie terrestre senza le finalità proprie della conoscenza scientifica o senza qualche scopo pratico, ma con la sola intenzione di osservare il paesaggio (una volta si sarebbe detto di “contemplarlo”), che immediatamente questo si carica di una molteplicità di significati solo in parte riconducibili a quelli degli atlanti geografici. Se lasciamo che la semiosi (cioè l’atto della significazione con cui, sulla base di un ‘codice’, associamo ‘significati’ a porzioni ‘significanti’ dell’informazione percettiva) si muova liberamente nel reticolo dell’Enciclopedia, senza preoccuparci di chiudere univocamente il senso; se ci lasciamo trasportare dalla semiosi anziché mantenerla (come si fa nella semiosi scientifica) nei binari di codici univocamente prestabiliti e tali da assicurare l’approdo semantico all’interno di ben delimitati settori sistemici dell’Enciclopedia; se in questo assecondare la spontaneità della semiosi annotiamo non solo i significati che possiamo esaurientemente esprimere nel linguaggio parlato, ma tutto ciò che possiamo far rientrare nel senso, anche quelli che ci appaiono come ‘effetti di senso’ difficilmente esprimibili a parole, come ad esempio le emozioni; allora ci predisponiamo davvero ad assaporare l’infinita potenzialità semantica del paesaggio.
Non dico che solo facendo funzionare in questo modo la semiosi si disveli il paesaggio, ma certo questa è la sensazione che personalmente ne abbiamo: solo così ciascuno di noi può assaporare, nella sua pienezza, il senso del proprio paesaggio. Quando ci atteggiamo in questo modo, il paesaggio, che è stato ed è lo spazio scenico del flusso del vissuto, ci restituisce il racconto avventuroso del vissuto. “Il paesaggio come teatro” dell’esistenza (Turri 1997), come scena che ha concorso a dar senso all’esistenza e a cui l’esistenza ha dato senso, diviene parte inscindibile del testo narrativo della nostra storia.
E qui possiamo subito osservare una differenza tra il paesaggio geo-grafico e questa forma narrativa di paesaggio. Il primo si presenta attraverso il linguaggio referenziale delle scienze, che ci consente di sapere tutto – o quasi – del paesaggio ecologico, di quello geologico, di quello politico, di quello socio-economico, di quello storico, ecc. e dei loro processi di morfogenesi; il secondo viceversa comunica attraverso “l’intricato stile incessante della realtà, con la sua punteggiatura di ironie, di sorprese, di presentimenti singolari come le sorprese” (Borges); il paesaggio narrativo parla attraverso il linguaggio evocativo della memoria e questa lo fa funzionare alla stregua di un testo ambiguo, dove i significati immediati delle cose, quelli soliti, quelli geografici, sono solo i significanti di significati altri, non univocamente definibili e che inducono a compiere passeggiate inferenziali all’interno della nostra Enciclopedia alla scoperta di un senso altro da cui non sono scindibili effetti emotivi.
Questo tipo di semiosi, che fa funzionare il paesaggio come un testo aperto, cioè a valenza estetica (Jakobson 1963, Eco 1962), sembra procedere in senso contrario a quello della semiosi scientifica delle varie discipline geo-grafiche: queste sono tutte intente a controllare la semiosi chiudendola in ben delimitati sottosistemi semantici; il paesaggio narrativo sembra aprire la semiosi all’intero Universo Semantico, senza assicurare approdi certi, univoci e oltretutto non contraddittori, anche perché di contraddizioni e di contrasti inestricabili è impastata la nostra storia.
Che fare di fronte a questo tipo di paesaggio di cui non possiamo negare l’esistenza, ma che è semanticamente inafferrabile e pericolosamente affetto da idiosincrasie? Credo che in sede di ricerca disciplinare possiamo assumere due possibili atteggiamenti:
i) questo paesaggio non ci interessa per alcuni buoni motivi. In primo luogo esso non ha le carte in regola per essere accolto nel Consesso delle Discipline Geografiche, sia perché le connessioni inferenziali della sua semiosi non si attengono alla disciplina del codice scientifico, sia perché, in conseguenza di ciò, il suo approdo semantico non è delimitabile ad un preciso sottosistema e pertanto risulta immaneggiabile a fini pratici (per di più esso comprende anche effetti di senso ineffabili come le emozioni: e che possiamo fare con le emozioni?). Esso è appunto un paesaggio tipicamente idiosincratico, specifico di ciascuno di noi e quindi può avere rilevanza solo nella sfera privata come forma personale di godimento del paesaggio, ma non può avere rilevanza pubblica;
ii) questo paesaggio ci interessa per alcuni buoni motivi. È vero che il senso a cui approda è basato su esperienze idiosincratiche, ma è anche vero che esse costituiscono un fenomeno di portata sociale, essendo il modo corrente di percepire e di vivere soggettivamente il paesaggio. È vero che l’approdo semantico è soggettivo, ma è anche vero che esso ha la pretesa di essere comunicato e di essere condiviso dall’universo dei soggetti, per il semplice fatto che, se ci fosse tolto questo paesaggio non potremmo neppure narrare ad altri la nostra storia: il paesaggio, in quanto spazio scenico del flusso del vissuto, è inscindibile dalla narrazione del vissuto; al di fuori del nostro paesaggio siamo degli inenarrabili. È vero che entrano in gioco effetti di senso indicibili come le emozioni dell’esperienza estetica, ma è anche vero che se trascurassimo questi effetti perderemmo una fetta del senso di cui l’uomo carica la propria esperienza del mondo (fetta peraltro non trascurabile, visto che è quel senso con il quale gioca la nostra facoltà di godere della bellezza e di produrre arte, e l’arte è un fenomeno di interesse pubblico).
Io capisco che le moderne geografie si siano preoccupate di dare fondamento ad un paesaggio altro rispetto a quello estetico; perché il loro obiettivo era di pervenire ad un paesaggio cognitivo che fosse utile per impadronirsi della Terra, per modificarla e per utilizzarla. Quello che non riesco a capire è perché questo paesaggio, cognitivamente perfetto per esercitare il dominio sul mondo, lo si sia voluto porre in alternativa a quello narrativo, che tra l’altro è anche l’unico in grado di farci assaporare la bellezza del paesaggio. Cioè lo capisco e lo motivo solo alla luce di quel mito che ha fatto del cognitivismo positivista un progetto di purificazione dell’Enciclopedia Universale e del suo Atlante. Semplicemente non mi sento di condividerlo, specialmente dal punto di vista dal quale professionalmente mi colloco in quanto architetto: se ha senso cercare di dare fondamento ad una disciplina che possa chiamarsi “Architettura del paesaggio”, allora certamente questa dovrà essere intrisa di cultura geografica (altrimenti il meno che ci possa capitare è di collocare le case in aree inondabili o franose), ma alla fine dovrà saper dare ragione di come il paesaggio funzioni come teatro e di come si possano progettare scene teatrali composte secondo le regole sintattiche di un’esistenza che non rinuncia alla bellezza (non rinuncia a fare arte con il paesaggio).
Per questo ritengo utile occuparsi di questo paesaggio strano, che ci consente di recuperare quel senso imperfetto del mondo che è irrimediabilmente contaminato dall’emozione, dall’estesis (Greimas 1987). Credo che se mi convincessi che l’unico paesaggio di cui ha senso occuparsi fosse quello del cognitivismo perfetto delle geo-grafie, mi verrebbe il dubbio di finire per assomigliare al calviniano Cavaliere Inesistente, tutto logica e calcolo e niente emozione, anch’esso personaggio dimezzato la cui altra metà è impersonata dal suo scudiero Gurdulù, tutto emotività immediata e niente significazione; l’uno e l’altro impossibilitati di connettere l’emotivo con il cognitivo, che è appunto la condizione indispensabile per godere del piacere estetico.
La sfida dell’ineffabile
Ciò di cui c’è bisogno è di un’analisi scientifica di quella forma strana di semiosi che trasforma il paesaggio in un testo narrativo a valenza estetica: c’è bisogno di uno sguardo semiotico sul punto di vista estetico. Essendo sin d’ora chiaro che, così facendo, non ci apprestiamo a dar luogo ad un’ennesima disciplina geo-grafica mirata a fondare la conoscenza di un qualche sottosistema del mondo; ciò che si tratta di capire è come il meccanismo della semiosi genera il più polisemico, il più aperto, il più ambiguo dei paesaggi: il paesaggio estetico per l’appunto.
Questo tipo di indagine è complicato dal fatto che il paesaggio estetico ci costringe a dilatare la nozione di senso fino a comprendere quegli effetti di senso che assumono la forma di un’ineffabile emozione (o, come diceva Greimas, di una “presa estesica”); ma anche l’ineffabile pone al semiologo la sfida di essere spiegato per l’appunto nella sua natura di effetto di senso, cioè di prodotto della semiosi.
È appena il caso di osservare la differenza di impostazione tra una analisi semiotica del fenomeno estetico e quella riflessione filosofica che ha improntato di sé l’estetica del paesaggio, in particolare nel contesto della cultura italiana. Mi riferisco all’elaborazione, pure importante, di Rosario Assunto, che ha protratto, ben al di là di quanto i tempi avrebbero consigliato, una riflessione in chiave estetico-romantica. In questo tipo di Estetica filosofica non si mira ad esaminare la struttura semiotica del testo e le ragioni per cui essa può esercitare una funzione estetica:[1] l’estetico è sostanzialmente indicibile, dipendendo esso da quella facoltà misteriosa che è l’intuizione[2]. Rinunciando a spiegare il funzionamento semiotico del testo estetico, questa Estetica finisce per incentrarsi soprattutto sulla costruzione di un codice della sensibilità, per cui, ad esempio, di fronte allo spettacolo infinito delle montagne si deve provare il senso del ‘Sublime’, che è un certo stato dell’anima che ci si premura di descrivere. Là dove questa Estetica cerca una motivazione di fondo sulla esteticità del paesaggio, con mossa tipicamente romantica, si appella al mito e ai suoi simboli, e quale mito è in questo caso più pregnante di quello della Terra Promessa e dell’Eden perduto (Assunto 1984)?
Dieci anni prima che Assunto pubblicasse il suo “Il paesaggio e l’estetica” (1973), Roman Jakobson pubblicava gli “Essais de linguistique générale”. I “Collected Papers” di Peirce, opera fondamentale del pensiero semiotico, sono di quarant’anni precedenti. Credo vi sia bisogno, anche nel campo della riflessione sul paesaggio, di un aggiornamento scientifico che cerchi di mettere a frutto gli strumenti su cui si basa, ormai da qualche tempo, l’analisi del testo estetico nel campo delle lettere come in quello delle arti figurative (Corrain, Valenti 1991).
Forse sbaglierò ma mi sono fatto l’idea che il rifiuto, a volte aspro, di porsi il problema dell’esteticità del paesaggio dipenda dal persistere di una vecchia concezione dell’estetico (quando non addirittura di una concezione volgare per cui la semiosi estetica viene ridotta ad un semplice giudizio sulla bellezza o la bruttezza delle cose) e dalla incapacità di fare i conti con il suo meccanismo cognitivamente imperfetto.
[1] “Tipico delle estetiche romantiche è descrivere l’effetto che l’opera d’arte produce, non il modo in cui lo produce. L’estetica romantica non mette a nudo l’artificio, come avrebbero detto i formalisti russi, ma racconta l’esperienza di chi soggiace al fascino dell’artificio.” (Eco 1984, 221).
[2] In proposito si può vedere: “Croce, l’intuizione e il guazzabuglio”, Appendice 2 a Kant e l’ornitorinco(Eco 1997, 375-387).
Per una semiotica del paesaggio narrativo-estetico
Se scegliessimo di interpretare il paesaggio attraverso i codici delle discipline geografiche, non avremmo alcun bisogno di transitare attraverso la semiotica: basterebbe conoscere quei codici e addestrarsi al loro corretto uso. Ma se ci ponessimo il problema di capire come sia possibile che l’informazione percettiva del mondo si trasformi in testo narrativo a valenza estetica, se fossimo cioè interessati a capire come sia possibile che un paesaggio si carichi di quell’effetto di senso che in modo molto approssimativo indichiamo con la parola “bellezza”, allora non troveremmo, al momento, alcun codice altrettanto ben confezionato e pronto per l’uso. La struttura e il funzionamento di questo complesso e aleatorio codice comportano un’indagine su quella facoltà strana che è la semiosi narrativo-estetica: la semiotica potremmo non nominarla mai, ma dobbiamo comunque sapere che il lavoro da compiere è di tipo semiotico. Come possiamo, dunque, impostare uno studio semiotico del paesaggio in modo tale che ci faccia capire il suo funzionamento estetico?
Quella della semiotica è un’ottica ostica, perché contrasta con la nostra abituale percezione del mondo, o meglio, con la sensazione che noi abbiamo di essa: là dove noi vediamo oggetti, cose, là dove percepiamo odori, suoni, la semiotica vede l’operare della semiosi. Noi percepiamo le cose e al tempo stesso nutriamo nei confronti della nostra percezione una sorta di fiducia cieca sul fatto che essa ci riveli la natura stessa delle cose. Tutte le persone dotate di facoltà percettive normali percepiscono le cose allo stesso modo; dunque le cose sono come noi le percepiamo, la percezione è oggettiva, perché ci offre le cose del mondo così come esse sono. Cosa c’è dunque di più oggettivo del “paesaggio percettivo”, del “paesaggio visivo”? Quando parliamo di percezione, comunemente pensiamo all’informazione che ci proviene dallo stimolo percettivo, per cui la nostra percezione visiva non sarebbe molto dissimile da quella di una macchina fotografica. La semiotica mette in crisi questa nostra “fede percettiva” (Merleau-Ponty 1964). Per la semiotica l’informazione dello stimolo è solo la materia prima su cui opera la semiosi percettiva, ed essa opera attraverso un lavoro di selezione che coglie solo l’informazione significante tralasciando quella non significante, dove la prima è solo quella che corrisponde ai significati che noi siamo abituati ad assegnare alle cose: noi ‘percepiamo’ solo ciò che risponde alle nostre attese di significazione. Percepire vuol dire significare e la capacità di significare dipende dal senso che alberga nella semiosfera della nostra Enciclopedia (Lotman 1985). L’informazione dello stimolo che non riesce a farsi significante non entra nella nostra semiosfera e si perde nel nulla. Il paesaggio che vediamo è solo quello che siamo in grado di raccontare: quanti paesaggi abbiamo perduto perché non li abbiamo osservati per raccontarli?
Come diceva Merleau-Ponty, “è vero che il mondo è ciò che noi vediamo, ed è altresì vero che nondimeno dobbiamo imparare a vederlo” (1964, 32), e poiché la visione è semiosi e questa conduce a significati che mutano al mutare della nostra Enciclopedia, possiamo affermare che non smettiamo mai di imparare a vederlo.
Spesso si sente dire che il giudizio estetico è soggettivo (il che sarebbe già di per sé un difetto), peccato però che la soggettività operi ben prima che il giudizio estetico possa essere profferito; essa rende ‘difettoso’ l’atto stesso della percezione, poiché non vi è nulla di più soggettivo dello sguardo e dell’ascolto (Barthes 1977).
Alla luce di queste considerazioni possiamo, da subito sgombrare il campo da un paesaggio inesistente, che alberga nella pesaggistica contemporanea: quel “paesaggio visivo o percettivo” che è figlio della “fede percettiva”. Che cos’è il “paesaggio visivo”? È ciò che noi vediamo. E che cosa vediamo? Ciò che ci offre la nostra visione… Se vogliamo uscire da questo circolo vizioso, dobbiamo cominciare a ‘nominare’ le cose che vediamo, ma nominare è appunto assegnare significati ad una porzione dello stimolo percettivo: noi vediamo solo ciò che siamo in grado di trasformare in senso. La percezione la sentiamo così intimamente fusa con la semiosi che non abbiamo più la capacità di distinguere tra ‘percezione come stimolazione’ (ciò che avviene sulla retina come sulla pellicola) e ‘percezione come significazione’ (ciò che ci consente di parlare di quello che vediamo), per cui il significato ci appare come qualcosa di connaturato con il mondo, mentre è solo il senso che noi gli diamo e della cui provvisorietà abbiamo ampiamente parlato.
Non concordo sulla fecondità di definizioni che sono frutto di un inganno dell’abitudine; le nozioni di “paesaggio visivo” e di “paesaggio percettivo” dovrebbero essere espulse dal lessico della paesaggistica, perché il non senso non può essere fecondo; può solo essere la sterile premessa su cui fondare un autoinganno, a meno che l’analisi sul paesaggio visivo venga portata fino al punto di prendere piena coscienza di quel confine che divide il visibile dall’invisibile; ma questo ci riporta appunto ad un’indagine sulla semiosi percettiva, sul suo funzionamento, sulle strutture che la reggono e sui suoi possibili approdi semantici.
Per inciso possiamo osservare come il tema sia di grande attualità: non è un caso che, dopo “Il trattato di semiotica generale” dove la percezione era solo marginalmente trattata, Umberto Eco abbia sentito il bisogno di scrivere “Kant e l’ornitorinco”, in gran parte dedicato ad un’indagine sulla semiosi percettiva e su come essa trasformi lo stimolo in segno. Ma potremmo riferirci alle ricerche nel campo delle scienze cognitive o dell’intelligenza artificiale. Per rimanere alla semiotica, si potrebbe indicare il filone greimasiano della ‘semiotica generativa’ là dove fa i conti con il momento sorgente del senso, dove il linguaggio si scinde dalla sensorialità, dove gli effetti di senso, che coinvolgono gli strati profondi del “timico”, si trasformano in significati comunicabili attraverso quella sintassi di superficie che è propria del linguaggio (Greimas 1970).
Non è qui possibile sviluppare, pur nelle sue linee generali, quella che potremmo definire una grammatica del paesaggio narrativo-estetico, e mi trovo per ciò costretto a rinviare ad altri miei lavori (Socco 1996, 1998).
Vorrei però accennare ad un aspetto importante che una teoria semiotica del paesaggio narrativo-estetico deve affrontare: il formato base del testo paesaggistico. La semiotica, lo abbiamo visto, tende a ridurre ogni cosa a ‘sistema di segni’, e poiché il modello più evoluto di sistema di segni è il testonarrativo, la parola “testo” ha finito per diventare sinonimo di qualsivoglia sistema di segni, come può esserlo un dipinto, un componimento musicale o anche una porzione di mondo. Ovviamente una cosa è un testo narrativo, che è una struttura sequenziale di significanti sintatticamente congegnata per comunicare dei significati, e altra cosa è, ad esempio, un luogo fatto di cose disposte nello spazio senza una intenzionalità comunicativa. Per cui si pone il problema di una sua messa in formato in modo conforme a quanto avviene nella semiosi. In altri termini si tratta di capire come la semiosi strutturi l’informazione percettiva dello spazio in modo tale da poterla tradurre in un testo narrativo a valenza estetica. Su questo aspetto mi pare che la metafora che Turri ci propone del “paesaggio come teatro” sia ben di più di una metafora: sia cioè il modello della struttura testuale. Per il vero, nella concezione di Turri il “teatro” compare in un significato più ampio e ricco di quello in cui intendo utilizzarlo. Per Turri il paesaggio-teatro è il luogo dove noi siamo attori e spettatori della recita che è la nostra esistenza e, al tempo stesso, siamo i formatori della scena che ospita la recita. Io recupero questo modello in una accezione più ristretta di spazio scenico che costituisce il contesto ineliminabile di ogni oggetto e di ogni azione in quanto segni.
Questo concetto di ‘scena-contesto di un segno’ lo ritroviamo nella semiotica là dove fa i conti con la forma dell’Enciclopedia. Poiché i significati che noi attribuiamo al mondo sono tra loro relazionati da una struttura, il problema di ogni teoria semantica, cioè del sistema dei significati, è quello di individuare la forma di tale struttura.
Nelle teorie semantiche si tende a distinguere tra una struttura in forma di Dizionario e una in forma di Enciclopedia (Eco 1984). Il Dizionario riguarderebbe “l’insieme circoscritto delle conoscenze linguistiche costitutive del significato, mentre l’Enciclopedia rappresenterebbe l’insieme generale delle conoscenze sul mondo, di natura fattuale e potenzialmente aperto, se non illimitato” (Violi 1997, 87). In altri termini, il Dizionario comprende solo i significati denotativi correnti delle cose, indipendentemente dal contesto in cui compaiono; l’Enciclopedia registra tutti i significati ulteriori che sul significato denotativo possono essere caricati a seconda del contesto e della circostanza in cui le cose compaiono (Eco 1975, 1979; Fillmore 1985). In effetti, se non ammettessimo che le cose possano assumere connotazioni diverse a seconda dei contesti, non riusciremmo a spiegare le differenze di senso dei vari contesti e dei vari oggetti in ciascun contesto, finendo così per appiattire il senso del mondo in una sommatoria dei soliti significati denotativi delle cose singolarmente prese. La forma strutturale dell’Enciclopedia riesce dunque a dar conto del complesso di connotazioni di cui ogni cosa si può caricare, dei diversi significati e delle diverse sfumature di senso che ad esempio fanno sì che quella cosa che chiamiamo “acqua” diventi un universo sconfinato di senso a seconda dei paesaggi reali e possibili in cui compare e delle recite che la natura, con le sue variazioni climatiche, vi svolge e di quelle che vi svolge l’uomo con le proprie azioni. È nell’intricata struttura dei diversi possibili inserimenti contestuali e circostanziali della nostra Enciclopedia che ritroviamo l’universo possibile del senso.[1]
Se la ‘scena-contesto’ è il modello base attraverso cui la semiosi mette in formato i vari significanti per assegnarvi i vari possibili significati, allora essa è anche il modello che la semiosi adotta per la messa in formato di quella forma singolare di testo che è il luogo che ci contiene: la ‘scena-contesto’ è il modello dell’unità base del paesaggio narrativo (Socco 1998). Ha ragione Gambino quando richiama la nostra attenzione sul problema cruciale del giusto formato dell’unità di paesaggio e della sua complessità definitoria nel momento in cui usciamo dai singoli paesaggi geografici, ciascuno con le sue unità di paesaggio, e cerchiamo di entrare in quella forma olistica di paesaggio che condensa il senso pieno del paesaggio stesso (Gambino 1997). Ma questo modello è lo stesso che i semiologi hanno dovuto mettere a punto per spiegare come sia possibile che lo stesso segno (o oggetto) si possa caricare di significati diversi a seconda dei contesti (o luoghi) e di come i contesti siano portatori di significati complessivi (o globali, o olisticamente assunti), che non sono esprimibili come sommatoria dei significati dei singoli segni componenti (per quel noto iato che esiste tra il locale e il globale, tra l’elemento componente e il sistema complessivo).
Il testo paesaggistico dunque si presenta in forma di ‘scena-contesto’ colta in una certa circostanza recitativa. Questa ‘scena-contesto’ è costituita da una lista di oggetti e di attanti colti in una certa circostanza (cioè da un contenuto lessematico); ciascun oggetto è collocato in una determinata posizione della struttura topologica dello spazio e muta il proprio significato connotativo a seconda della posizione nella struttura stessa (la quale pertanto costituisce la struttura sintattica delle connessioni sintagmatiche); ciascun oggetto è portatore di una informazione plastica cromatico-eidetico-materica in relazione alla quale si carica di connotazioni espressive diverse (Greimas 1984) (ed è a questo livello che si pone un problema di morfologia del paesaggio). Come si vede vi sono le premesse per dare fondamento ad una grammatica del paesaggio narrativo nella sua articolazione lessematica, sintattica e morfologica. Rimane il problema di scoprire ciò che aumenta il grado di ambiguità del testo paesaggistico imprimendogli quel di più che è la sua valenza estetica; ma mi pare vi siano, almeno tentativamente, le premesse per poterlo fare.
[1] L’enciclopedia è “l’unico modello capace di render ragione, sia sul piano teorico, sia come ipotesi regolativa per processi concreti di interpretazione, della complessità della semiosi.” (Eco 1984, 255).
Il paesaggio mitico
Esiste, oltre al paesaggio geografico ed a quello narrativo-estetico, un paesaggio che apporti un ulteriore contributo di senso alla già così vasta polisemia del paesaggio? O il paesaggio su cui ha senso concentrare la ricerca disciplinare può esaurirsi in queste due forme complementari, non sostitutive e non sostituibili, di paesaggio?
In effetti nel nostro Atlante Enciclopedico alberga un contenuto rilevante, che sempre aleggia quando si estende lo sguardo al di là delle letture geografiche dei vari sottosistemi del mondo: mi riferisco al contenuto mitico che le analisi antropologico-culturali hanno messo in luce, dando vita ad una importante geografia mitologica, che nei Tristi Tropici di Lévi-Strauss (1955) ha raggiunto il suo culmine. In proposito si deve però distinguere tra mito e mito. Una distinzione interessante mi sembra essere quella tra mitologia del sacro e mitologia dell’estetico.
La mitologia del sacro è quella che riempie il mondo di simboli, che trovano la propria motivazione profonda in qualcosa che non può essere spiegato se non ricorrendo all’Arcano, ad una qualche ragione prima e ultima che non è di questo mondo, qualcosa che in quanto soprannaturale non può che essere adorato e che solo un atto di fede può far esistere. A questo modello del mito sacrale è riconducibile tutta la mitologia arcaica, che anima la primordialità della nostra cultura: è il mito del brivido preistorico e dell’estetica mistica, che ha fatto della Natura un Tempio e del paesaggio una foresta di simboli (Turner 1967). Ora il mito, non essendo altro che un possibile senso del mondo, nel momento in cui viene calato sulla Terra, traccia confini e divide la Terra in paesi e in paesaggi. Così il mito della razza e del sangue genera regioni anche là dove nessuna ricerca geografica e storica riesce ad identificarle per il semplice fatto che esse esistono solo per volontà dell’Arcano. Questi miti arcaici sono duri a morire e spesso sopravvivono alla storia. Così, ad esempio, può capitare che, mentre la storia comincia a disegnare un paesaggio europeo, vi siano folle che presidiano i confini della Padania mentre i loro sacerdoti celebrano il mito del Po.
Anche tra i miti arcaici occorre pur distinguere. Non vi è infatti solo il mito della razza, il mito di potenza e di dominio sul diverso, inscindibile dal terrore dell’assedio dei barbari. Vi è anche il mito di Odisseo e del viaggio alla scoperta dell’infinita varietà di paesaggi di cui è fatto il mondo di tutti noi, del viaggio che non si ferma a quelli che gli dei dicono essere i confini del mondo, dell’avventuroso viaggio alla scoperta del senso molteplice del mondo e che solo ci consente di scoprire il senso della nostra Itaca: “Itaca ti ha dato il viaggio,/ senza di lei mai ti saresti messo/ in viaggio: che cos’altro ti aspetti?” (Kavafis). Ma quello di Odisseo è appunto il mito della vitalità della semiosi, della spinta ad andare oltre il confine dell’Universo Semantico dato, dell’avventurosa scoperta del senso possibile di cui possiamo caricare un Universo che per esistere non ha bisogno di avere un senso.
Il mito, tuttavia, non è solo quello sacro della cultura arcaica: anche nella cultura secolarizzata della contemporaneità permane una dimensione mitica che è profondamente connaturata con la semiosi stessa. Mi riferisco a quella mitologia della contemporaneità che con tanta maestria Roland Barthes ha disvelato. Quella dimensione mitica che è intrinseca al linguaggio perché può essere mito solamente “ciò che subisce le leggi del discorso” (Barthes 1957, 191). Mitico è un senso che opera senza apparire, riposto tra le pieghe dei significati come un parassita che svuota i significati stessi e li riduce a pure forme significanti di una “condensazione informe, instabile, nebulosa” (id., 201). Il mito può pervadere ogni atto e ogni oggetto che sia espressione di senso: dal vestiario, al cibo, alle automobili, alla pubblicità, fino a quella espressione totale del mondo che è il paesaggio come cultura.
Che fare di fronte al paesaggio mitico? Direi che nei confronti dei miti arcaici della sacralità, nonostante la loro tenacia, non ci sia che da indagarli per porli in una prospettiva storica in modo da accrescere la consapevolezza delle nostre origini: di essi si può solo sperare di liberarsi, non foss’altro per alleggerire il senso del paesaggio di ciò che non fa più parte della nostra Enciclopedia viva e feconda.
Diverso è il discorso che si può fare nei confronti del secondo tipo di mito: cioè quello che la semiosi stessa ha l’innata capacità di generare. E qui mi pare che si aprano due direzioni di lavoro: una è quella tracciata, ad esempio, proprio da Barthes nella sua acuta analisi dei miti d’oggi, cioè il disvelamento dell’ideologico che sta dietro al significato enunciato; l’altra è l’uso di questa potenzialità della semiosi per produrre un sovrappiù di senso che alimenti l’estetico.
Con riferimento alla prima direzione di lavoro, credo che una cultura del paesaggio abbia anche un compito di disvelamento dell’uso ideologico del paesaggio stesso, di quell’uso che appiattisce il paesaggio negli stereotipi del ‘villaggio turistico’, della ‘lottizzazione della città diffusa’, ‘dei cerimoniali consumistici della pubblicità televisiva’, insomma degli stereotipi che, per vendere paesaggi e prodotti, appiattiscono ogni differenza e con essa cancellano la molteplicità del senso del paesaggio. Ma l’aspetto che, in quanto architetto, più mi interessa è il secondo, cioè l’uso del potenziale mitologico-simbolico con quella finalità del tutto innocua che mira a creare l’illusione che il paesaggio dica di più di quanto il suo uso quotidiano normalmente non gli faccia dire: ma questa finalità non è appunto altro che quella estetica, quella di un “simbolismo poetico moderno”, cioè di un “ simbolismo secolarizzato dove il linguaggio parla di se stesso e delle proprie possibilità.” (Eco 1984, 254).
La polisemia come valore
Abbiamo visto che al di là del paesaggio geo-grafico e di quello estetico non esistono altro che residui arcaici, che giustamente affascinano gli appassionati di antropologia culturale, ma che sarebbe bene non turbassero i sonni di pianificatori territoriali o di disegnatori del teatro della nostra esistenza. D’altra parte abbiamo visto che già di per sé queste due forme caricano il paesaggio di una quantità di significati più che sufficiente per riempire il nostro pur sterminato Atlante Enciclopedico.
Abbiamo visto come le geo-grafie siano intente ad ampliare i loro atlanti con significati sempre nuovi, che le costringono a ridisegnare continuamente le mappe del mondo. Che ci stanno a fare degli architetti che si occupano di paesaggio estetico? In un mondo che corre il rischio di ridurre la polivocità del paesaggio, per fargli raccontare un po’ dappertutto più o meno la stessa storia, l’architetto (con l’inevitabile cooperazione dei geografi) può tentare di tenere aperto il senso del paesaggio, progettando paesaggi che funzionino alla stregua di testi aperti: sarà poco, ma forse è il modo più avanzato di fare cultura disegnando il paesaggio-teatro della nostra esistenza.
Credo che, se avesse ancora senso parlare di ‘idee guida’, quella della “cultura” (e del paesaggio come parte ineliminabile della cultura) è forse l’idea guida della contemporaneità: il valore di riferimento fondamentale. Noi sappiamo che al di là del senso che assegnamo al mondo non esiste un altrove di cui possiamo parlare; ma sappiamo anche della precarietà del senso acquisito e ciò ci sospinge costantemente alla ricerca di un senso altro: è così nel lavoro scientifico come in quel lavorio incessante di reinterpretazione della nostra storia, necessario per ricalibrare continuamente il progetto del nostro futuro. Forse il valore di riferimento è proprio in questa instabile precarietà della cultura; di una cultura che si produca come risultato di una sempre più vasta e attiva partecipazione degli individui. Se ciò fosse vero allora il destino del paesaggio culturale è quello di una crescente provvisorietà non solo del senso di cui lo carichiamo, ma anche delle forme che ad esso diamo per farne un’espressione di senso, cioè appunto di cultura: nulla di più instabile del senso e dei paesaggi di quelle società che sono in rapida e tumultuosa trasformazione.
Ma per un’epoca che ha fatto della provvisorietà del senso uno stile di vita, diventa altrettanto indispensabile conservare la memoria storica per renderla disponibile a quel continuo lavoro di reinterpretazione necessario per ridefinire la propria identità culturale e il proprio futuro. La nostra è anche un’epoca che, proprio per la sua spiccata coscienza ermeneutica, teme più di altre la perdita della memoria (di ciò che è stata la nostra cultura e il nostro paesaggio culturale): forse è proprio vero che per questa nostra cultura il mito più temuto è quello dell’incendio della Biblioteca di Alessandria.
Innovazione e conservazione sono le due polarità di riferimento intorno a cui si va definendo il paesaggio della contemporaneità (Gambino 1997): un paesaggio di crescente provvisorietà in cui progettiamo il futuro della nostra cultura (e che cosa sono le megalopoli dei Paesi in via di sviluppo se non questo? Ma possiamo tenerci le periferie delle nostre metropoli, le nostre “città diffuse” così come esse sono o non dobbiamo innescare in esse un profondo processo di continua trasformazione per farne l’espressione paesaggistica di una nuova cultura?), ma anche un paesaggio che sia scrigno di memoria, che sia museo della nostra storia (che cosa devono essere i centri storici se non questo? Ma i paesaggi agricoli o naturali di antica formazione e ancora relativamente intatti non sono forse il giusto equivalente dei centri storici?).
Dobbiamo proteggere il paesaggio-teatro della nostra storia per la ricchezza di memoria di cui esso è portatore e dobbiamo istituire delle regole che consentano un’ampia partecipazione dei cittadini alla formazione del paesaggio della provvisorietà come teatro della metamorfosi del senso. Si tratta di regole di saggezza che costringano ciascuno a fare i conti con i delicati equilibrii ecologici e con i limiti delle risorse; ma si tratta anche di regole di linguaggio, del linguaggio che ciascuno deve apprendere per comporre il paesaggio come un testo narrativo aperto, di un paesaggio fatto di una grande ricchezza di scene-contesto, di una continua e consapevole ricerca di effetti di decontestualizzazione scenica per far esprimere alle solite cose dei significati inusuali. Anche il linguaggio delle immagini attraverso cui diamo forma al paesaggio-teatro sembra contaminato da quella che Calvino chiamava la “peste del linguaggio”: “immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma e come significato, come forza d’imporsi all’attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola d’immagini si dissolve immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella memoria; ma non si dissolve una sensazione d’estraneità e di disagio.” (Calvino 1988). È questa incapacità di cogliere in tutto il suo potenziale espressivo il linguaggio delle immagini che finisce per impoverire il senso del paesaggio e per farne una cultura povera di senso.
Il paesaggio è uno di quegli oggetti “fatalmente suggestivi”, come Baudelaire diceva della Donna. La sua suggestione deriva proprio dall’inesauribità del suo significato, il problema dunque non è di limitarne il senso, né tantomeno quello di smembrarne una parte per rivendicare qualche forma di primato disciplinare sul paesaggio tutto: in questa smania di protagonismo abbiamo visto avvicendarsi, nella lunga storia del paesaggio, geomorfologi, storici, architetti, persino gli economisti quantitativi, e oggi vediamo soprattutto gli ecologi. In queste contese accademiche il paesaggio finisce appunto per smembrarsi divenendo irriconoscibile.
La strategia di ricerca, forse più efficace per non perdere di vista il paesaggio, mi sembra essere quella opposta; una strategia dove ciascuno dal proprio punto di vista lavora liberamente nell’intento di arricchire il senso del paesaggio proprio allo scopo di preservarne la sua fatale suggestione.
Riferimenti bibliografici
Assunto R., 1973: Il paesaggio e l’estetica, Giannini, Napoli
Assunto R., 1984: Parterre e ghiacciai, Novecento, Palermo
Barthes R., 1957: Miti d’oggi, Einaudi, Torino, 1974
Barthes R. 1977: “Ascolto” in Enciclopedia, vol. 1, Einaudi, Torino, 982-991
Calvino I., 1988 Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, Milano
Cantoni R., 1963, Il pensiero dei primitivi, Il Saggiatore, Milano
Conseil de l’Europe 1997) Rapport sur l’avant-project de Conservation Européenne du paysage, CG (4) 6. Strasbourg
Corrain L., Valenti M. (a cura di) Leggere l’opera d’arte, Esculapio, Bologna
Eco U. ,1962: Opera aperta, Mondadori, Milano
Eco U. , 1975: Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano
Eco U. , 1984: Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino
Eco U, 1997: Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano
Gambino R., 1997: Conservare, innovare. Paesaggio, ambiente, territorio, UTET, Torino
Greimas A. J. ,1970: Du sens, Édition du Seuil, Paris
Greimas A. J. ,1984: “Sémiotique figurative et sémiotique plastique”, in Actes Sémiotiques – Documents, 60, Paris
Greimas A. J., 1987: De l’imperfection, Éd. P. Fanlac, Paris
Jakobson R., 1963: Essais de linguistique générale, Minuit, Paris
Le Goff J., 1978: “Documento/monumento” in Enciclopedia, vol. 5, Einaudi, Torino, 38-48
Leroi-Gourhan, 1964-65: Le geste et la parole, 2 voll., Michel, Paris
Lotman J. M., 1985: La semiosfera, Marsilio, Venezia
Merleau-Ponty M. (1964) Le visible et l’invisible, Éd. Gallimard, Paris (tr. it. (1969) Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano)
Peirce C. S., 1931-35: Collected Papers, Havard University Press, Cambridge
Socco C.,1996: “Lo spazio come paesaggio” in VS. Quaderni di studi semiotici, n. 73-74, 193-215
Socco C., 1998: Il paesaggio imperfetto. Uno sguardo semiotico sul punto di vista estetico, Tirrenia Stampatori, Torino
Turri E., 1997: Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia
Violi P., 1997: Significato ed esperienza, Bompiani, Milano