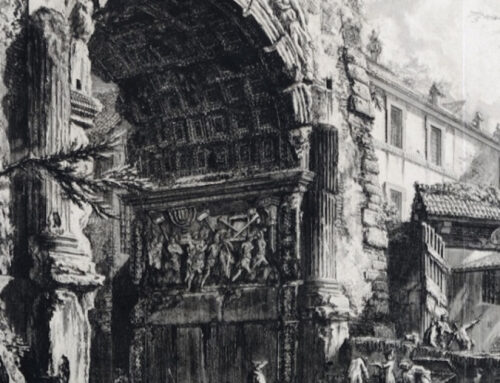Il senso della cura dei luoghi si sviluppa nelle comunità che si sentono proprietarie storicamente e culturalmente del patrimonio territoriale e quindi paesistico che abitano. Le pratiche faticose di gestione della montagna testimoniano la complessità del rapporto delle comunità con i luoghi: non solo per il senso identitario, ma anche per dare spazio all’esplorazione e sopratuttto al senso del sacro, così importante in passato e oggi ancora vivo ma sempre più segreto.
Gli usi civici, come la Magnifica comunità, frutto del lavoro di intere comunità per intere generazioni, segno di una cultura che ha creduto nell’importanza delle imprese collettive, durature.
Due notazioni sul termine “usi civici”, che poi ci serviranno: si parla di USI e non di beni, cioè c’è un implicito riconoscimento del lavoro: il bene comune non è la terra, ma la terra che produce perchè l’abbiamo curata e usata bene: perchè c’è il lavoro che l’ha resa utile.
Perchè poi si dice CIVICI, quando invece sono tipicamente rurali, frutto del lavoro contadino? La radice di civico non è parte della recente separazione tra città e campagna, deriva da civitas, civiltà: quel patto che unisce i singoli non in legami di sangue ma in accordi di cultura comune. Il mondo rurale si dota di civitas con gli usi comuni, fa patti e definisce regole dello stesso tipo di quelle che sono state alla base della formazione delle città medioevali, fondate sul termine COMUNE, che usiamo ancora oggi, senza rendercene conto, per identificare l’unica istituzione territoriale che nessuno mette in discussione.
La città medioevale è fondata su un patto di usi civici, che formano il comune.
Di questi usi residuano, come relitti galleggianti lungo un flusso del tutto nuovo, gli usi civici delle comunità rurali, soprattutto in montagna, dove la necessità di essere insieme di fronte all’avventura della produzione agricola è stato più forte: sono i pascoli in quota, i boschi, le acque che derivano dai ghiacciai, quelle che a valle sono sempre gestite comunemente, ma diventano proprietà dei consorzi, di enti autonomi, staccati dalle comunità.
Comunque è sempre da notare che nessuno si preoccupa degli oggetti, che si dà per scontato che siano beni comuni, ma della loro gestione: degli usi, che devono essere civici, cioè non solo destinati ma controllati dalla comunità… questo sarebbe bene tenerlo come bussola per dibattiti speciosi come quello sull’acqua, in cui si distingue l’uso dal bene….
Dunque gli usi civici sono il segno magnifico della cura della montagna che è implicita nelle pratiche rurali, quelle che hanno nel DNA la sostenibilità dell’uso della risorsa, che curano l’equilibrio tra processi naturali e loro derivati utili per la comunità (presente e futura) e in questa cura rallentano o accelerano cicli, sfruttano microclimi, mantengono condizioni senza mai stravolgere i processi, non perchè il contadino sia buono o ecologo, ma per un sano principio di economia dettato dalla fatica, che è massima in montagna: quando hai compiuto l’impresa di terrazzare e far fruttare un campo su un versante cerchi di farlo rendere per molti anni, quando hai costruito un ricovero per il bestiame al pascolo in quota lo fai in modo che sia protetto dalla valanga e che lo ritrovi l’estate prossima eccetera. La fatica è un’ottima consigliera del fare e del manutenere, e induce un rispetto per il frutto del lavoro, proprio e di chi ci ha preceduto e un criterio di economia reale, cioè delle leggi che regolano la vita.
E il paesaggio cosa c’entra???
Facciamo nostra la definizione della convenzione europea:
Parlando di paesaggio non si parla delle cose, dei luoghi, ma della relazione sociale che c’è con i luoghi.
Fin qui il paesaggio non emerge, è sotto traccia: nessun abitante tradizionale della montagna agisce o racconta di sè in base alla propria percezione del territorio, ma direttamente agisce sul o racconta del territorio. E il territorio è il proprio, che non c’è bisogno di dirlo perchè tutti lo sanno.
Nel Tao si dice “beato il contadino che guarda dal proprio versante gli abitanti dell’altro paese sul versante di fronte, li saluta e viene ricambiato, e non è mai stato dall’altra parte del versante”: nel mondo tradizionale si pensa che tutto il mondo è paese, e che quindi non c’è bisogno di rappresentare il paesaggio.
La definizione della CEP comporta l’emergere di un tema di consapevolezza, che è propria di ciò che non c’è naturalmente, ma come le pulizie domestiche, ci se ne accorge quando manca.
Ad una società che si è chiusa nelle città, che non produce più a diretto contatto con la terra, il paesaggio manca, e ne scopre la versione culturale: la relazione percettiva con il territorio.
Tanto è vero che quando diciamo paesaggio pensiamo ad un luogo non urbano, con molto verde, in parte coltivato e in parte no, con radi segni insediativi…. un pays, (noi siamo latini e mediterranei e pensiamo sempre a paesaggi antropici):
Nel nord pensano al landschaft , alla faccia della terra, naturale, senza uomo.
Quando dalla comunità unita dal lavoro faticoso si passa ad una entità sociale più vasta, che abita un territorio complesso e parzializzato, in cui non tutte le esigenze dell’abitare sono comprese nel luogo in cui si sta, allora emerge il bisogno di paesaggio.
Qui si passa dall’economia alla cultura, dalla necessità primaria: alimentarsi, avere un tetto, ai bisogni complessi: sentirsi a posto, godere del piacere di abitare nel senso più completo del termine (avere consuetudine con i luoghi, incoativo del verbo avere: continuare ad avere).
Abbiamo provato a distinguere tre grandi versanti su cui declinano i percorsi del senso attivati dal paesaggio, attraverso un modello interpretativo basato su un’antinomia: l’identità e l’alterità.
Secondo questo criterio la nostra attenzione al paesaggio va normalmente alla ricerca di segni, e la CEP ci dice che il paesaggio è una componente importane del senso di identità dei popoli europei.
In questa fase di mobilità territoriale e di melting pot culturale abbiamo bisogno di rassicurarci, di ristabilire la nostra carta di identità, e il paesaggio è importante. Per questo dobbiamo resistere alle presioni di omologazione, di produrre non luoghi, di essere indifferenti alle differenze.
Però non c’è solo il senso di identità, ma anche quello di alterità: il sentirsi incuriositi perchè diversi, essere mossi da un senso di conquista, di espansione perché siamo di fornte a segni e sensi che non conoscevamo sino ad un attimo prima ed ora che li abbiamo percepiti sentiamo di avere arricchito il nostro patrimonio (di esperienza se non altro, e talvolta di cultura). Da una parte “la conferma dell’identità attraverso segni conosciuti, (dall’altra) la ricerca di nuovi trofei di segni in territori di alterità sino ad ora inesplorati……
Il senso di esplorazione vale in particolare in montagna:
«Il vero alpinista è l’uomo che tenta nuove ascensioni. Non importa se vi riesca o no; egli ricava il suo piacere dalla fantasia e dal gioco della lotta» Mummery, 1890, che usava il termine “fair means”: mezzi leali, cioè assegnati solo al proprio corpo.
Ma talvolta non bastano queste due contrapposte tensioni a spiegare le multipolarità del senso che ci agitano guardando un paesaggio: c’è anche la loro contraddizione, il desiderio folle di abitare nel sacro, di vivere un rapporto con l’ambiente senza la mediazione di apparati domesticatori come il senso del bello, dell’ordine e soprattutto senza il senso del senso, cercando di vincere la tensione ossessiva alla semicità che ci rassicura e che probabilmente è il radicale intimo dell’abitare: nominare le cose, darsene una ragione. Il senso panico, il romantico perdersi, l’appartenere piuttosto che possedere sono prodotti di una terza pulsione, rimossa e rinnegata da tutta la gnoseologia e da quasi tutta l’estetica ma che sicuramente agita la nostra cultura da sempre e che permane, negli esiti dei movimenti artistici degli ultimi trecento anni, sul gusto diffuso”
Nella definizione del dizionario Treccani: “In senso stretto, ciò che è connesso all’esperienza di una realtà completamente diversa, rispetto alla quale l’uomo si sente radicalmente inferiore, subendone l’azione e restandone atterrito ed insieme affascinato. In opposizione a profano, ciò che è sacro è separato, è altro, così come sono separati dalla comunità sia coloro che sono addetti a stabilire con esso un rapporto, sia i luoghi, destinati ad atti con cui tale rapporto si stabilisce. Il sacro è ciò che gli uomini avvertono come totalmente altro e che si manifesta con forza misteriosa, rispetto al quale essi si sentono sottoposti, spaventati e allo steso tempo attratti”.
Ma la particolarità strutturale del senso del sacro forse sta proprio nella diversità di atteggiamento dei soggetti: dunque bisogna averne voglia, attenzione, disposizione per dare senso al paesaggio che percepiamo.
Ma, fuori dalla generalità filosofica, il paesaggio si presenta in forma di luoghi, differenti in sé e differentemente percepiti: dovremmo avere una certa competenza nel selezionare i luoghi più adatti a ciascun tipo di esperienza. Qui si apre una delle pagine più frequentate dai critici della modernità: abbiamo perso ogni capacità di percepire le differenze dei luoghi. Come intere discipline studiavano dove era meglio collocarsi per abitare, così ogni cultura arcaica individuava i luoghi sacri, molti dei quali ospitano nei secoli templi delle più diverse religioni, confermando sempre più la sacralità del sito. Noi no: da un paio di secoli la cultura ufficiale si è scientifizzata e ha perso il senso di queste sapienze antiche, con grande dispiacere di studiosi come Guenon, che lamenta la perdita del sapere tradizionale, che dava spazio ai luoghi eccezionali per la forza del sacro che contengono.
Dall’arcaico (lontano da noi nel tempo, antidiluviano, o ancora presente nel tempo ma lontano nella cultura, antioccidentale) sicuramente arriva ancora viva l’intuizione di poter cercare luoghi adatti ad un’esperienza sublime, come Kant la definiva, o per lo meno che faciliti l’ascolto di un nuovo senso delle cose: Elemire Zolla parla della Montagna (come dimenticare lo straordinario Monte Analogo di Renee Daumal?), Simon Shama estende il campo di indagine alle storie sacre della Foresta.
In una bella pagina Sergio Quinzio mette a confronto i due luoghi archetipici del sacro, il bosco e il deserto: “Per le religioni pagane, cosmiche, il bosco è la manifestazione più evidente del pulsare delle forze divine che animano la natura, dunque il più intenso simbolo sacro.(…) Di fronte alla sacralità del bosco, cupo e pieno delle misteriose voci che il vento trae dalle chiome degli alberi, c’è per l’antico monoteista il deserto. Basta vedere cos’è il deserto per l’ebreo Edmond Jabes. Il mistero non sta nelle cose, che sono anzi offerte alla disponibilità degli uomini, ma al di là delle cose, nella trascendenza dell’unico Dio, di cui la distesa sconfinata del deserto è simbolo.”(in Boschi e foreste, ed.Gruppo Abele 1994, p.57). Luisa Bonesio porta a fondo il discorso esplorando le differenze dei tre percorsi archetipici per un senso nuovo attraverso i luoghi: l’esperienza del sacro nel deserto, nel bosco e sulla montagna (in La terra invisibile, Marcos y Marcos,1993).
- a) in prima istanza siamo indotti dalla cultura urbana che ci assedia da almeno 200 anni, a confondere ricerca del naturale con ricerca del soprannaturale. Coltiviamo un’idea astratta del naturale, con cui abbiamo ormai rapporti diretti rari quanto con il soprannaturale: la nostra continua attenzione ai segni del paesaggio trova conferma in paesaggi sempre ricchi di segni, in paesaggi culturalizzati negli oggetti manufatti e non solo nel nostro sguardo. La natura diventa quindi, nel nostro desiderio di incontrare l’alterità, un fantasma che si va sovrapponendo all’ansia del sacro, e l’immaginario che accompagna il nostro personale, artigianale e velleitario senso del sublime sono sempre più legate a spazi naturali che probabilmente sarebbero sembrati normali (in quanto abitabili) al sapiente arcaico, ad esperienze di contatto con una natura che noi ci trasfigura mentre per loro è casa (ricordate Dersu Uzala, la guida della foresta protagonista di quel capolavoro di Kurosawa). Ma noi abbiamo perduto sia la dimestichezza che il rispetto, quello che fa cantare al capo Seattle degli Apache che tutto è sacro, perché l’intera esperienza di vita è in intenso rapporto con una natura che ha il suo autonomo sistema di segni e di valori, rispettati in quanto diversi; il nostro rapporto con la natura è mitico: Zolla dice che cerchiamo uno stupore ma non abbiamo più lo sguardo capace di ingenuità;
- b) in seconda istanza siamo indotti da una millenaria ricerca della comunità a fare attenzione al suo stesso patrimonio culturale, ai segni di sé che la koinè traccia nei luoghi per tenere uniti i suoi componenti. Condividiamo ansie di identità e chiediamo conferma ai luoghi, al paesaggio: cerchiamo patrie per la nostra gente. Il senso della koinè per definizione non può immergersi in un ambiente estraneo e rimanerne intriso: mantiene una impermeabilità, fa un guscio di ambiente conosciuto attraverso i suoi rapporti interni e non può accedere all’alterità. Sappiamo tutti che se si va in gruppo all’estero non si riescono ad imparare le lingue straniere, e tanto meno l’esperienza del sacro. Ulisse ci insegna: ha dovuto staccarsi dai suoi per ascoltare le Sirene, anche se i compagni gli hanno impedito che l’esperienza sublime si tramutasse in viaggio definitivo;
- c) in terza istanza, e in coerenza con la scelta di privilegiare i rapporti comunitari, è innescato da oltre un millennio un processo di simbolizzazione del sacro, di spostamento dall’esperienza diretta e ostensiva, che coinvolgeva i sensi ed il senso, ad una comunicazione astratta, rappresentativa, rituale. E in occidente questa rappresentazione simbolica è fondata su atti edificatori, segni nel paesaggio (non è dappertutto così: si pensi al rito delle comunità aborigene australiane raccontate da Chatwin ne Le vie dei Canti). Nella nostra storia invece abbiamo dovunque la stessa sequenza: prima c’era il luogo sacro, reso sacro dalla presenza (o dalla manifestazione) del Dio, privo di segni umani; poi la comunità ha segnato il luogo sacro con un suo edificio, il tempio, poi il segno del tempio, rimasto a testimoniare l’antica devozione per il sacro, si è staccato dal luogo dove sta il Dio ed è stato costruito dove stanno i devoti.
La ricerca di ogni cultura di assestare equilibri tra le tre componenti:
l’evoluzione dell’identità: la campagna (la chiesa, l’ecclesia, la comunità, il campanile) si perde nella città, salvo il centro storico
l’evoluzione dell’esplorazione la perdita di identità delle città spinge al turismo , la nuova forma di esplorazione, ma anch’essa si perde, nel turismo di massa
l’evoluzione del sacro (dal simbolo si ritorna all’immanenza della natura): le religioni monoteiste, è stato detto, nascono dal deserto; quelle politeiste, da bosco; è facile capire perchè: la solitudine, il rapporto impari deve essere riprodotto
La montagna come paesaggio di frontiera, dove le tre componenti trovano equilibri molto avanzati, per la presenza forte della natura
la natura come riferimento per il sacro
il turismo come esplorazione verso la natura
la coltivazione come identità rispetto alla natura
ecco il ruolo dell’agricoltura di montagna: insegnare un diverso turismo, sia per esplorare che per riassaporare il senso del sacro
Turismo, come tutti gli ismi, si porta addosso un connotato negativo: al mondo rurale dei secoli scorsi l’“andare in giro” appare, appunto, come una stravaganza, riservata agli eccentrici abbienti, una mania di chi rinuncia agli agi della residenza per cercare non si sa quali diversi (e quindi perversi) piaceri. Perché, al di là del disprezzo sintetizzato nel monito contadino “sta a ca’ tua”, è chiaro a tutti che di piaceri si tratta: il turismo comporta un andare in luoghi poco conosciuti per scelta, per curiosità, per il gusto del personale arricchimento culturale e psicofisico.
Insomma il turismo è una versione borghese del viaggio romantico, la riproduzione comoda dell’esplorazione avventurosa e dei piaceri adolescenziali che quell’emozione comporta.
Sembra molto più politically correct la storia recente del termine Paesaggio, che è stato dedicato, nella Convenzione europea, a corredo del senso di identità “delle popolazioni”. Nel senso comune, ancora influenzato dalla civiltà stanziale contadina, le “popolazioni” sono le società abitanti: il senso di identità si suppone crescere come una pianta, legata al suolo, quindi patrimonio di chi ha una relazione stabile, radicata, con il “suo” paesaggio. Il turista, ad una lettura preconcetta, sembra estraneo alla definizione della Convezione: un intruso, uno che sbircia o, peggio, potenzialmente calpesta il paesaggio altrui.
Ma, come capita per il colesterolo, la versione negativa, che vede immediatamente gli aspetti dannosi provocati dall’intasamento e dall’accumulo, non spiega tutto il fenomeno: se si approfondisce si scopre che un certo turismo non solo è utile, ma costituisce una risorsa fondamentale per la valorizzazione (e quindi la manutenzione) dei paesaggi che amiamo.
Prima di tratteggiare i requisiti della fausta alleanza tra abitanti che sanno ospitare e turisti che sanno essere ospiti, va disegnato il profilo del TB (“Turista Buono”). E per questo bisogna risalire alla definizione iniziale: il turismo è un piacere, che comporta un andare in luoghi poco conosciuti per scelta, per curiosità, per il gusto del personale arricchimento culturale e psicofisico.
Il turista che ricerca questo tipo di piacere:
– è curioso e sta attento a percepire il più possibile i tratti di novità e di differenza dei paesaggi che incontra, rispetto a quelli già conosciuti;
– relativizza le sue esigenze abituali alle situazioni che incontra, anche in termini di confort, di dieta, di comportamento sociale;
– riconosce il valore aggiunto della cultura del paesaggio di chi abita, e con quella cultura, fatta di competenze e visioni diverse dalle proprie, entra in relazione, le ascolta (nell’accezione arguta del termine che ne dà Barthes nell’Enciclopedia Einaudi, 1977), godendosi in quella relazione una bella fetta del piacere del tour.
Questi requisiti del TB inducono pratiche comportamentali che vanno al di là di quelle dettate dalla buona creanza o dall’etica dell’egualitarismo. Le motivazioni del TB sono la base stessa del viaggio, della esplorazione dell’altro da sé, del postulato secondo cui la propria identità si arricchisce attraverso la comprensione di altre identità.
Senza quelle curiosità e riconoscimenti della diversità paesistica, l’attenzione a se stessi prevale, offusca l’ascolto e il gusto delle specificità si perde: il piacere del viaggio sfuma e finisce per non valerne più la pena.
Ovviamente, se si pongono queste priorità di attenzione e di ascolto, ne conseguono condizioni di tempo e di spazio inderogabili: il TB deve essere libero di muoversi e di fermarsi, di guardarsi intorno, di chiacchierare, di deviare da rotte preventivate, di attendere occasioni per superare la naturale diffidenza che si riserva ai forestieri. In una metafora classica: si devono creare le condizioni per la serendipity, quella situazione che Perec ed altri hanno esplorato con tanta dedizione (Perec,1989) (Bagnasco, 1994) (Merton & Barber,2008). Questa condizione fondamentale separa in modo definitivo il buon turista da quello cattivo, di massa, col tempo contato e autoriferito.
Una straordinaria testimonianza del processo virtuoso, di integrazione tra consapevolezza del proprio e attenzione all’altrui paesaggio, è data dalla raccolta di segnalazioni di “Luoghi del cuore” messa in campo dal 2003 per iniziativa del FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Nelle varie edizioni tra il 2003 e il 2008, anche indipendentemente dalle intenzioni dei promotori, si è verificata una metamorfosi dei messaggi prevalenti (ogni anno più di 100.000).
In una prima fase venivano segnalati per lo più i luoghi natali, spesso trascurati o sconosciuti, ma ritenuti interessanti dagli abitanti, che vi erano naturalmente affezionatissimi. A questi si sono affiancate, e poi hanno prevalso, le segnalazioni di paesaggi “d’elezione”, di turisti che hanno voluto testimoniare l’emozione di luoghi scoperti e gustati in tutta la loro specificità. Sono proprio i paesaggi d’elezione ad essere posti, in una terza fase, al centro della metamorfosi del turista (e qualche volta dell’abitante) in “militante”: le segnalazioni diventano via via sempre più preoccupate per la salvaguardia dei siti amati, denunciano progetti pericolosi, fanno appelli contro il degrado.
Insomma si verifica, statisticamente e su un campione, un processo “politico”, per il quale emergono diverse fasi salienti: dalla consapevolezza di una risorsa paesistica non scelta (da parte dell’abitante locale) ad una ricerca di riconoscimento di risorse cercate e scelte (da parte del TB), alla “presa in carico” di un paesaggio d’affezione, atteggiamento che è ormai dominante nelle segnalazioni al FAI degli ultimi anni, che siano di turisti o di abitanti, o, come avviene sempre più frequentemente, di esponenti dei due gruppi solidali.
Di fase in fase è in crescendo l’assunzione di responsabilità, che si manifesta all’inizio nel rendere pubblica la propria posizione: il primo e il secondo passaggio sono una sorta di “outing paesistico”, in cui l’abitante e il turista si dichiarano impegnati proprio nell’atto di riconoscere un paesaggio; la terza fase è un balzo in avanti, per cittadini che possiamo pensare normalmente estranei ad un ruolo forte di impegno civile, che si mobilitano per una causa non legata ad interessi o a vantaggi personali o di categoria, ma per difendere e valorizzare un bene comune. Si vogliono innescare processi di pubblicizzazione, di chiamata di tutti a valutare, a partecipare di un bene comune e a prendersene carico, difendendolo non in quanto specifici utilizzatori ma in quanto rappresentanti del mondo (presente e futuro).
Nei casi virtuosi, come quelli promossi da Petrini, dalla relazione economica tra TB e abitante emergono programmi a lungo termine, in cui non si discute più tanto di sostenibilità del turismo, ma di partecipazione del TB alla sostenibilità dei progetti di paesaggio. In quei casi il consumatore consapevole entra direttamente come operatore nei processi economico- territoriali, in aiuto e non in aggressione della diversità paesistica, come accade con i GAS (Gruppi di Acquisto Solidali) in molte province dell’Italia centrale a favore delle produzioni agricole qualificate o, con progetti appena nati, per le produzioni casearie di alcuni pascoli alpini.
Sono casi di seconda generazione, in cui il turismo e il consumo si costituiscono come attori e non semplici fruitori del paesaggio, mettendo a frutto i risultati della prima lezione: il turismo è un piacere, un’arte di ospitalità, con i precetti della seconda: che comporta responsabilità reciproche e imprese comuni tra ospiti.
D’altra parte l’abitante stabile fruisce quotidianamente del paesaggio con competenza e nel quadro di un sapere profondo e radicato, ma nella disattenzione. Normalmente non si riflette sugli aspetti di piacere e di risorsa per la qualità della vita che ci provengono dal paesaggio che abitiamo. Il rapporto ordinario con il paesaggio è implicito, trascurato come un muscolo involontario, di cui ci si accorge pienamente solo quando fa difetto, quando manca (Raffestin 2005).
Se il motore dell’attenzione al paesaggio viene mosso dal desiderio di qualcosa che non si ha (o si rischia di non avere più), non parte dall’abitante se non quando si teme per la sua perdita. Quindi, in condizioni normali, l’abitante non conta consapevolmente sul paesaggio per la propria qualità della vita: deve essere suscitato, deve riscontrare qualcuno che invece il paesaggio lo cerca, qualcuno che ha piacere di ascoltare la “sua” relazione con i “suoi” luoghi: il suo senso del paesaggio.
Dunque quasi sempre l’abitante riesce ad attivare la pratica fondamentale della consapevolezza del paesaggio solo assumendo come target il TB: ci si rende conto del patrimonio di cui si dispone proprio all’atto di offrirlo alla fruizione del forestiero.