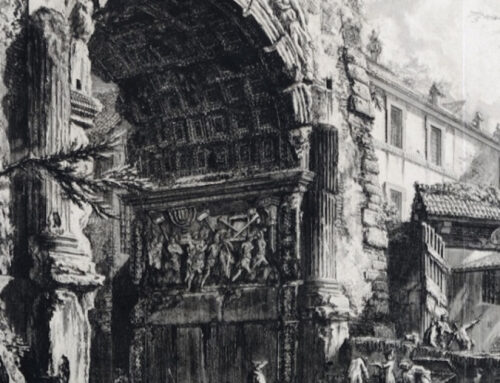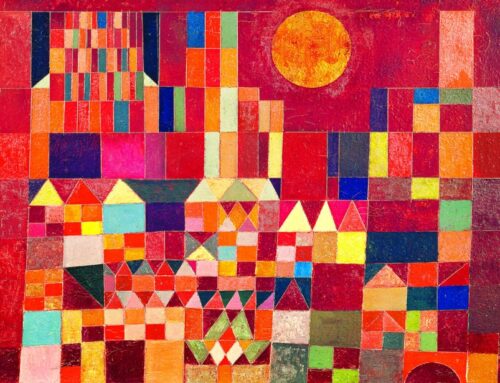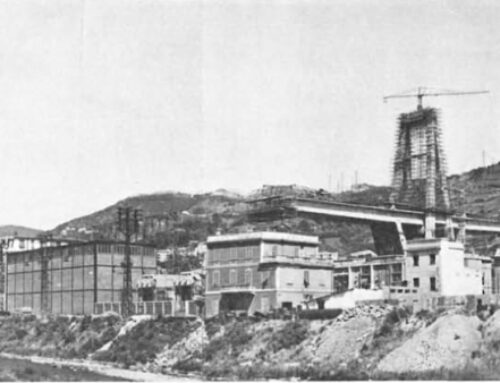Relazione d’apertura al seminario in Art Lab10, Torino
- Il paesaggio non è nelle cose, è nello sguardo. Con questa premessa artisti e poeti hanno spiazzato chi, come noi, lavora da tempo sul tema per la sua sostanza: di bene culturale, di risorsa territoriale, di aspetto del sistema ambientale. Da qui con fatica ma anche con soddisfazione si comincia a ragionare sul paesaggio come relazione, dialettica tra il territorio e il punto di vista, tra fattori oggettuali e fattori soggettivi. E si scopre che anche lo sguardo può essere considerato una risorsa, ove se ne riconoscano le caratteristiche, la domanda implicita.
Un film di qualche anno fa, Camera con vista, ha riportato l’attenzione su uno straordinario racconto di Forster dei primi del ‘900. La vicenda è romantica: una giovane inglese è colta da un amore inopportuno durante un viaggio in Italia, complice il paesaggio toscano, sintetizzato nella vista che si gode dalla camera d’affitto in cui risiede. Questa avventura, poco più che platonica, le cambia la vita, facendole scoprire la potenza dell’intensità delle emozioni.
La vista su Firenze di Forster è un paesaggio sognato che costituiva, nell’immaginario dell’Inghilterra vittoriana e repressa, un habitat di libertà e di amore. Un’idea non tanto alimentata da diversi usi e i costumi in tema di rapporti amorosi o sessuali, quanto dallo stimolo dei sensi anglosassoni provocato dalla luce, dal tepore delle stagioni, dalla cultura mediterranea del corpo, dei cibi, dei suoni e della prossemica ravvicinata nelle relazioni sociali…. insomma un senso del paesaggio vivo che attizza la vivacità dei sentimenti.
Il senso comune del paesaggio quindi non si rivela solo in una modalità tradizionale, tipo la Heimat tedesca, generatrice degli attaccamenti al proprio territorio che pesano su tante nostre scelte di vita, o delle nostalgie che motivano tanti ritorni. Nel senso comune del paesaggio sta anche la fonte dell’ansia di fuggire che prende i cittadini al week end, per il mare, la campagna o un’altra città; sta il riguardo dei libri del Touring club allineati su uno scaffale dei salotti dei nostri nonni. In quei libri di foto in bianco e nero e di cartine si palesa un ruolo del paesaggio fondativo del nostro sistema di valori, così incarnato nel pensiero corrente del ‘900 che non ce ne rendiamo neppure più conto: è il frutto maturo del Risorgimento, della cittadinanza italiana, è la forma concreta e inaspettata del patrimonio che il figliol prodigo riscopre come segno dell’appartenenza ad una schiatta nobile.
Il senso comune del paesaggio non è prodotto autoctono per un consumo autistico, come il mondo rurale ci ha insegnato a fare, è al contrario un modo di comunicazione, una rappresentazione a se stessi e al mondo del proprio habitat, un esercizio di cittadinanza globale, frutto implicito delle rivoluzioni democratiche dell’800. Ci piace sapere che il mondo è ricco di varietà e di bellezza di natura e di prodotti e ci piace farne parte non solo come fruitori ma anche come portatori di un nostro specifico contributo: il paesaggio non è un dato, si produce continuamente nelle cose e nelle culture di ciascuno.
Sin qui un riconoscimento di valori che costituiscono la qualità della vita della nostra civiltà, un lavoro da psicologo o meglio da antropologo che bisogna tenere presente per non oggettivare troppo il tema quando si parla di risorse, per non parlare solo di beni, di ambienti, di architetture dimenticandoci il motore interno a noi, che genera l’apprezzamento e il valore. - Ora le novità: se il Consiglio d’Europa dieci anni fa ha promosso una Convenzione del paesaggio, chiedendo impegno alle istituzioni di tutti i paesi per difendere e valorizzare il ruolo identitario dei paesaggi distintivi di ogni luogo, una ragione c’è; anzi c’è un ruolo politico. Ci si accorge, a Strasburgo, che l’identità delle genti non passa solo per la lingua e i simboli della propria storia, ma per la cultura diffusa del proprio territorio, per la considerazione che si ha per i luoghi che si abitano. Ci si accorge che il paesaggio non è solo un bene in sé, ma che è utile ad un progetto politico, al miglioramento della qualità della vita e che l’azione sul paesaggio promuove la capacità collettiva di rendere duraturo e condiviso questo miglioramento.
Si scopre che essere consapevoli delle proprie risorse e offrire il proprio territorio senza consumarlo è il nuovo modo di coltivare, di innescare cicli economici sostenibili. E’ una sfida che assume straordinario interesse perchè ha strutturalmente aspetti alternativi al sistema economico che ci ha illuso per due generazioni e che oggi si vede attraversato da crepe gigantesche. E’ una sfida in primo luogo culturale, che richiede la formazione di competenze e capacità imprenditoriali tarate su valori diversi dalla pura conservazione degli oggetti o viceversa della pura economia commerciale.
Spesso si tratta di talenti già presenti sul territorio, nascosti nei saperi e nelle microimprese che crescono nei milieu locali, nati in una concezione di slow economy e di sobrietà nell’uso delle risorse, anche se schiacciati da una prevalenza della cultura della genericità e del disimpegno e da un’imprenditorialità corsara e di breve periodo. Le speranze di innovazione per un modello di comportamenti e di piaceri della vita lento, sobrio e diffuso sono affidate ad iniziative locali, a testimonianze ancora per qualche anno presenti ma in via di estinzione, energie tenaci ma deboli se non si mettono a sistema per acquisire una visibilità, una credibilità, una capacità di comunicazione tra soggetti impegnati nella stessa direzione.
D’altra parte queste iniziative trovano adeguato sviluppo se si connettono con una domanda che parla la stessa lingua, che ricerca con lo stesso gusto per lo spazio vasto e il tempo lungo, che è animata da una curiosità rispettosa e divertita. Per ora si tratta di fruitori (turistici e residenziali) di nicchia, piccoli numeri che non muovono investimenti miliardari e che non costituiscono alcun tipo di fronte organizzato: anzi la ricerca individualista dei propri luoghi di elezione e dei paesaggi del cuore sembra essere il principale motore psicologico di questo aspetto della qualità della vita.
La frammentazione delle iniziative locali e quella della domanda per un paesaggio vivo e non banale sono fonte contemporaneamente di debolezza e di resilienza: non consentono prospettive di sviluppo locale potenti ma hanno anche una capacità di adattamento e di sopravvivenza maggiore di iniziative che richiedono pianificazione e investimenti importanti. Anzi, proprio la frammentazione impedisce l’omologazione, spinge alla diversificazione e alla ricerca del particolare, dello specifico che si vuole mantenere e che è oggetto di ricerca per gli “esploratori” del paesaggio.
Su questo fronte qualitativo, strategico per la nostra cultura che rischia la definitiva banalizzazione, su cui si allinea chi dedica le proprie energie di imprenditore o di consumatore, mancano i servizi di sostegno che non abbiano implicito un processo di massificazione, che non portino ad uno sviluppo solo quantitativo, ad una competizione al ribasso che perde per strada per prime proprio le qualità differenziali dei luoghi e degli sguardi. Il ruolo delle istituzioni per il paesaggio è forse tutto qui, nel promuovere le rotte, le mappe e i servizi d’appoggio per questa Operazione Dunkerque dei nuovi comportamenti economici basati sulla competenza territoriale e paesistica, nella disfatta del consumismo e delle produzioni inutili. Tra i servizi d’appoggio, che le istituzioni possono (a questo punto devono) fornire, è fondamentale il supporto alla formazione di reti, di sistemi di relazioni che facciano raggiungere massa critica e riconoscibilità a chi si occupa di valorizzazione delle risorse paesistiche.
Infatti la produzione di prodotti tipici, la dotazione di servizi per il turismo, la messa in pristino dei beni culturali non sono in sè attività che valorizzano il paesaggio e generano modalità economiche alternative, se non sono inserite in un disegno complessivo che risponde a due requisiti:- partecipano ad una rappresentazione olistica di un luogo, in cui i singoli elementi concorrono a definire un’immagine organica, che si deposita nella memoria nel suo insieme;
- generano un’interazione complessa in chi fruisce dei luoghi, inducendolo ad utilizzare risorse anche al di là di quelle che aveva previsto: innescano un processo di serendipity che sorprende e intriga rispetto al normale funzionalismo commerciale e alla triste specializzazione dei gusti. In questo senso il ruolo delle istituzioni non è di produrre il paesaggio, ma inserire il lavoro di coloro che lo producono in un sistema coerente ed integrato, con:
- incentivi a stabilire relazioni tra aspetti normalmente incomunicanti (come ad esempio il turismo culturale con quello balneare, la valorizzazione dei segni storici del territorio con le produzioni agricole e le attività ricettive, o la conservazione dei beni naturalistici e architettonici con le attività culturali),
- regole che riducano lo spazio di messaggi contradditori, come la devastazione dei bordi di aree pregiate per fornire servizi alle loro produzioni (l’edilizia turistica intorno alle aree protette, i capannoni alla base dei versanti a vigneto candidati all’Unesco) o la costruzione banale di periferie sottoutilizzate intorno a centri storici, di valore ma anch’essi sottoutilizzati,
- procedure selettive per eliminare le iniziative che esauriscono la loro forza propulsiva nel breve periodo, ingestibili per i costi, per la difficile accoglienza nel senso comune del paesaggio o per la mancanza di adeguate competenze diffuse: mettere a punto una cultura tecnica della gestione dei progetti strategici che oggi manca e ci fa sprecare le energie e i pochi investimenti disponibili.
Si tratta di temi su cui si sono misurate da qualche anno la buona volontà di molti sindaci e assessori, i programmi virtuosi di aree protette e regioni: pochi successi e moltissime delusioni, dispersioni di entusiasmi e investimenti che non sembrano mai raggiungere la soglia minima per dare soddisfazione a chi partecipa, visibilità agli interventi, indotto economico convincente.
Certo i pochi esempi di successo si sono fondati non tanto su strategie generali quanto su specificità locali, integrazioni tra poche iniziative tra imprenditori di livello analogo che affrontavano sfide condivise. Se questo aspetto, di base comune da integrare, costituisce il comune denominatore delle poche iniziative di successo, certo gli enti impegnati nei progetti di valorizzazione del loro territorio attraverso la logica del paesaggio devono caratterizzare il loro contributo di regia e coordinamento sulla base delle specifiche condizioni (temporali) e situazioni (locali). Senza la capacità di riconoscere i limiti e le risorse del tempo e del luogo non si riesce ad progettare tenendo conto che il lavoro sul paesaggio è sempre come quello degli Argonauti, che hanno rifatto la nave mentre navigava, sostituendola pezzo a pezzo senza mai fermarla.
3. Si può credere che per il successo di una strategia pubblica, vadano considerate a fondo le specificità delle situazioni di riferimento, le cui dimensioni sono sempre a scala locale ma mai rinchiudibili in un solo Comune. Ma accanto all’attenzione alle situazioni va anche interpretato in quale ciclo della propria storia si trova il paesaggio condiviso: vanno studiate le condizioni evolutive del rapporto tra genti e luoghi. Insomma non ci sono ricette onnivalenti, ciascuna strategia deve essere ad hoc, adeguata ad ottimizzare i risultati relativamente a quel pezzo di territorio e a quella fase evolutiva del paesaggio.
4. Nei casi virtuosi già in atto i progetti di sviluppo locale e di miglioramento della qualità della vita si sono sempre innescati realisticamente nelle condizioni storiche e culturali specifiche, caso per caso. Ma se l’attenzione ai luoghi comincia a diffondersi, sinora nelle strategie per il paesaggio è mancata l’attenzione per le dinamiche temporali, le condizioni evolutive del rapporto tra fruitori e luoghi.
Per esemplificare cosa si intenda per condizioni paesistiche evolutive proviamo ad abbozzarne alcuni tipi, relativi a diversi stadi dell’atteggiamento verso le risorse e il territorio:
- il paesaggio addormentato, in trasformazione solo per processi di abbandono, trascurato nella sua manutenzione e in via di obliterazione nella memoria collettiva, anche se ancora dotato di risorse organiche e con una base materiale integra, che attende la comparsa di soggetti vitali per rimettere in moto processi economici; caratterizza i contesti dei centri storici abbandonati, delle reti di risorse culturali non emergenti, delle fasce rurali ritenute prive di chances economiche, con comunità abitanti ridotte al minimo e flussi di visitatori di nicchia;
- il paesaggio shangri-là, poco dotato di risorse di interesse generale, senza emergenze, nascosto ai flussi e poco comunicante con i territori vicini e con i “forestieri”, con uno stabile rapporto tra luoghi e abitanti, esclusivo rispetto alle novità (i luoghi possono anche profondamente modificarsi senza alterare i comportamenti bloccati degli abitanti); caratterizza le aree di pianura o di collina poco significative, spesso toccate dallo sprawl insediativo e dai processi di industrializzazione ma prive di una struttura urbana completa e distanti dai grandi flussi;
- il paesaggio consapevole, di dimensione e rilevanza delle risorse identitarie adeguate alla comunità allargata, cioè da una parte leggibile e utile per il senso di identità personale dei nuovi abitanti o dei visitatori, almeno nei suoi riferimenti simbolici, e d’altra parte capace di mantenere la propria identità storica metabolizzando il confronto con altre culture; ha un ritmo evolutivo di tipo inclusivo, in cui procedono di pari passo la considerazione culturale dei luoghi e la trasformazione dell’assetto fisico; caratterizza brevi periodi felici dell’evoluzione dei paesaggi urbani, quando le dinamiche culturali della comunità abitante corrispondono alla capacità adattativa di produrre segni e comportamenti equilibrati tra identità e novità;
- il paesaggio stressato, complesso e contraddittorio, prodotto anarchico di intenzioni sovrapposte e di processi degradanti il patrimonio precedente, in continua evoluzione, generatore di sensi di spaesamento che spesso affliggono le situazioni periurbane o con sviluppo insediativo recente;
- il paesaggio da inventare, definito per assenza: privo di identità e di utenza, prodotto da usi privatistici spesso degradanti le risorse materiali e da trasformazioni nascoste e lontane dall’immaginario collettivo; caratterizza i grandi insediamenti dominati da attrezzature industriali o logistiche, le aree abbandonate, i territori residuali tra paesaggi non inclusivi.
Ciascuno di questi tipi evolve in un altro in periodi più o meno lunghi, ma comunque lentamente abbastanza da apparire stabile agli occhi degli abitanti. Così ci si muove in un habitat condizionato da ciascuna fase evolutiva, che costituisce il milieu in cui ambientare i propri progetti e desideri.
Se si capiscono e si tiene conto di queste situazioni locali e condizioni temporali certo sarà più facile condividere strategie di azione con gli abitanti, trovare alleanze operative e imprenditori disposti a mettersi in gioco, piuttosto che proporre programmi con riferimento ad un paesaggio astratto e senza tempo.
I progetti strategici sperimentali possono trovare spazio se, sul luogo e nella fase data, riconoscono le risorse già esistenti e le iniziative che rispondono ad una potenziale domanda per il miglioramento della qualità della vita e dell’economia locale. Su questa base, di capacità locali anche minime ma autonome, è molto probabile trovare una sponda presso le istituzioni, indispensabile per legittimare e promuovere la crescita (non la nascita) dei progetti.
Il testo qui presentato ha costituito la traccia d’apertura di un seminario che è stato dedicato al Paesaggio nell’ambito di Art Lab10, il 2 ottobre 2010.
ArtLab realizzato dalla Fondazione Fitzcaraldo e dalla Regione Piemonte – è luogo d’incontro per eccellenza della comunità culturale interessata ad un confronto critico e senza reticenze su temi cruciali e di attualità per la gestione, l’economia e le politiche della Cultura; luogo dove operatori culturali, amministratori pubblici, imprenditori, artisti ed intellettuali di generazioni, ambiti e discipline diverse si ritrovano per parlare del ruolo della cultura in Italia e delle condizioni per la sua sostenibilità.
ArtLab 10, la quinta edizione, prendendo atto del contesto sempre più problematico con cui operatori culturali ed artistici devono confrontarsi, ha proposto una riflessione comune tra professionisti e decisori sul presente, per individuare idee, direzioni e strategie per il futuro per il rinnovamento delle politiche culturali, del management delle organizzazioni artistiche e culturali e il rilancio dell’imprenditoria culturale, al di là delle questioni di settore.
ArtLab 10 ha affrontato, con seminari specifici, temi di grande interesse ed attualità come: idee e strumenti per la sostenibilità, il paesaggio come risorsa per lo sviluppo, l’impresa sociale al servizio della produzione culturale, la mobilità di artisti ed operatori culturali e l’accessibilità per le persone con disabilità alle offerte culturali.
Al seminario Camera con vista hanno partecipato Enrica Borghi, Asilo Bianco, Ameno (NO), Fausto Carmelo Nigrelli, Sindaco di Piazza Armerina (EN), Ippolito Ostellino, Ente di gestione dell’Area protetta del Po torinese, Nicola Perullo, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (CN), Liliana Pittarello, per il Touring Club Italiano, oltre ad altri amministratori ed operatori locali.
I contributi e il vivace dibattito che è seguito hanno fatto emergere la straordinaria vitalità ed interesse suscitati del tema, ma anche l’isolamento di chi si prova in iniziative di “resistenza” e la difficoltà dare corpo e continuità a strategie che non siano il semplice diniego alle trasformazioni. Il leitmotiv che emerge dalle testimonianze dirette è la solitudine delle battaglie locali per mantenere questa o quella specificità, e la contraddizione degli enti, stretti tra una strumentazione vincolistica, in parte voluta e in parte subita, e la spinta a trasformare, in parte subita e in parte voluta. In ogni caso tutti hanno un comune denominatore: l’atteggiamento di accettazione di soluzioni mediocri, come se la migliore azione di governo fosse comunque alla meno peggio, ci si dibattesse per contenere i danni. L’impostazione del tema offerta dal seminario è sembrata aprire uno spiraglio nuovo rispetto alla posizione più diffusa: superare lo scetticismo di fondo di chi sostiene che “Per il paesaggio si sa cosa si teme e non si sa cosa si vuole”.