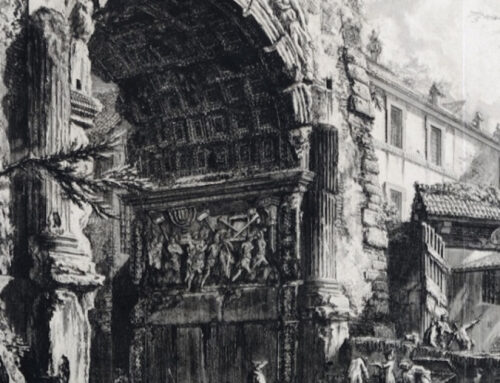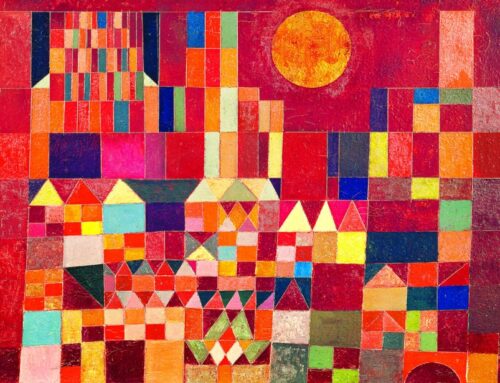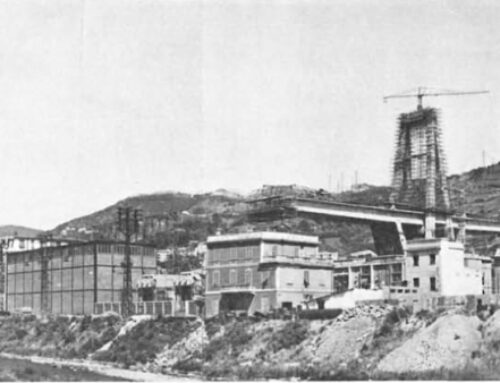Perché le più diverse discipline, politici ed operatori sociali e culturali riservano molte attenzioni al tema del paesaggio? Perché il paesaggio non è un affare privato di elites culturali o categorie professionali. Ma c’è una “questione del paesaggio” che interessa la società contemporanea e che investe l’azione politica, richiedendo acutezza e complessità non diverse da quelle che hanno caratterizzato per 50 anni la “questione urbana”.
L’evidente attenzione che esperti e specialisti delle più diverse discipline nonché, in misura crescente, politici ed operatori sociali e culturali riservano da qualche anno al tema del paesaggio, merita un tentativo di spiegazione. Il fatto che questa problematica rifletta preoccupazioni, attese ed esigenze che si riconoscono di comune e generale interesse, il fatto che il paesaggio non è, non può essere considerato un affare privato di singole accademie od elites culturali o categorie professionali. Il fatto cioé che esista una “questione del paesaggio” che interessa la società contemporanea e che investe l’azione politica, con acutezza e complessità non molto diverse da quelle che hanno caratterizzato da trenta o quarant’anni la “questione urbana”.
Il seminario internazionale di cui sono qui raccolti gli atti non è stato che una delle tante occasioni in cui, in Italia e all’estero e nelle sedi più diverse, si è discusso e si discute di paesaggio. L’evidente attenzione che esperti e specialisti delle più diverse discipline nonché, in misura crescente, politici ed operatori sociali e culturali riservano da qualche anno al tema del paesaggio, merita un tentativo di spiegazione, se si vuol cercare di capire in quale contesto problematico si situino le riflessioni qui raccolte. Chiedersi perché il tema del paesaggio sia diventato tanto e così largamente attuale può forse servire anche a chiarire gli scopi e l’utilità specifica del Seminario di Torino e del confronto interdisciplinare che, con esso, si è inteso avviare.
Può sembrare paradossale che un dibattito, che si annuncia ristretto agli specialisti, per lo più operanti in ambito accademico, prenda le mosse dalla constatazione della rilevanza politica e sociale della problematica paesistica. Eppure è proprio questo il punto di partenza: il fatto che questa problematica rifletta preoccupazioni, attese ed esigenze che si riconoscono di comune e generale interesse, il fatto che il paesaggio non è, non può essere considerato un affare privato di singole accademie od elites culturali o categorie professionali. Il fatto cioé che esista una “questione del paesaggio” che interessa la società contemporanea e che investe l’azione politica, con acutezza e complessità non molto diverse da quelle che hanno caratterizzato da trenta o quarant’anni la “questione urbana”.
Se si accetta questo punto di partenza, può diventare comprensibile il percorso logico proposto dal Seminario, sostanzialmente illustrato nell’ampia relazione introduttiva di Castelnovi. Esso profila una sequenza di interrogativi:
1, quali sono le ragioni d’attualità della questione paesistica? A quali sollecitazioni politiche e a quali domande sociali il mondo scientifico e culturale che si occupa di paesaggio dovrebbe tentar di rispondere?
2, perché la questione paesistica si presenta così culturalmente e scientificamente complessa? Quali apparati teorici consentono di affrontarla efficacemente? E soprattutto esiste o ha senso tentar di costruire “una teoria” del paesaggio?
3, che significato assume, per la società e per l’uomo contemporaneo, il paesaggio? E soprattutto esiste un senso comune del paesaggio, una capacità di condivisione dell’esperienza paesistica che solleciti la pubblica responsabilità?
4, che senso può avere, allora, il progetto di paesaggio? Quale specificità gli va riconosciuta in rapporto al progetto d’architettura, di città, di territorio?
È evidente che una simile sequenza implica una convergenza, dalle tematiche generali verso le responsabilità specifiche delle scuole d’architettura (come quella che non casualmente ha ospitato il Seminario) e delle discipline che accompagnano e sorreggono l’agire progettuale. Ed inversamente, tale sequenza implica l’intento di risalire costantemente dai problemi pratici del progetto alle preoccupazioni politiche e culturali più generali che tali problemi sottendono. Questa interazione reciproca, che tende a legare l’agire progettuale al discorso sociale, non è ovviamente pacifica e scontata. Essa rispecchia da un lato una concezione del mondo non neutrale, nostalgica o rassegnata, non scevra di attese di cambiamento e quindi di speranze progettuali; una concezione che si fonda su un’analisi critica dei processi in corso e che respinge l’idea di una conservazione statica e passiva del patrimonio di valori che la nostra società ha ereditato dalla natura e dalla storia, che induce invece a credere che, in generale, “non si possono lasciare le cose come sono”. Credere in quell’interazione significa, d’altro canto, assumere una concezione del progetto molto lontana dai giochi autistici dell’architetto (o dell’urbanista o del paesaggista) arroccato nell’autoreferenzialità o nell’arroganza dell’atto creativo, molto attenta invece a quell’“impegno civile” che già con le parole del Defoe (1697) doveva caratterizzare la “projecting age”; significa pensare il progetto immerso nelle turbolenze e nei conflitti dei processi sociali, capace di esprimere le responsabilità tecniche, scientifiche e professionali non meno che le ansie, le speranze e le paure delle comunità che vi si riconoscono. È in questa duplice concezione – destinata a conferire un significato non banale a due principi che hanno acquistato da qualche tempo, sotto la spinta della “svolta ambientalista”, un ampio riconoscimento a livello internazionale, quello di conservazione e quello di responsabilità – che trovano articolate motivazioni gli interrogativi sopra richiamati, su cui si è sviluppato il nostro seminario (maiuscolo?).
Nel tentativo di capire le ragioni attuali della questione paesistica, è difficile sottrarsi alla tentazione di cercarle nei mutamenti strutturali della società contemporanea. Con brutale schematizzazione, si potrebbe pensare che, come la “nascita” del paesaggio è stata posta in relazione con l’esordio del capitalismo (Cosgrove, 1984), così la sua crisi attuale, preludio di una “morte” annunciata o di una metamorfosi radicale, possa e debba essere posta in relazione con la crisi del capitalismo maturo, post-industriale e post-moderna. E in effetti molti aspetti della società tardo-moderna o post-moderna – che caratterizzano quell’”ampio e profondo cambiamento nella ‘struttura del sentire’” di cui parla D.Harvey, 1993) – sembrano trovare riscontro nelle domande e nelle preoccupazioni riguardanti il paesaggio. Sarebbe d’altra parte insensato sottovalutare le stringenti relazioni che legano la domanda di paesaggio ai processi di internazionalizzazione dei mercati e di globalizzazione delle dinamiche economiche, sociali e culturali, coi loro contradditori effetti di omologazione e modernizzazione unificante, da un lato, e di esasperata specializzazione, squilibri, diseguaglianze e disperata ricerca d’identità, dall’altro. Come nota A.Berque (1993), “la spettacolare crescita della domanda di paesaggio non è soltanto una deriva estetizzante di una società sazia; al contrario è il segno che l’uomo tende a riallacciare i suoi legami con la terra, che la modernità aveva dissolto”. La “grande illusione” che anima la domanda di paesaggio può essere, in altre parole, collegata all’ansia di riconciliazione con la propria storia e con la natura, che nasce come reazione ai processi di sradicamento e di deterritorializzazione, che tendono a cancellare ogni rapporto coi luoghi, e ai processi d’“urbanizzazione totale”, che tendono a cancellare ogni rapporto diretto con la natura. Da questo punto di vista, la “simulazione” implicita nell’attuale offerta di paesaggio (tipicamente nel marketing turistico: Raffestin, 1998) non sarebbe altro che l’estrema espressione di quella “naturalizzazione delle forme storiche” che percorre l’intero progetto della modernità, volta a legittimare e rendere socialmente accettabili i processi di modernizzazione in corso. L’attuale produzione paesistica, coi suoi stereotipi e i suoi meccanismi comunicativi, presenta in questo senso evidenti analogie con quelle operazioni “normalizzatricì di cui l’“invenzione” delle Alpi, con l’oggettivazione scientifica della loro conoscenza (De Rossi, 1998; Joutard, 1986), e, prima ancora e in ben diversi termini, il “landscape gardening” inglese (Gambino, 1989) costituiscono manifestazioni paradigmatiche. Ma, paradossalmente, è sulle attese e le paure determinate dalla “morte” del paesaggio (nell’ampio significato attribuitogli da Dagognet et al., 1982) che essa sembra costruire le proprie risposte.
Ma la questione paesistica, sotto la spinta delle critiche ambientaliste, va più in là: essa mette a nudo alcune contraddizioni fondamentali dei processi di sviluppo affermatisi soprattutto nella seconda metà di questo secolo, la loro intrinseca ed invincibile “insostenibilità”, cioé l’incapacità di protrarsi nel tempo senza mettere irreversibilmente a repentaglio la sopravvivenza del patrimonio di risorse trasmettibile alle future generazioni. La cancellazione del passato, delle memorie e delle eredità naturali e culturali, si associa inevitabilmente – nella prospettiva paesistica – alle minacce sul futuro.
L’interpretazione critica dei processi di sviluppo offerta dal paradigma paesistico non implica, di per sé, alcun vagheggiamento nostalgico di una mitica condizione pre-industriale e pre-moderna, anche se la tentazione di far coincidere la fine dei “bei paesaggi” con l’avvento dell’industrializzazione e la fine del mondo rurale è ricorrente (Greppi, 1991) nel dibattito contemporaneo. Essa induce certamente a prendere le distanze da quelle ideologie della modernità – più o meno connese all’hybris della cultura occidentale (Bateson, 1972) – che hanno impregnato la cultura tecnica, professionale ed ammnistrativa, assecondando l’illimitato e incondizionato sviluppo dei processi di “domesticazione” del mondo naturale, la sua progressiva trasformazione in sistemi interamente dipendenti dall’azione antropica e destinati quindi, quando tale azione si interrompe, ad entrare in crisi o collassare. Ma tale critica è sempre meno propensa a tradursi in una sterile difesa dello status quo, o nel vano inseguimento di una ecologia illusoriamente sottratta all’influenza antropica. Al contrario, il paradigma paesistico costringe a rivedere l’opzione conservativa, intendendola non più come limite allo sviluppo (secondo quella contrapposizione che pure aveva avuto, negli anni Settanta, una salutare funzione di contrasto politico e culturale), ma come sfida all’innovazione, anzi come il luogo elettivo dell’innovazione per la società contemporanea (Gambino, 1997). La conservazione del paesaggio non è pensabile che in chiave evolutiva: come già ammoniva il Bateson (1972), “se l’evoluzione senza conservazione è follia, la conservazione senza evoluzione è morte”.
Il ripensamento dell’opzione conservativa profilatosi in questi ultimi anni è stato certamente stimolato dalla tragica rilevanza dei processi d’abbandono, che hanno colpito tanti paesaggi rurali europei, mettendo in evidenza l’inefficacia delle misure puramente difensive od ostative nei confronti dei conseguenti effetti di degrado, destabilizzazione, dissesto e depauperamento. E’ questo che rende manifestamente inaccettabile l’idea di “separare le cose dal loro divenire” (Tiezzi, 1998). Più in generale, sembra evidente che il rilievo assunto dalla questione paesistica è direttamente legato al drammatico aggravamento delle condizioni ambientali, alla intensificazione ed alla diffusione pervasiva dei rischi e delle minacce ambientali. Sebbene la percezione sociale di tali rischi sia ancora largamente inadeguata e soprattutto incapace di produrre svolte radicali nell’azione politica, non v’è dubbio che il dibattito politico e culturale degli ultimi decenni ha registrato una crescente consapevolezza dei nessi che legano i problemi ambientali a quelli economici e sociali. Molti nodi sono venuti al pettine: e se da un lato la fragilità e la precarietà degli sviluppi in atto denunciano la loro incoerenza nei confronti delle attitudini e delle condizioni dei contesti ambientali in cui si manifestano, dall’altro sempre più spesso si avverte l’impossibilità di assicurare la stabilizzazione ecosistemica e la difesa efficace delle specificità ambientali in carenza di forme opportune di sviluppo economico, sociale e culturale, come da qualche anno avverte l’Unione Mondiale per la Natura (Iucn, 1996). I tentativi, ancora timidi ed embrionali, di individuare nuovi percorsi di “sviluppo sostenibile” hanno generalmente posto in evidenza intrecci complessi di interazioni tra i problemi economici e sociali dei sistemi locali e le esigenze di tutela ecologica ed ambientale. Sono questi intrecci a costituire attualmente il nucleo cruciale della questione paesistica.
In realtà, il paradigma paesistico coglie il punto di convergenza di due fondamentali orientamenti emergenti a livello internazionale. L’estensione, da un lato, del principio di conservazione, da singoli oggetti di speciale rilevanza (i monumenti, le cose d’interesse storico od artistico, i beni culturali), a realtà ampie e complesse come i centri storici o la “città storica” latamente intesa, all’intero territorio, nella globalità dei suoi valori storici e culturali (Carta di Gubbio: Ancsa, 1990). L’attenzione per il paesaggio si accentua in misura diretta di questa dilatazione del campo, che travolge progressivamente ogni frontiera spaziale ed ogni discriminante cronologica, allargando lo sguardo sui territori extraurbani, agricoli e naturali, e legando sempre più la sensibilità per il passato alle preoccupazioni per il futuro. L’estensione del principio di conservazione incrocia, d’altro canto, un orientamento non meno importante, che ha preso le mosse nell’ambito dei movimenti ambientalisti e della cultura della protezione della natura e che ha spostato via via l’attenzione dai problemi di protezione di singole specie o di singoli siti a quelli della tutela degli interi ecosistemi e del territorio globale. Il messaggio della “territorializzazione” delle politiche ambientali, che ha fortemente connotato la Conferenza di Rio (UN, 1992) e le successive principali occasioni di confronto internazionale, va in questa direzione. La sfida che si profila è quella di innescare strategie conservative che si calino nelle diverse realtà territoriali, misurandosi coi loro problemi economici e sociali, coinvolgendo le comunità locali ed incidendo sui modelli e processi d’utilizzazione delle risorse locali. Con schematizzazione certo eccessiva, si potrebbe osservare che mentre da un lato le politiche di conservazione del patrimonio sono sollecitate ad uscire dalle “isole costruite” interamente antropizzate per investire l’intero territorio, simmetricamente le politiche di conservazione della natura sono sollecitate ad uscire dalle “isole naturali” per investire anch’esse l’intero territorio. Sarebbe certo ingenuo pensare che questo duplice orientamento abbia cancellato quella aspra bipolarizzazione tra natura e cultura, tra physis e logos, che costituisce tuttora uno dei retaggi più ingombranti dell’età moderna e che trova nei contrapposti stereotipi del parco naturale e del centro storico la sua più vistosa espressione (la natura ghettizzata nei parchi, la cultura nei centri storici). E tuttavia su entrambi i fronti si osservano ripensamenti ed esperienze innovative che vanno in quella direzione: basti pensare ai nuovi orientamenti che si profilano nelle politiche dei parchi, anche in paesi, come quelli del Nord Europa o del Nord America, che, grazie all’abbondanza di spazi naturali vasti ed incontaminati, hanno maturato tradizioni di tutela che prescindono dalla stabile presenza umana (e che anzi in certi casi presuppongono l’espunzione di ogni influenza antropica); o, inversamente, all’importanza che anche in Italia le nuove politiche urbane e regionali tendono a riservare al paesaggio e all’ambiente naturale. Sotto l’ampio ombrello della “sostenibilità”, in particolare del programma d’azione riassunto nell’Agenda XXI (sottoscritta a Rio nel 1992), si colloca ormai una serie di esperienze diverse, dal “greening” urbano, alle rivisitate “greenbelts” e alle “greenways”, alle bonifiche e al recupero di vasti complessi minerari o industriali, alla rimodellazione paesistica del territorio extraurbano. E, nella misura in cui questo fecondo incrocio obbliga a riflettere sull’interazione dinamica e continua tra processi “culturali” e processi “naturali”, il paesaggio è chiamato in causa. Istanze di tutela del patrimonio culturale e di salvaguardia ecologica complessiva trovano così nella questione paesistica un terreno basilare di convergenza e di confronto. Un confronto, beninteso, non privo di conflittualità: ad esempio, la tutela della diversità biologica può, in determinate situazioni, confliggere con la tutela della diversità culturale che si manifesta nel paesaggio (non a caso nel recente documento approvato dai Ministri dell’UE, 1998, l’obbiettivo di tutela e valorizzazione della diversità paesistica è affiancato a quello della diversità biologica e non già ricompreso in esso).
A fronte di quest’ampia confluenza di interessi, non stupisce che la rilevanza “politica” del paesaggio abbia trovato, dapprima in alcune legislazioni nazionali, e poi anche a livello internazionale, formale riconoscimento. La Risoluzione sul paesaggio approvata nel 1998 dal Consiglio d’Europa (CE, 1998) non lascia dubbi sulla consacrazione giuridica del ruolo politico-culturale attribuito al paesaggio, quale “fondamento dell’identità culturale e locale delle popolazioni, componente essenziale della qualità della vita e espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale, ecologico, sociale ed economico”. È un’affermazione tanto più risolutiva in quanto si applica non già a particolari paesaggi, di speciale rilevanza “culturale” (la risoluzione non riguarda infatti soltanto i “paesaggi culturali”, se con questa espressione si intendono quei paesaggi in cui l’azione antropica sia stata particolarmente energica e trasformatrice), ma a tutta la variegata gamma delle configurazioni paesistiche che connotano il territorio europeo. Ed ancor più rileva ? la Risoluzione europea, ove si consideri il principio esplicitamente fissato secondo cui il paesaggio deve essere tenuto in conto sistematicamente in tutte le politiche urbanistiche, territoriali, agricole, sociali, economiche e culturali e nelle altre politiche settoriali capaci d’incidere su di esso. Siamo, com’è evidente, ben lontani da quelle concezioni sostanzialmente elitarie od edonistiche (la difesa di “pochi oggetti per pochi fruitori”, com’ebbe a dire l’Emiliani) che in Italia avevano trovato ospitalità anche nella L.1497 del 1939, per tanti altri aspetti importante e anticipatrice. Ma siamo anche lontani da quelle concezioni, riduttivamente appiattite sugli aspetti “naturalistici”, che avevano trovato espressione nelle (peraltro gloriose) tradizioni del “landscape planning” nordamericano. La consacrazione politica del paesaggio segna quindi inevitabilmente il tramonto di molte concezioni tradizionali e costringe la riflessione scientifica e l’elaborazione tecnica a misurarsi con la complessità della questione paesistica.
Il crocevia paesistico
Alla densità e varietà degli interessi confluenti nella questione paesistica non può quindi non corrispondere la complessità che essa presenta sotto il profilo epistemologico. Il paesaggio è da sempre – in particolare, dalla grande svolta humboldtiana a metà del secolo scorso – luogo di convergenza interdisciplinare, luogo d’incrocio di saperi, di discorsi e di giochi linguistici diversi. L’appello ad un’ampia gamma di contributi scientifici diversi costituisce uno dei tratti caratterizzanti del “landscape planning” nordamericano, soprattutto a partire dal vasto programma volto a “progettare con la natura” (“Design with Nature”, McHarg, 1969) messo a punto negli anni Sessanta. Anche l’esperienza italiana della pianificazione paesistica innescata dalla L.431 del 1985, nonostante la carenza di risultati pratici, testimonia il ricorso generalizzato alla ricerca interdisciplinare e, sempre più spesso, transdisciplinare per la comprensione ed il trattamento dei problemi paesistici. Lo stesso seminario cui si fa qui riferimento ne costituisce l’ennesima prova, non soltanto per la varietà dei contributi direttamente portati, ma ancor più per la varietà di quelli evocati, per l’amplissimo ventaglio delle aree tematiche inevitabilmente toccate.
Ma nello stesso tempo il tema del paesaggio è il luogo dei sentieri che si biforcano, nodo d’origine di direttrici e programmi diversi di ricerca, punto di tensione di interpretazioni e proposte progettuali diverse e non di rado confliggenti. Ciò sembra connaturato al carattere stesso del tema paesistico (“il paesaggio non è un cerchio chiuso, ma un dispiegarsi”, già per Dardel, 1952). Ma si deve constatare che scuole diverse, che si misurano da tempo col tema del paesaggio, hanno messo a punto apparati interpretativi, teorie e metodi d’analisi tra i quali è spesso difficile riconoscere rapporti di coerenza o anche soltanto possibilità d’intercomunicazione. Prima ancora della mancanza di un paradigma paesistico condiviso, si avverte la mancanza di un comune sistema di riferimento, o di definizioni comunemente accettate, persino nell’ambito di esperienze legate ad una stessa matrice legislativa, come la pianificazione paesistica italiana ex L.431/1985 (Gambi, 1986). Nel comprensibile sforzo di quell’approfondimento specialistico che consente di far avanzare le frontiere del sapere, sono stati spesso eretti recinti protettivi attorno ai diversi ambiti disciplinari, che possono dar l’impressione di una sorta di “lottizzazione” del paesaggio: ogni scuola si prende il “suo” paesaggio. Non di rado, le singole scuole difendono la propria visione del paesaggio come l’unica valida ed accreditabile, respingendo ogni contaminazione ed ogni confronto. Anzi, è curioso osservare che spesso – anche nel corso del seminario qui presentato – gli argomenti con cui si combattono determinati approcci teorici e metodologici sono gli stessi con cui questi sono sostenuti in alternativa ad altri: vedi ad esempio alcuni degli argomenti della polemica contro l’“imperialismo delle scienze della terra” (Quaini, 1998) che si trovano ribaltati nelle polemiche contro gli “approcci estetizzanti” (Conti, 1997). Il rischio del riduttivismo implicito nella “confinazione” dei programmi di ricerca sul paesaggio – o il rischio, per usare le parole del Tricart (1985) di “vedere gli alberi e perdere di vista il bosco” – è fin troppo noto sul piano teorico. E tuttavia occorre riconoscere che il trattamento della complessità della questione paesistica si presenta estremamente difficile non appena si tenta di andar oltre le metafore e le affermazioni di principio. Che cosa significa, nelle concrete realtà territoriali, restituire importanza all’identità ed alla qualità dei luoghi, alle specificità ambientali ed alle culture locali od ai processi endogeni di sviluppo, con approccio olistico e comprensivo? Esistono certamente teorie importanti, che consentono di dar risposte significative a domande come queste. Ma esiste o val pena di cercare una teoria generale del paesaggio, in grado di considerarne tutti gli aspetti più importanti? Fino a che punto può essere “condivisa” la questione paesistica? A quali condizioni la complessità del paesaggio può essere davvero gestita con approccio interdisciplinare?
Un tentativo di risposta non può che partire dalla constatazione del pluralismo delle matrici disciplinari storicamente impegnate nella ricerca e nella riflessione sul paesaggio: dalla geografia, alla geologia, alla geomorfologia, alla pedologia, all’ecologia, alle scienze naturali, all’agraria, all’economia, alla sociologia, all’antropologia, alla psicologia, alla semiologia, all’estetica, alla storia, alla storia dell’arte, all’architettura, all’urbanistica, all’analisi e alla pianificazione territoriale… Il ruolo delle diverse matrici è stato ed è peraltro assai diverso: essenzialmente orientato all’analisi per alcune e al progetto per altre, esso è soprattutto cambiato nel corso della storia anche recente ed è stato diverso nelle diverse culture. La differenza, sottolineata da Steiner (1998) tra landscape (landshaft, landschap, ecc.) e paesaggio (paysage, pajsage, ecc.) segna anche una marcata differenza nel peso assegnato alle diverse matrici disciplinari. Netta prevalenza dell’ecologia e delle scienze della terra nella cultura del “landscape”, anche per l’importanza dei rapporti col “land” alle radici della democrazia americana (Steiner, 1998), non disgiungibile dall’influenza profonda dei miti della natura, che segnano le origini specifiche della civiltà americana, preesistenti alla colonizzazione (Schama, 1995); netta prevalenza, almeno fino ad una certa data, della geografia e delle scienze umane nella cultura del “paesaggio”. Ma è innegabile il ruolo egemone assunto, anche nell’esperienza italiana ed europea e soprattutto a partire dagli anni Sessanta o Settanta, dalla Landscape Ecology, nel cui ambito confluiscono anche le tradizioni nordamericane del “landscape planning” (Steiner et al., 1988). Alla base del successo della Landscape Ecology vi è certamente il fatto che essa ha offerto un quadro teorico organico e sistematico, capace di “spiegare” in ampia misura, con l’analisi scientifica oggettiva, la fenomenologia paesistica. La fede nelle scienze esatte, che aveva consentito a McHarg (riprendendo le lezioni dei Leopold, degli Odum, di Angus Hill e di Philip Lewis: McHarg, 1966) di propugnare polemicamente l’“ecological determinism” contro gli orientamenti economicisti del “planning”, si è dimostrata vincente nei decenni successivi contro il confuso impressionismo degli approcci estetizzanti, il descrittivismo di certi approcci geografici o l’arbitrarietà progettuale della “landscape architecture”. Essa ha saputo allearsi alla contestazione ideologica della violenza implicita nel “maitriser la nature” (tipicamente in Marcuse), ha rimesso in discussione i fondamenti culturali della manipolazione estetica della natura (il “plaisir superbe de forcer la nature”, come diceva Saint Simon a proposito di Versailles), ha contrastato efficacemente l’“amenagement du territoire” guidato dalle logiche funzionaliste: in Italia, ha dato fiato alla riaffermazione delle ragioni della pianificazione (a partire dall’ambiente e dal paesaggio) contro le tendenze alla deregolamentazione selvaggia, all’“urbanistica contrattata” e alle “politiche per progetti”. Di più, l’orientamento ecologico ha sottolineato con forza quell’esigenza già richiamata di non staccare i paesaggi dal paese reale, i testi paesistici dal loro contesto ambientale.
Ma la visione sistemica offerta dalla Landscape Ecology, nonostante si presenti come un paradigma totalizzante (l’ecologia come quadro globale di riferimento), non sembra in grado di rispondere da sola agli interrogativi suscitati dalla questione paesistica, in tutta la sua complessità. Essa lascia nell’ombra alcuni aspetti chiave di tale questione, alcune dimensioni del paesaggio, la cui importanza è emersa con forza soprattutto negli ultimi decenni, stimolando nuovi approcci metodologici ed investendo altre matrici disciplinari.
1) La prima dimensione su cui il dibattito e la ricerca degli anni Ottanta e Novanta hanno richiamato l’attenzione è quella economico-sociale. Quest’attenzione non è di per sé in contrasto col quadro teorico della Landscape Ecology, che da C.Troll,1939, a Naveh, Forman, Godron e altri, fa riferimento esplicito alla presenza e all’azione dell’uomo (“nessun ecosistema potrà essere studiato senza fare riferimento all’uomo”, per McHarg,1981, p.110; e parole ancora più esplicite usavano Giacomini e Romani, 1982, p.59, affermando la necessità di “estendere i principi di tutela della risorsa naturale sino alle zone più antropizzate e di coinvolgere sempre più gli uomini nella conservazione della natura” (…) “mediante un processo integrato fra conservazione, ripristino delle espressioni naturali e programmazione delle attività umane”). D’altra parte non ci sono ecosistemi che non risultino almeno in parte modificati dalla cultura umana (Schama, 1995). Ma, prescindendo da certe pretese ambientaliste di distinguere il landscape dal “manscape” (cioè dal paesaggio umano), sarebbe difficile rintracciare nella maggior parte dei piani e delle ricerche basate sulla Landscape Ecology quell’attenzione per i processi sociali e produttivi che la gestione del paesaggio nella prospettiva dello sviluppo sostenibile comporta. In questa prospettiva, il terreno da esplorare – con strumenti più appropriati d’analisi – è quello che riguarda quell’intreccio complesso di interazioni e riverberazioni tra le dinamiche economiche e sociali ed i processi di trasformazione paesistica, che costituiscono lo “zoccolo duro” della questione paesistica. Un intreccio che investe le dinamiche globali: vedi ad esempio le preoccupazioni emerse a livello europeo per la scomparsa dei “paesaggi di piccola scala”- come i “bocages”, gli “hedgerow landscapes”, le nostre colture promiscue ecc. – sotto l’urto della modernizzazione e dell’industrializzazione agricola, assecondata dalle stesse politiche comunitarie (Ministry of Housing, the Netherlands, 1989). Ma l’intreccio si presenta in forme ancor più acute nelle dinamiche locali: come difendere il paesaggio delle Cinque Terre senza l’agricoltura? Come salvaguardare la diversità paesistica delle Alpi senza mantenere e rinnovare le attività agricole e pastorali? Come riqualificare i paesaggi peri-urbani senza intaccare gli attuali modelli d’uso dello spazio e del tempo? Sembra impossibile una tutela paesistica minimamente efficace se non si riporta al centro il ruolo dell’uomo in quanto “produttore” di paesaggio e non si affronta la separazione storicamente intervenuta tra il “produttore” e l’“abitante”. Se la tutela e il progetto di paesaggio si pongono a rimorchio dei correnti modelli economici e produttivi e delle loro tendenze evolutive, c’è anzi il rischio che si riducano ad un’azione “cosmetica”, decorativa (il “landscaping” stigmatizzato da Steiner, 1998, come figlio “bastardo” dell’architettura del paesaggio), concorrendo in fondo al consolidamento di quegli stessi modelli e di quelle stesse tendenze. Il problema è particolarmente evidente nel caso dei paesaggi agrari, sia in quanto paesaggi tipicamente “edificati” (vale a dire modellati dall’azione antropica in funzione di modelli e programmi precisi di utilizzazione colturale, secondo l’espressione che già il Cattaneo adoperò a metà del secolo scorso), sia in quanto particolarmente esposti ai cambiamenti strutturali degli scenari economici e sociali. Ma il problema è di portata generale: basta pensare alle aree turistiche (dove il turismo può rappresentare l’attività economica basilare per pagare le attività manutentive e consentire la sopravvivenza delle culture locali e, nello stesso tempo, la sorgente principale degli impatti ambientali e del degrado paesistico) o alle aree di antica industrializzazione da recuperare e bonificare: la radicale trasformazione paesistica avviata dall’IBA a Emscher Park nel cuore della Ruhr ha la sua chiave di volta nella promozione di un insieme complesso ed articolato di operazioni economiche, sociali e culturali.
2) La seconda dimensione del paesaggio di cui si avverte la crescente importanza riguarda gli aspetti storici e culturali. Anche questi non comportano, in linea di principio, ragioni di contrasto con la teoria e la ricerca ecologica, che hanno da tempo posto in risalto quanto la struttura e il funzionamento degli ecosistemi dipendano dalle vicende pregresse; d’altra parte la stessa prospettiva ecologica, nel pensiero di studiosi come Bateson o Lorenz, si dilata ad abbracciare anche i processi culturali. Tuttavia, non è certo nell’ambito della Landscape Ecology che si riscontrano i più promettenti sviluppi teorici e metodologici riguardanti questi aspetti, che anzi per alcuni (Romani, 1994) vanno ritenuti affatto estranei all’analisi ecologica. Il contributo della storia e della geografia storica si è rivelato per contro fondamentale soprattutto nel caso dell’Italia e di altri paesi europei, i cui paesaggi sono direttamente fondati sulla storia abitativa e su processi complessi di acculturazione (“memorie in cui si registra e sintetizza la storia dei disegni territoriali degli uomini”, come diceva il Sereni, 1961), indipendentemente dal fatto che l’uomo sia tuttora presente. Lo scavo dei palinsesti territoriali coi metodi dell’archeologia del paesaggio (Sereno, 1983) consente di portare alla luce i tratti profondi, le geometrie latenti, le regole trasformative dei testi paesistici, mentre la prospettiva storica illumina i processi soggiacenti, quel che non si vede e che è spesso più importante di ciò che è immediatamente afferrabile con lo sguardo (Gambi, 1961). D’altra parte il significato culturale del paesaggio – esplicitamente richiamato dalla Risoluzione del Consiglio d’Europa – va al di là delle sue stesse ragioni storiche. Non soltanto perché “anche i paesaggi che crediamo più indipendenti dalla nostra cultura possono, a più attenta osservazione, rivelarsene invece il prodotto”, ma anche perché, più in generale, la tradizione comune del paesaggio “è costruita su un ricco deposito di miti, memorie ed ossessioni” (Schama, 1995). I contributi dell’antropologia culturale, della sociologia ambientale e della geografia umanistica, che implicano “il definitivo superamento, nella cultura europea, della tradizionale contrapposizione tra mito e logos” (Quaini, 1992), si ricollegano peraltro al pensiero fondativo del paesaggio geografico, secondo il quale “per abbracciare la natura in tutta la sua sublime maestà non basta attenersi ai fenomeni esterni, gli è d’uopo mostrare com’essa si riverberi all’interno dell’uomo e come in virtù di questo riflesso essa talora popoli di leggiadre immagini i campi caliginosi dei miti, talaltra sviluppi il nobile germe delle arti” (Humboldt, 1860, II, p.2). È da allora che il significato culturale del paesaggio va colto in riferimento non soltanto alla “sentina fabularum” costituita dalle opinioni e dalle concezioni del mondo che precedono ed orientano l’esplorazione e la ricerca, ma anche al rapporto dinamico e continuamente rinnovato tra la ricerca e l’invenzione (il Nuovo Mondo propriamente “inventato” da von Humboldt nel quadro della cosmografia coeva). È in questa larga accezione che va inteso anche il pensiero di Simmel (1912) per cui “il paesaggio non è ancora dato quando cose di ogni specie si estendono, una accanto all’altra, su un pezzo di terra e vengono viste immediatamente insieme”, ma è “un vero e proprio processo spirituale che solo trasforma tutto questo e produce il paesaggio”. O in altre parole è questo il significato pregnante di espressioni come quella secondo cui “ogni paesaggio è un’elaborazione culturale di uno specifico ambiente naturale” (Sereno, 1983), o come quella secondo cui i paesaggi sono natura adattata dalla cultura (che a sua volta è natura umana modificata dalla tecnologia: Steiner, 1998).
3) Questo ci accosta ad una terza dimensione del paesaggio, quella semiotica ed estetica, che, del tutto assente dall’analisi ecologica, è forse quella su cui si è registrato negli ultimi anni un più vivace risveglio d’interesse. Se si riconosce il ruolo culturale del paesaggio – di ogni paesaggio, indipendentemente dalla qualità dei suoi contenuti culturali – è perché lo si considera come un processo di significazione (Barthes, 1985) e, quindi, come un fenomeno di comunicazione sociale (Eco, 1975). Di per sé, il riconoscimento del ruolo culturale e della funzione estetica del paesaggio non è certo una novità. Il paesaggio occupa infatti un posto di rilievo nella storia dell’arte (Clarck, 1976) e persino le sue descrizioni più primitive, come i graffiti preistorici, sono state interpretate come espressioni artistiche ed insostituibili testimonianze “culturali” (Jellicoe, 1987). In particolare in Italia l’assimilazione crociana delle “bellezze naturali” alla bellezza artistica, nell’unicità della comunicazione poetica, è alla base della legislazione di tutela paesistica (L.778/1922, L. 1497/1939) che, con le successive integrazioni, è tuttora in vigore. Ed anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, soprattutto a partire dagli anni Settanta, l’interesse per i valori estetici del paesaggio (o più precisamente per quelli “scenici” o visivi) ha stimolato una vasta produzione di piani e di ricerche. D’altra parte la consapevolezza dell’irriducibilità del giudizio estetico nella comprensione paesistica si inquadra in quel “ritorno all’estetica (verso una scienza che conservi i valori)” (Tiezzi, 1998, p.19) che ha da tempo assunto un significato assai più vasto.
Ma l’interpretazione semiologica del paesaggio (per quanto ancora “timida e temeraria”: Barthes, 1966) pretende molto di più. Se infatti si riconosce il duplice fondamento – naturale e culturale – dell’esperienza paesistica, occorre anche riconoscere che il sistema segnico costituito dalla sostanza sensibile del paesaggio non può in alcun modo tradursi in un insieme “dato” di significati: la semiosi paesistica è un processo sempre aperto (Dematteis, 1998). Un processo tanto più aperto in quanto le dinamiche trasformative staccano i segni dai loro significati originari, allargando progressivamente gli spazi d’ambiguità delle trame storiche (Olmo, 1991) su cui si costruisce l’esperienza paesistica, accentuando il distacco tra le tracce e il progetto (d’altronde, come nota Derrida, 1998, citato in questo stesso volume da Isola, “la traccia si rapporta a ciò che chiamiamo il futuro non meno che a ciò che chiamiamo il passato”). La dinamica delle cose – l’ecosfera – è inseparabile dalla dinamica dei significati – la semiosfera – e quindi dai processi sociali in cui questa si produce (Dematteis, 1998). Ma, se questo è vero, allora il paesaggio non può essere quello, cognitivamente perfetto (Socco, 1998a), che le scienze della terra tendono a proporci. Esso è spazio di semiosi aperta, non racchiudibile nelle semiosi scientifiche delle varie discipline. La sua complessità si manifesta, ben prima che nella pluralità dei contenuti, nell’insopprimibile apertura dei processi di significazione che riesce ad attivare, nella molteplicità ed imprevedibilità degli approdi semantici. È in questa dinamica apertura che si collocano e debbono essere indagate le sue funzioni simboliche e metaforiche, i suoi depositi mitici e memoriali, le sue funzioni narrative e le sue funzioni propriamente estetiche. È in questa direzione che alcune stimolanti equazioni ancora recentemente proposte acquistano forse più preciso significato. Così, se il paesaggio è teatro (Turri, 1997), non è tuttavia un teatro “dato”, con le sue scene fisse e i suoi fondali immobili, dove soltanto gli attori e gli spettatori possono cambiare; l’autorappresentazione, che consente agli attori locali di “prendere le distanze” dalle vicende rappresentate diventando spettatori di se stessi, ricostruisce continuamente il teatro stesso o almeno il significato che esso assume per chi partecipa in vario modo all’azione teatrale. Così anche, se “il paesaggio è natura che si rivela esteticamente” (Ritter, 1994), la contemplazione estetica che ci consente di definirlo (Isola, 1998) non può tradursi né in una chiusura autistica e solitaria (che isolerebbe l’esperienza individuale dal processo di significazione e dai suoi rapporti coi processi sociali del contesto), né in un rito preordinato ed in qualche modo imposto, come nei modelli stereotipati della fruizione turistica.
Il significato del paesaggio
a. Polisemia e comprensione olistica.
Le tre linee di ricerca sopra ricordate (in varia misura rappresentate nel seminario qui illustrato) sono sufficientemente indicative di sollecitazioni scientifiche che non possono trovare adeguato riscontro né, da un lato, nelle matrici teoriche e nei quadri concettuali più consolidati, quale quello della Landscape Ecology, né, dall’altro, nel semplice allargamento del ventaglio di discipline coinvolte dalla questione paesistica. Non si tratta tanto di considerare qualche aspetto in più, ma di ripensare l’intera questione paesistica in termini più complessi. Se questo è vero, ecco una prima parziale risposta all’interrogativo che ci eravamo posti, se sia utile e possibile tentare di costruire una teoria generale del paesaggio e come altrimenti sia possibile affrontare olisticamente la complessità del paesaggio. Allo stato attuale, si può avanzare un’ipotesi “debole” eppure già molto impegnativa: che sia possibile ed opportuno “mettere in rete” le diverse interpretazioni e ricercare la massima interazione tra le diverse linee di ricerca, in modo che possano arricchirsi a vicenda. Questa ipotesi, se da un lato consente di rispettare il pluralismo degli approcci disciplinari, dall’altro richiede però che siano individuati i punti d’incrocio e di convergenza e che siano stabiliti gli “accordi linguistici” necessari all’intercomunicazione. È interessante notare che, in parte, questo è precisamente ciò che già si fa o si tenta di fare nelle esperienze innovative di pianificazione paesistica: ad esempio, col ricorso a “griglie valutative trans-settoriali” che ospitino la confluenza e favoriscano l’interazione delle analisi valutative operate nell’ambito delle diverse discipline (Gambino, 1996, 1997). Ma qui si ipotizza qualcosa di più e di diverso: la possibilità cioè che la fertilizzazione incrociata delle linee di ricerca retroagisca sugli apparati concettuali e sui quadri interpretativi messi a punto nei diversi ambiti disciplinari, in modo che i diversi contributi possano concorrere più efficacemente alla comprensione olistica del paesaggio. Questa ipotesi rispecchia l’idea che esista o possa esistere un interesse comune al trattamento della questione paesistica; che il paesaggio assuma o possa assumere un significato complessivo, per la società contemporanea, tale da investire la pubblica responsabilità e da richiedere un impegno collettivo. È un’idea confortata dalla consacrazione politica decisa dal Consiglio d’Europa. Ma qual’è questo significato?
La domanda è tutt’altro che banale, visto che non c’è accordo tra le diverse discipline e neppure al loro interno su ciò che col termine di paesaggio (o col quasi-equivalente termine inglese) si debba intendere. Nel corso del Seminario sono state richiamate alcune delle tante definizioni proposte dalle diverse scuole, che non è qui il caso di ricordare. Sembra tuttavia rilevabile una larga convergenza nel riconoscere che, anche al di là delle gabbie teoriche tuttora utilizzate, l’esperienza paesistica abbia un duplice fondamento – naturale e culturale – e che nel paesaggio si incrocino inevitabilmente ecosfera e semiosfera (Dematteis), o geosfera-biosfera e noosfera-gnoseosfera (Calzolari). Questo riconoscimento non attenua ed anzi accentua le ambiguità e le tensioni interpretative inerenti il concetto stesso di paesaggio.
b. Soggettività ed oggettività
Anzitutto non si può prescindere dalla sua ambiguità intrinseca (quella che Farinelli, 1991, chiama l’“arguzia”), quel suo alludere insieme ad un pezzo di terra ed alla sua rappresentazione, alle cose e alla loro immagine, alla “res extensa” e alla “res cogitans”. È un’ambiguità che non va confusa con le incertezze semantiche del termine, e che appare utile e feconda (Gambino, 1994a) proprio perché mantiene aperto e metaforico il significato del paesaggio, respingendo le seduzioni oggettivanti delle scienze della terra e di un certo storicismo, senza pretendere la regressione al puro visibilismo estetizzante o all’impressionismo ascientifico. Essa richiama l’attenzione sui rapporti tra processi reali e processi di percezione e di rappresentazione, con scoperto richiamo ai meccanismi di “bisociazione” studiati dal Koestler, 1964 (l’ironia del Don Chisciotte, fondata sull’endemico doppio senso e sul confronto continuo di realtà e fantasia), alle trasposizioni poetiche della pittura di paesaggio fino agli artifici del “Claude-glass” usato nel Settecento (Schama, 1995) ed ai trompe l’oeil di Magritte.
Ma proprio quest’ambiguità costringe a confrontarsi con la tensione ineliminabile tra soggettività ed oggettività del paesaggio. Il dualismo paese/paesaggio o luogo/rappresentazione (Dagognet, 1982) richiama inevitabilmente questa tensione, che sfida le certezze e le ansie d’oggettivizzazione dell’approccio scientifico e che si manifesta a più livelli. Naturalmente, è la stessa oggettività dell’osservazione scientifica a dovere essere messa in dubbio, in questo come in altri campi d’analisi. L’idea che il paesaggio possa costituire l’oggetto immobile ed inerte di un osservatore neutrale e disinteressato, in grado di coglierne con assoluta oggettività l’essenza, è stata ed è indubbiamente utile a legittimare politicamente e giuridicamente l’azione di tutela. Come si ricorderà, il carattere ri-cognitivo delle attribuzioni di valore operate con la pianificazione paesistica sviluppatasi in Italia dopo la L431/1985 le distingueva nettamente dai vincoli conformativi derivanti dalle tradizionali scelte urbanistiche, anche sotto il profilo della non-indennizzabilità dei vincoli di tutela. Ma è un’idea che risulta sempre più difficile conciliare con l’evoluzione del pensiero scientifico contemporaneo, con la crescente consapevolezza dell’intrinseca fluidità e provvisorietà di ogni avanzamento conoscitivo e dell’inevitabile dipendenza di ogni giudizio valutativo dai pre-giudizi dell’osservatore e dai sistemi di preferenze del contesto sociale. Si può discutere se, come è stato osservato (Todorov, 1990) lo sgretolamento delle certezze e la perdita d’innocenza delle conoscenze scientifiche rifletta lo scontro tra i “monologhi” delle scienze della natura e il “principio dialogico” delle scienze sociali. Ma, più specificamente, molti dubbi possono essere avanzati circa la possibile autonomia dell’osservazione scientifica di fronte alla natura stessa dell’esperienza paesistica. L’idea che possa esistere un sapere scientifico in qualche modo separato e diverso dalle varie forme di esperienza e conoscenza paesistica sembra implicare una concezione estremamente riduttiva del significato del paesaggio per la società contemporanea. Ridotto a realtà oggettivabile e neutralmente quantificabile, il paesaggio perderebbe il suo significato primario di “processo interattivo, osservazione incrociata tra idee e materialità” (Bertrand, 1998). Mediazione simbolica tra società e territorio, il paesaggio lega la coscienza storica e le memorie collettive alle attese e ai progetti di cambiamento dello spazio sociale. “In questo senso, il paesaggio è il luogo privilegiato d’una riflessione tendente ad includere in una stessa problematica differenti modalità di conoscenza, estetica, scientifica, ordinaria” (Mondada et al.,1992).
c. Ipertestualità e senso comune
Questa considerazione induce a spostare l’attenzione, dalla soggettività inerente l’osservazione scientifica disinteressata, a quella inerente il fruitore, direttamente impegnato nell’esperienza paesistica. È questo un tema su cui sembra addensarsi una nube cospicua di interrogativi, strettamente legati alle peculiarità di tale esperienza. Al fatto, certamente, che si tratta di un’esperienza plurisensoriale: se è vero che il paesaggio visivo la fa da padrone e “la visualità è il mezzo più importante con cui la gente interagisce con ciò che la circonda” (Steiner, 1998, che cita Tuan, 1974, secondo cui siamo essenzialmente animali visivi), studi recenti sul paesaggio sonoro attestano il ruolo fondamentale che esso svolgeva anticamente, nei sistemi d’intercomunicazione sociale (Giametta et al., 1998; Anzani, 1993). Ma ciò che conta soprattutto è il fatto che il paesaggio circonda il fruitore, lo forza a partecipare, lo costringe ad una percezione attiva (Zube et al., 1982), lo obbliga a scegliere di continuo (la fruizione come viaggio, o come navigazione): a scegliere almeno il punto di vista, indispensabile perché il paesaggio possa esistere (Caprettini, 1998), quando non addirittura “costitutivo” (come nelle grandi marine del paesaggio realistico olandese del ‘600: Clarck, 1976). E proprio questa libertà intrinseca dell’esperienza paesistica, questa dipendenza della fruizione dalle scelte dell’utente, questa multidirezionalità della lettura favorita dalla “straordinaria compresenza di dati testuali, di racconti, di documenti, di derive, di biografie, di repertori” (Pavia, 1996) che si profila nella prospettiva post-moderna, insomma questa “ipertestualità” implicita in ogni testo paesistico (Cassatella, 1998), sembra portare alle estreme conseguenze la soggettività di tale esperienza, sembra prefigurarne una radicale irreversibile atomizzazione. Nomadismo e sradicamento caratterizzerebbero la navigazione solitaria di ogni singolo fruitore, sottratta ad ogni regola di concordanza e di intercomprensibilità, sempre totalmente “straniante”: una logica perfettamente corrispondente a quella che guida le rappresentazioni offerte dai GIS, prive, a differenza delle carte tradizionali, di centro e di prestabiliti punti di vista, atte a descrivere uno “spazio di flussi” totalmente deterritorializzato. Ma il paesaggio può davvero disperdersi in una miriade incoerente di esperienze individuali? Un paesaggio così atomizzato avrebbe ancora “senso”? O non sarebbe precisamente questa l’annunciata “morte del paesaggio”? Può il paesaggio rinunciare ad ogni “principio d’ordine”, se persino la sua funzione estetica, in quanto forma privilegiata di comunicazione sociale, risponde antropologicamente ad una tendenza all’ordine e alla “pregnanza” (Eibl-Eibesfeldt,1994), se la sua stessa “leggibilità” presuppone l’iscrizione di un codice nella materialità dei luoghi?
L’ipertestualità implicita nei paesaggi della post-modernità non impone la rassegnata accettazione di ogni perdita di senso. Al contrario, si può ritenere che il paesaggio sia chiamato a svolgere oggi più che mai quella essenziale funzione di “orientamento” che già il Lynch (1971) aveva messo in evidenza. Se è vero che il paesaggio è un passaggio obbligato per la comprensione del mondo, forse il suo ruolo consiste proprio nel manifestare quella “concordanza” che fà sì che gli uomini “non abitino ciascuno nel proprio isolotto”, creando legami che ci uniscono attraverso “il nostro contatto muto con le cose, quando esse non sono ancora dette” (Merleau Ponty, 1993, citato in Dematteis, 1998). La pluralità, apertura ed imprevedibilità dei significati offerti dai testi paesistici non impediscono di cogliere, come sottolinea Dematteis, un “senso comune” del paesaggio (o anzi del “proto-paesaggio”, per seguire Berque, 1995), che “crea un legame silenzioso e latente tra ogni individuo e gruppo sociale ed il resto del genere umano e dei suoi ambienti geografici”, un senso di appartenenza potenzialmente globale (“global sense of place”: Massey, 1993, citato da Dematteis, 1998) che si oppone efficacemente alle tendenze omologatrici in corso.
d. Identità ed alterità
È da questo senso comune, per quanto difficile da precisare, che conviene forse partire per affrontare un’altra tensione fondamentale dell’esperienza paesistica, quella tra identità e alterità, diversità e interculturalità. Nella ricerca e nella pianificazione paesistica degli ultimi decenni il tema dell’identità occupa un posto di rilievo. Esso evoca l’attenzione per le peculiarità geomorfologiche ed ecologiche locali (anche in termini di biodiversità), per le specificità storiche, estetiche e culturali (lo “statuto dei luoghi”), per i sistemi di relazioni che legano localmente determinati gruppi o comunità ai territori in cui abitano o svolgono le proprie attività. A torto o a ragione, il paesaggio è stato inteso come spazio dell’identità, chiamato a svolgere un ruolo di aggregazione difensiva e di contrasto nei confronti di tendenze trasformatrici e di processi di sviluppo eterodiretti che erodono le radici, le memorie e la stessa riconoscibilità delle comunità locali. Sotto l’ampia bandiera dello sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle identità paesistiche locali si è saldata ai tentativi di consolidamento, rinascita o promozione dei sistemi economici locali, capaci di battere le strade dello sviluppo endogeno ed auto-organizzato. La contrapposizione tra le visioni e gli interessi degli insider e quelli degli outsider – già ben argomentata in prospettiva storica dal Cosgrove, 1984 – ha così assunto una forte enfasi politica, economica e socioculturale. Non sono mancati riscontri nel marketing turistico (con l’utilizzazione strumentale degli stereotipi paesistici), come pure nel marketing urbano e territoriale (nel quadro della valorizzazione del capitale simbolico e dell’appeal ambientale). Non si può neppure negare che la strenua difesa della propria diversità e dei propri sistemi d’appartenenza, contro la violenza soppraffatrice delle tendenze globalizzanti, possa alimentare lo spirito d’esclusione, le chiusure localiste (i “ponti levatoi” che si calano alla sera a proteggere certe comunità nordamericane da possibili “incursioni”), l’appello a nuove forme di violenza (Isola, 1998), com’è tragicamente evidente nelle “identità armate” (Remotti, 1996) che si manifestano nel panorama internazionale. Ma, più in generale, è necessario articolare più complessamente il tema dell’identità. Al centro dell’attenzione c’è il rapporto intrigante tra identità e alterità e quindi tra i luoghi in cui si coglie l’identità e le reti lungo le quali si incontra l’alterità. L’identità si costituisce sulla diversità e presuppone quindi l’alterità (Castelnovi, 1998; Remotti, 1996); e, così come identità e alterità sembrano rappresentare due polarità complementari e mutuamente irriducibili dell’esperienza paesistica, luoghi e reti sembrano legati da una complementarietà indissolubile (Gambino, 1994b). Questa complementarietà è alla base di ogni possibile tentativo di articolazione dei testi paesistici, in particolare di riconoscimento di “unità di paesaggio”, distinguibili l’una dall’altra proprio perché dotate di una propria identità e di una propria interna coesione. Negli studi per il Piano Paesistico Territoriale della Valle d’Aosta o in quelli del Piano del Parco dei Colli Euganei, le unità di paesaggio sono definite come ambiti caratterizzati da specifici sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e percettive) tra componenti eterogenee, che conferiscono loro un’identità riconoscibile che li distingue dal contesto. Il riconoscimento dell’identità é basato sull’esperienza dell’altrove e del diverso (Telaretti, 1997), così come l’apprezzamento della diversità presuppone la capacità di leggere, riconoscere e quindi distinguere le diverse identità. Inversamente, i sentimenti d’identità e d’appartenenza staccati dalla sensibilità per la diversità inducono a chiusure nostalgiche e regressive e a comportamenti d’esclusione, così come la ricerca dell’altrove e del diverso, staccata dall’attenzione per le identità specifiche e locali, induce all’omologazione e alla colonizzazione repressiva, fondata sulla virtualizzazione dell’esperienza paesistica (i paesaggi inventati dal marketing turistico sono “paesaggi illusori, attraversati, non abitati”: Raffestin, 1998). Ma questo implica che:
- il problema dell’identità non riguarda soltanto gli insider, gli abitanti o gli attori locali, ma anche gli outsider, gli osservatori e i “landscape users”, nella misura in cui sono impegnati nell’esperienza del diverso (come tipicamente nel caso del turismo);
- l’esperienza paesistica è soggetta a rilevanti cambiamenti, nella misura in cui la crescita della mobilità e delle opportunità di comunicazione, di scambio e di confronto riduce od incrina il radicamento territoriale e trasforma gli stessi abitanti ed attori locali in “landscape users”, in “turisti a casa propria”.
Non v’è dubbio che “di fronte all’onda di piena di un turismo totalmente indifferente ai segni e ai valori”, il ruolo centrale dell’abitante-produttore locale nella costruzione e nella manutenzione del paesaggio debba essere gelosamente difeso (Quaini, 1998); questa difesa è anzi ancora più importante se si tien conto della complessiva dimensione economica e sociale della questione paesistica, richiamata nel par. 2.2.. Ma è anche vero che la difesa dei caratteri identitari non può essere pensata come un affare privato dei locali, ma come una responsabilità più ampia che riguarda chiunque possa prendersene cura (i “care-takers”: Poli, 1998) e in particolare chi vi si accosti con piena consapevolezza del loro valore distintivo (Castelnovi, 1998). La disputa che qualche anno fa oppose Messner, che a nome di Mountain Wilderness, appeso alle funi della funivia dei ghiacciai, reclamava una miglior tutela del Monte Bianco, al Presidente della Regione Valle d’Aosta, che ne rivendicava l’appartenenza alle comunità locali, è sufficientemente emblematica. Anche l’importanza crescente accordata all’esperienza del viaggio e dell’attraversamento nella fruizione paesistica risulta giustificata, purché non si dimentichi il significato primigenio del viaggio, come scoperta e conoscenza di luoghi e di realtà culturali dotate di una propria specifica identità: vale qui la distinzione metaforica di Kundera tra il chemin, che invita a fermarsi, e la route che invita a spostarsi (Quaini, 1998). È in questo senso che, sulla scia dei mutamenti profondi nelle modalità dell’abitare contemporaneo, il paesaggio – come la realtà speculare, la città – sembra destinato sempre più a qualificarsi come lo spazio dell’interculturalità (Castelnovi, 1998), del confronto e della contaminazione, del conflitto e dell’arricchimento reciproco.
Quali progetti per il paesaggio?
La domanda di paesaggio che si avverte nella società contemporanea non è soltanto il frutto della nostalgia e della sfiducia nel futuro, ma riflette, pur tra molte contraddizioni, il bisogno di riprendere il contatto coi luoghi e di “ri-abitare la terra”, riscoprendone i valori identitari (naturali e culturali), rispettandone e valorizzandone le diversità. Nonostante la varietà degli interessi, delle sensibilità e delle attitudini culturali, sembra maturare una preoccupazione largamente condivisa circa i processi di degrado e trasformazione che contrastano quel bisogno: una preoccupazione che investe le responsabilità pubbliche nella gestione e nella pianificazione del territorio, cui si richiede di partire dal riconoscimento esplicito di tali valori. L’analisi scientifica e la pianificazione del paesaggio hanno perciò assunto questa fondamentale funzione ri-cognitiva. Ma, come si è notato, non esiste una ricognizione neutrale e realmente oggettiva, ogni giudizio valutativo riflette pre-giudizi, intenzioni e preferenze, nasconde un progetto. Questo è particolarmente vero per il paesaggio, che sollecita il fruitore ad una percezione attiva ed esprime, nel contempo, un ordine intenzionale, seppur leggibile e fungibile in una pluralità di modi. Il ciclo idea-conoscenza-interpretazione-giudizio-progetto (Calzolari, 1998) viene continuamente percorso nei due sensi. Esiste una dimensione progettuale da cui nessuna esperienza paesistica può realmente prescindere. Non c’è paesaggio senza progetto (Bertrand, 1998).
Ma, se è vero che il paesaggio non è mai “dato”, perché il suo significato e i suoi valori si definiscono nel presente, in funzione delle paure, delle attese e delle intenzioni del suo contesto sociale; se è vero che non esiste un “genius loci” veramente indipendente dal modo con cui i luoghi son visti e considerati dai loro possibili abitatori-utilizzatori; se è vero che “la felicità che possiamo trarre dai nostri luoghi, dobbiamo essere noi a porla in essi” (Isola, 1998); qual’é il ruolo concreto del progetto? Un dilemma paradossale sembra imprigionare il progetto di paesaggio: quanto più efficacemente esso interpreta gli spazi di libertà e di creatività del paesaggio, sforzandosi di dar senso ai suoi sistemi di segni e di riorientare i processi che lo animano, tanto più rischia di irrigidire l’esperienza paesistica in un ordine prefigurato, di anticipare l’imprevedibile e l’inaspettato, di fissare ciò che non può essere fissato, di chiudere un discorso che deve restare aperto, o addirittura di dire l’indicibile, violandone il mistero. Certo, un paesaggio non è un giardino. Ma il dilemma non riguarda soltanto la dimensione semiologica, estetica o culturale del paesaggio: esso, a ben vedere, si ripropone nella dimensione ecologica ed in quella economica e sociale (come innescare processi innovativi nei sistemi locali, scontando l’autonomia e l’imprevedibilità delle loro reazioni agli stimoli esterni?). Né il dilemma può essere fugato rifugiandosi nella sacralità perenne della sua essenza costitutiva, poiché anche il sacro e l’arcano si manifestano nell’attualità della cultura contemporanea.
Per uscire dal dilemma del progetto, è necessario ripensarne il ruolo nell’intero ciclo di produzione ed uso del paesaggio, partendo dall’osservazione che un’efficace assunzione di responsabilità progettuale (che in particolare respinga la rassegnazione a “lasciar le cose come sono” e il relativismo imbelle per cui “tutto è lo stesso”, come ammonisce Isola) non è obbligata a tradursi in arroganza pianificatoria o in violenza tecnocratica. Al contrario, la responsabilità di ridar senso e qualità agli spazi abitativi e di riorientare i processi con cui la terra diventa territorio, comporta la capacità di reimparare a “contestualizzare” l’agire progettuale, a coglierne e misurarne l’incidenza su dinamiche complesse, che – come l’esperienza quotidiana dimostra – possono sempre più spesso assumere caratteri distruttivi o propriamente catastrofici. L’umiltà nei confronti di quel “qualcosa di infinitamente più esteso e fluttuante” (Simmel, 1912), che continuamente si intreccia con le realtà specifiche su cui si concentra il progetto, l’umiltà nei confronti del tempo (dei tempi lunghi della natura), non riduce ma accentua le responsabilità del progetto: non costringe a subire il determinismo ambientale, ma induce a progettare “con la natura” come chiedeva McHarg, o, più comprensivamente, a “collaborare con la terra e col tempo”, per usare la bella espressione che M.Yourcenar mette in bocca a Adriano. Una maggior coscienza storica ed una maggior consapevolezza ambientale sono oggi necessarie se si vuol evitare che l’“impeto prometeico” che (secondo la fiduciosa immagine del Gottmann, 1970) ha alimentato nei secoli l’avventura urbana, possa corrodere i territori in cui viviamo e distruggere il pianeta.
Questa difficile coniugazione di coraggio ed umiltà sposta certamente il rapporto ermeneutico del progetto con la “comprensione”, accentua il ruolo delle “descrizioni fondative” e dei “racconti identitari” nell’orientare i processi di pianificazione (Quaini, 1998) sulla base delle attese e dei progetti collettivi che maturano localmente. Nell’esperienza più recente di pianificazione paesistica è facile constatare che all’indebolimento della funzione “normativa” corrisponde l’enfasi sulla funzione retorica ed argomentativa, sul ruolo che le descrizioni orientate, le analisi valutative e le stesse immagini progettuali possono svolgere nella comunicazione sociale ed in particolare nei processi d’aggregazione identitaria. Sembra diffondersi l’idea che la forza del progetto di paesaggio non risiede nella sua “vis cogendi” – anche se esso non può sottrarsi ad una funzione regolativa che è oggi reclamata a gran voce dagli stessi operatori economici – ma nella sua capacità di animare ed orientare il confronto sociale, di stimolare interessi, di evidenziare le poste in gioco, le sinergie attivabili e gli esiti prevedibili delle scelte possibili.
Più ancora della pianificazione urbana e territoriale, quella paesistica sembra necessariamente inscriversi in quella prospettiva dialogica e cooperativa, in cui attori ed istituzioni diverse sono chiamati a collaborare, che da qualche anno si è imposta all’attenzione internazionale ed è propugnata anche dal fronte conservazionista (Iucn, 1996). Ma il nodo cruciale riguarda proprio il rapporto del progetto di paesaggio con i processi di pianificazione e di governo complessivo del territorio: in altri termini, il ruolo “specifico” del progetto di paesaggio. La sua “diversità”, sostenuta con convinzione da non pochi studiosi (Maniglio Calcagno, 1998), sembra trovare riconoscimento teorico nell’ampio quadro della Landscape Ecology. Ed effettivamente il confronto dei progetti di paesaggio con le correnti pratiche progettuali concernenti la città e il territorio evidenzia differenze significative, soprattutto per due aspetti chiave: il maggior peso accordato alle analisi valutative e l’importanza del lavoro interdisciplinare. Ciò giustifica le riluttanze e le perplessità nei confronti di proposte metodologiche e di impostazioni istituzionali (quali ad es. in Italia certe proposte di riforma tendenti a riassorbire totalmente in piani urbanistici e territoriali onnicomprensivi la tematica paesistica ed ambientale), in cui il progetto di paesaggio rischia di diventare “uno” dei contenuti della pianificazione urbanistica e territoriale. E tuttavia è chiaro, alla luce di tutto quanto sopra evocato, che la questione paesistica non può essere efficacemente affrontata semplicemente “affiancando” alle correnti pratiche progettuali il progetto di paesaggio, autonomamente concepito e gestito. Perché il paesaggio possa costituire davvero una “risorsa progettuale”, occorre che il paradigma paesistico fecondi, attraversandole a tutti i livelli, proprio le correnti pratiche progettuali (Dematteis, 1998). In questo senso, distinguere il progetto di paesaggio dal progetto d’architettura (latamente inteso), può essere fuorviante, può indurre a riproporre quelle visioni riduttive del paesaggio che, anche nel corso di questo Seminario, sono state ripetutamente contestate. La fecondità del paradigma paesistico, ai fini della promozione di una miglior qualità dell’abitare, non si esprime tanto nella costruzione di progetti autonomi e separati, quanto piuttosto nel confronto esplicito delle opzioni di valore, degli obbiettivi e degli interessi su cui si definiscono le strategie di trasformazione continua del territorio.
Riferimenti bibliografici
ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storico Artistici), 1990: Un contributo italiano alla riqualificazione della città esistente. Gubbio.
Anzani G., 1993: “Lo spazio sonoro”, in Anzani G., Mazzoleni D., Cilento Antico: i luoghi e l’immaginario. Electa, Napoli.
Bateson G., (1972): Verso un’ecologia della mente. Adelphi, Milano 1993.
Barthes R.,(1966): Elementi di semiologia. Linguistica e scienze della significazione. Einaudi, Torino 1983.
Barthes R., (1985): L’avventura semiologica. Einaudi, Torino 1991.
Berque A., 1993: “L’ecumene”, in Spazio e società, 64.
Berque A., 1995: Les raisons du paysage. Hazan, p.39.
Bertrand G., 1972: “La science du paysage: une science diagonale”, in Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 43, 2, pp.127-33.
Bertrand G, 1998: “L’image sociale du paysage: rationalité et irrationalité”, Convegno Valori e interpretazione del paesaggio. Istituto Italiano di Studi Filosofici, Maratea.
Calzolari V., 1999: “Il progetto del paesaggio”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Caprettini G.P., 1999: “Dal feeling allo spaesamento”, in Il senso del paesaggio, ISSU, Torino.
Cassatella C., 1998: “Il paesaggio: da testo a ipertesto”, Seminario Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Castelnovi P., 1999: “Il Senso del Paesaggio” in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Cattaneo C., 1845: “Industria e morale”, in Atti della Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri. Milano.
CE (Consiglio d’Europa), 1998: Progetto di Convenzione Europea sul Paesaggio. Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa, Strasburgo, maggio 1998.
Clarck K., (1976): Il paesaggio dell’arte. Garzanti, Milano 1985.
Conti G., 1997: “Abitare la distanza”, in Urbanistica Dossier, 9/97.
Cosgrove D., (1984): Realtà sociali e paesaggio simbolico (a cura di C.Copeta). Unicopli, Milano 1990.
Dagognet F. (a cura di), 1982: Mort du paysage? Champ Vallon, Macon.
Defoe D.,1697: An Essay upon Project. Cockerill, London.
Dematteis G., 1995: Progetto implicito, Franco Angeli, Milano.
Dematteis G., 1999: “Il senso comune del paesaggio come risorsa progettuale”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
De Rossi A., 1999: “Il lungo processo d’invenzione del paesaggio alpestre”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Eco U., 1975: Trattato di semiotica generale. Bompiani, Milano.
Eibl-Eibesfeldt, 1994: L’albero d’oro della vita. Boringhieri, Torino, pp. 289-291.
Farinelli F., 1981: “Teoria del concetto geografico di paesaggio”, in AA.VV. Paesaggio: immagine e realtà. Electa, Milano.
Farinelli F., 1991: “L’arguzia del paesaggio”, in Casabella, n. 575-576, pp. 10-12.
Gambi L., 1961: Critica ai concetti geografici di paesaggio umano, Lega, Faenza.
Gambi L.,1972: “I valori storici dei quadri ambientali”, in Storia d’Italia, Vol.I, Einaudi, Torino, pp. 5-60.
Gambi L., 1986: “La costruzione dei piani paesistici”, in Urbanistica 85/1986, pp. 102-105.
Gambino R., 1989: “Il paesaggio edificato: piani paesistici e prospettive di recupero”, in Recuperare n.40.
Gambino R., 1994a: “Ambiguità feconda del paesaggio”, in Paesaggi tra fattualità e finzione (a cura M.Quaini), Cacucci, Bari.
Gambino R., 1994b: “Luoghi e reti: nuove metafore per il piano”, in Archivio di studi urbani e regionali, pp. 11-44.
Gambino R., 1996: Progetti per l’ambiente, Franco Angeli, Milano.
Gambino R., 1997: Conservare innovare: paesaggio, ambiente, territorio. Utet, Torino.
Giacomini V., Romani V., 1982: Uomini e parchi. F.Angeli, Milano.
Giametta S., Maset S., Polese V., 1999: “Soundscape”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Gottmann J., 1970: Megalopoli. Einaudi, Torino.
Gottmann J., Muscarà C., 1991: La città prossima ventura, Laterza, Bari.
Greppi C.,1991: “Guardare con meraviglia”, in Casabella, n.575-576, pp. 18-21.
Harvey D., 1993: La crisi della modernità. Il Saggiatore, Milano.
Koestler A., 1964: The Act of Creation. Hutchinson, London.
IUCN, Unione mondiale per la natura, 1996: World Conservation Congress, Montreal.
Jellicoe G., Jellicoe S., 1987: The Landscape of Man. Thames and Hudson, London.
Joutard P., 1986: L’invenzione del Monte Bianco, Einaudi, Torino.
Lynch D., 1971: L’immagine della città., Marsilio, Padova.
Maniglio Calcagno A., 1998: relazione al Seminario Il senso del paersaggio, ISSU, Torino.
Merleau Ponty M., 1993: Il visibile e l’invisibile. Bompiani, Milano.
McHarg J.,1966: “Ecological Determinism”, in F.F.Darling, J.P.Milton: Future Environments of North America , The National History Press, Garden City, New York.
McHarg J., (1969): Progettare con la natura. Muzzio, Padova 1989.
McHarg J, 1981: “Human Ecological Planning at Pennsylvania”, Landscape Planning, 8.
Ministry of Housing (the Netherlands), 1989: Small-scale Landscapes in a Large-scale Europe. The Hague.
Mondada L., Panese F., Soderstrom O. (a cura di), 1992: Paysage et crise de la lisibilité. Université de Lausanne, Institut de Géographie.
Olmo C., 1991: “Dalla tassonomia alla traccia”, in Casabella, n. 575-576, pp. 22-24.
Pavia R., 1996: Le paure dell’urbanistica. Disagio e incertezza nel progetto della città contemporanea. Costa & Nolan, Genova.
Poli D., 1999: “Il cartografo-biografo”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Quaini M., 1992: “Alexander von Humboldt, cartografo e mitografo”, in A. von Humboldt, op. cit.
Quaini M, 1999: “Attraversare il paesaggio: un percorso metaforico nella pianificazione territoriale”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Raffestin C., 1999: “De la domestication à la simulation du paysage”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Remotti F., 1996: Contro l’identità. Laterza, Bari-Roma, p.65.
Romani V., 1994: Il paesaggio: teoria e pianificazione, Franco Angeli, Milano.
Schama S.,(1995): Paesaggio e memoria. Mondadori, Milano 1997.
Sereni E., 1961: Storia del paesaggio agrario italiano. Laterza, Bari.
Sereno P., 1983: Il paesaggio, La Nuova Italia, Roma.
Simmel G., (1912): Il volto e il ritratto. Saggi sull’arte. Il Mulino, Bologna 1985.
Socco C., 1998: Il paesaggio imperfetto. Uno sgardo semiotico sul punto di vista estetico. Tirrenia Stampatori, Torino.
Socco C., 1999: “La polisemia del paesaggio”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Steiner F., 1994: Costruire il paesaggio: un approccio ecologico alla pianificazione del territorio, McGraw Hill Italia, Milano.
Steiner F., 1999: “Landscape as idea and as a framework for human adaptation”, in Il senso del paesaggio, Ires edizioni, Torino.
Steiner F., Young G., Zube E., 1988: “Ecological planning: retrospect and prospect”, in Landscape Journal, 7/1, pp. 31-39.
Telaretti A., 1997: “L’altro e l’altrove. Frammenti di epistemologia della descrizione”, Macamé, DUPT, Firenze, n.1/97.
Tiezzi E., 1998: “Il capitale naturale tra evoluzione e conservazione”, in Oikos n.4/98, p.15-22.
Todorov T.,1990: Bachtin, il principio dialogico. Einaudi, Torino.
Tricart J., Killian J., 1985: L’ecogeografia e la pianificazione dell’ambiente naturale. Franco Angeli, Milano.
Turri E., 1998: Il paesaggio come teatro. Marsilio, Padova.
UN (United Nations), 1992: Convention on Biological Diversity, Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (Unced), Rio de Janeiro.
von Humboldt A., (1860): Comos. Saggio di una descrizione fisica del mondo. Venezia.
von Humboldt A., 1992: L’invenzione del Nuovo Mondo. Critica della conoscenza geografica. La Nuova Italia, Firenze.
Zube E.H., Sell J.L., Taylor G., 1982: “Landscape Perception: Research, Application and Theory”, in Landscape Journal 9, 1:33.